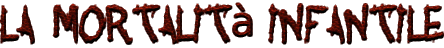
La mortalità infantile, pur essendo stata nel passato una piaga dell'
umanità, è oggi in calo.
Nei paesi più sviluppati essa è praticamente
inesistente, e nei paesi del terzo mondo la situazione sta migliorando a macchie
di leopardo con l'aiuto di associazioni umanitarie.
Tuttavia, persiste ancora.
|
|
Si parla di mortalità infantile
nel caso di coloro che muoiono entro il primo anno di vita.
Talora anche riferita a coloro che
muoiono nei primi cinque anni di vita, ma in questo caso si
parla anche di mortalità giovanile.
Cause e conseguenze
Degli oltre dieci milioni di decessi infantili che avvengono
annualmente nel
mondo, il maggior numero è dovuto a infezioni
respiratorie acute, dissenteria, morbillo e malaria. Tutte patologie che
possono essere prevenute tramite vaccini, zanzariere, misure igieniche e altre
semplici precauzioni, che però spesso rimangono
sconosciute o troppo dispendiosa per larghi strati
della popolazione, nei paesi economicamente arretrati. Lo stesso può dirsi per
le medicine che possono curare queste malattie, facilmente accessibili per
qualsiasi cittadino occidentale ma fuori portata per quei tre miliardi di
abitanti del pianeta che vivono con meno di due
dollari al giorno.
Miseria e malattie sono strettamente collegate.
E se sono universalmente note le differenze tra Nord e Sud del mondo, vanno ricordate
anche le enormi disparità all'interno dello
stesso paese, fra città e campagna, e fra quartieri della medesima città.
Un
bambino appartenente alla fascia sociale più povera della popolazione ha almeno
il doppio delle probabilità di morire in età infantile rispetto a un coetaneo
nato in una famiglia appena benestante.
Nelle regioni più povere del pianeta, solitamente localizzate in
aree rurali, semi-desertiche o montane, gli ambulatori sono rarissimi, e di regola l'unico modo per essere curati è recarvisi con mezzi
propri, anche a rischio della vita.
Il 90% dei bambini
muore a casa, senza alcuna assistenza
medica se non quella di un guaritore tradizionale, sempre che i genitori abbiano
avuto i mezzi per richiederne l'intervento.
Dove regna la povertà, lo Stato non è in grado di assicurare neppure le vaccinazioni di base. Due milioni di bambini ogni anno muoiono a causa di malattie come il morbillo o la tubercolosi, per le quali esistono vaccini dal costo irrisorio.
I vaccini sono misure sanitarie a basso costo che salvano milioni di vite
ogni anno, e la loro diffusione a livello planetario è uno dei principali mezzi
per salvare milioni di vite a minimi sforzi.
Ancora negli anni '70, soltanto un bambino su dieci
nel mondo era regolarmente vaccinato contro le principali malattie mortali
(poliomielite, morbillo, tubercolosi, difterite, tetano e pertosse) per le quali
esisteva una simile protezione. Oggi la copertura vaccinale globale
è prossima all'80%, un successo che si
misura anche con il numero di vite salvate grazie alle campagne di
immunizzazione: circa 20 milioni negli ultimi due
decenni.
|
|
Vaccini di nuova generazione, più efficaci di quelli tradizionali e in grado di
colpire infezioni che fino a pochi anni fa non potevano essere prevenute,
offrono motivi di ancora maggiori speranze per il futuro.
Eppure, nonostante questi immensi progressi, ogni
anno due milioni di bambini continuano a morire a causa di banali
malattie, per le quali esiste un vaccino che costerebbe pochi centesimi di euro.
La carenza di servizi sanitari di base è
rafforzata dalla mancanza di informazioni.
Spesso le comunità e le famiglie ignorano l'importanza vitale delle
vaccinazioni, non sanno riconoscere i sintomi delle malattie e neppure quando
sia giunto il momento di cercare un medico per un bambino che sta male. Per
combattere queste forme di ignoranza sanitaria,
si rivela fondamentale l'istruzione delle donne
e delle future madri.
Una ragazza che ha frequentato qualche anno di scuola è in grado di
assistere e nutrire meglio il suo bambino,
sa leggere le istruzioni di un operatore sanitario e dosare un farmaco come una
donna analfabeta non può fare (basti pensare alle decine di migliaia di bambini
che ogni anno muoiono perché le madri diluiscono troppo le medicine o il latte
in polvere). L'umanità non ha mai visto andare a scuola un numero di bambini così alto quanto
oggi, in termini sia assoluti che percentuali, nel corso della sua storia.
Eppure, un'istruzione di qualità accettabile rimane un sogno ancora per troppi
bambini nel mondo. Sono oltre 120 milioni i
bambini ai quali è negato il fondamentale diritto all'istruzione di base, e in
oltre metà dei casi si tratta di bambine.
Avere accesso alla scuola primaria è molto più che imparare a leggere, scrivere
e far di conto. In un paese a basso reddito e con alti tassi di incremento
demografico, le nuove generazioni rappresentano la
ricchezza più importante e la migliore speranza di spezzare la catena
che collega ignoranza, povertà, sfruttamento e sottosviluppo.
|
|
In una
scuola a misura di bambino i più
giovani apprendono, oltre alle nozioni basilari che li salvano
dall'analfabetismo, competenze e comportamenti che serviranno loro nel corso di
tutta la loro esistenza.
La storia insegna che nessuna società è mai uscita dal sottosviluppo senza un
cospicuo investimento nel proprio capitale umano.
Per questo l'istruzione è considerato un diritto umano fondamentale e uno dei
più importanti fra gli otto Obiettivi di Sviluppo
del Millennio sanciti nel 2000 dall'Assemblea Generale dell'ONU.
Garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine la possibilità di frequentare
per intero almeno il ciclo dell'istruzione primaria
e di ricevere insegnamenti di qualità è il modo più efficace per conseguire
anche gli altri traguardi del terzo millennio, quali l'eliminazione della fame,
della povertà e degli ostacoli che frenano uno sviluppo umano sostenibile per
tutti gli abitanti del pianeta, inclusa la pandemia da HIV/AIDS.
La principale causa dell'esclusione scolastica delle
bambine è la discriminazione
di genere.
Sia i maschi che le femmine devono spesso superare
ostacoli nell'accesso all'istruzione: tuttavia, di
norma, e a parità di altri fattori, gli ostacoli che
incontra una bambina sono
più frequenti e penalizzanti.
E questo per il solo fatto di essere nata femmina!
Queste sono le più frequenti tipologie di cause alla
base del divario fra maschi e femmine nelle scuole di
molti Paesi in via di sviluppo.
Per una famiglia a basso reddito, ogni figlio che va a scuola è
al tempo stesso una fonte di reddito sottratta al bilancio
familiare e un aiuto in meno per le incombenze domestiche.
Quando poi la scuola diventa un costo netto, per via delle
tasse di iscrizione o delle
spese per i libri, l'uniforme o i pasti, è facile che una
famiglia debba scegliere quali figli debbano continuare a
studiare e quali no. Di fronte alla scelta di mandare a scuola
il fratello o la sorella, è probabile che i genitori dedichino
le scarse risorse disponibili all'istruzione del figlio maschio,
convinti che questo sia l'unico investimento che renda a lungo
termine.
Le bambine sono sfavorite anche da circostanze esterne al mondo della scuola,
ma che possono avere come effetto la loro esclusione dal diritto all'istruzione.
Ad esempio, la mancata registrazione anagrafica
alla nascita si traduce spesso in una successiva impossibilità di essere ammessi
nel sistema educativo nazionale. E le bambine costituiscono la maggior parte dei
circa 50 milioni di esseri umani afflitti da questa condizione di "inesistenza
legale".
|
|
Matrimoni e gravidanze precoci
costringono ogni anno centinaia di migliaia di
adolescenti, spesso poco più che bambine, a rinchiudersi in
casa o ad abbandonare gli studi. Per loro, la condanna
all'analfabetismo si somma al peso di una sottomissione
quotidiana al marito e alla sua famiglia.
Ad aggravare la situazione di queste ragazze vi sono a volte
leggi arretrate che vietano a una ragazza che ha dato alla
luce un figlio di tornare a frequentare la scuola.
Fra le ragioni per cui la famiglia può preferire che una
bambina non vada a scuola vi sono anche preoccupazioni per
la sua sicurezza o per
l'onorabilità familiare.
Se il tragitto dal villaggio all'aula è ritenuto troppo
lungo o esposto a pericoli, se a scuola si verificano
fenomeni di bullismo o
punizioni corporali
degli allievi, ma anche se mancano insegnanti donne o
servizi igienici separati, i genitori - soprattutto se di
cultura tradizionalista - tendono a ritirare le figlie da
scuola.
Ancora maggiori sono le barriere che possono ostacolare
l'istruzione femminile in situazioni di emergenza, come
quelle che si verificano nelle zone teatro di un
conflitto o nei
campi profughi.
In questi casi, la forzata promiscuità e, non di rado,
l'assenza di un efficace controllo dell'ordine pubblico,
possono rendere le più giovani facili prede di abusi e
violenze. In un simile clima, è probabile che le bambine
siano tenute segregate e private dell'ambiente educativo e
ricreativo, da tutti gli esperti riconosciuto come il più
prezioso dei rimedi contro il trauma psicologico e lo stress
emotivo.
Una scuola di scarsa qualità può indurre all'abbandono i suoi
allievi in maniera indifferenziata, ma se l'insegnamento è
ispirato a teorie discriminatorie e
sessiste, saranno le bambine ad essere spinte verso la
dispersione scolastica.
Ciò accade quando i maestri applicano norme punitive o
derisorie nei confronti delle bambine, quando i testi di studio
abbondano di stereotipi sui ruoli
dei maschi e delle femmine o semplicemente ignorano gli
interessi culturali e sociali delle alunne.
L'ambiente scolastico può acuire questi problemi, ad esempio
quando si addossano alle allieve le pulizie dei locali o altri
compiti di manutenzione a scapito del tempo dedicato alle
lezioni.
Non è azzardato sottolineare infine che le ragazze, ancor più
dei loro coetanei, nutrono grandi
aspettative formative negli anni dell'istruzione di
base, se non altro perché sanno che poche di loro avranno la
possibilità di frequentare anche la scuola secondaria. Quando
vanno deluse le loro speranze di acquisire competenze utili per
la vita adulta, le allieve non vedono più il motivo di resistere
alle pressioni familiari e sociali che le vogliono
esclusivamente dedite alla casa e alla famiglia.
Fra le minacce alla salute dei bambini, occupa una posizione
sempre più rilevante l'HIV/AIDS.
Oltre ai tre milioni di bambini e ragazzi
sotto i 15 anni che convivono con il virus, in massima parte a causa del
contagio da parte materna alla prima o durante la nascita, vanno considerati i
moltissimi altri la cui vita è stata indirettamente segnata dall'AIDS.
Per
coloro che accudiscono familiari malati, e soprattutto per i 15 milioni di
orfani, la capacità di tutelare il proprio stato di salute dipende
esclusivamente dalla benevolenza di parenti, per lo più anziani e in difficoltà
economiche, o dai rarissimi programmi assistenziali dello Stato. Quando
il virus (HIV) dell'AIDS fece la sua comparsa, poco più di due decenni fa, si
pensava che i giovani fossero relativamente al sicuro dalla malattia.
Oggi
la diffusione dell'HIV/AIDS ha preso le dimensioni di una epidemia globale (pandemia)
e oltre metà dei nuovi casi di infezione che avvengono nel mondo colpiscono
persone con meno di 25 anni.
Nei Paesi in cui il virus è più diffuso, gli
effetti dell'HIV/AIDS sulle nuove generazioni è devastante.
L'età media
delle persone infette o malate è sempre più bassa: le ragazze, più indifese
rispetto al virus per ragioni fisiologiche e per condizionamenti sociali, pagano
un tributo alla malattia ancora più alto rispetto ai coetanei maschi.
I
tassi di mortalità infantile crescono a causa della trasmissione del virus da
madre a figlio, mentre il numero dei bambini rimasti orfani a causa della
malattia è salito a oltre 15 milioni.
L'HIV/AIDS è una malattia spietata,
per la quale non esiste un vaccino o una cura in grado di debellare il virus
dall'organismo malato, ma può essere combattuta con le terapie che ne bloccano
il decorso e soprattutto con la prevenzione.
Purtroppo, da quando
l'Occidente ha imparato a proteggersi efficacemente dal virus, sembra avere
dimenticato il resto del mondo, che non avendo i mezzi per imitarne il successo,
vede l'epidemia espandersi di anno in anno.
Oggi l'AIDS è la prima causa di
morte in Africa, il continente in cui vivono tre quarti dei sieropositivi e dei
malati di AIDS, e il 90% degli orfani per AIDS di tutto il pianeta.
|
|
L'HIV/AIDS sta provocando un terribile carico di sofferenze per l'intera
umanità, facendo più vittime di tutte le guerre in corso e riportando molti
Stati indietro di decenni lungo il sentiero dello sviluppo.
Attualmente l'HIV/AIDS è la quarta causa di mortalità a livello planetario, e la
prima in assoluto nel continente africano. Dai primi casi individuati alla fine
degli anni Settanta a oggi, oltre 23 milioni di persone sono morte per colpa
della malattia, e le stime prevedono che questa cifra raddoppierà di qui al
2010.
A quell'epoca, se non vi sarà stata un'efficace azione della comunità
internazionale, negli Stati più colpiti dall'epidemia si avranno tassi di
mortalità infantile due volte più alti rispetto a quelli odierni e i sistemi
educativi e sanitari saranno ridotti allo stremo.
L'HIV/AIDS è una malattia dal volto sempre più giovane. Sin dal 2002, almeno
metà dei 5 milioni di nuovi casi di infezione che si verificano ogni anno nel
mondo riguardano persone con età inferiore a 25 anni. Una persona sieropositiva
su tre ha meno di 25 anni, e fra i giovani sieropositivi due terzi sono ragazze,
segno di una loro sproporzionata vulnerabilità.
Si contano attualmente nel mondo 15 milioni di bambini e ragazzi resi orfani di
uno o entrambi i genitori dall'AIDS, per nove decimi concentrati nell'Africa
subsahariana. Il loro numero potrebbe salire a 25 milioni di qui al 2010.
Ogni giorno quasi 2.000 bambini nascono sieropositivi per contagio da parte
materna durante la gravidanza, il parto o l'allattamento al seno.
Le statistiche attuali e gli scenari futuri appaiono spaventosi, ma questa
tendenza al peggioramento può ancora essere vinta, con un impegno deciso e
concertato da parte della comunità internazionale.
Mentre prosegue la difficile ricerca di un vaccino, si possono salvare milioni
di vite con la prevenzione della trasmissione madre-figlio del virus, estendendo
l'accesso ai farmaci e ai test per l'HIV, potenziando i servizi sanitari di base
e diffondendo messaggi di prevenzione fra i giovani.
Al tempo stesso, si possono alleviare ingiuste sofferenze garantendo assistenza
ai bambini rimasti orfani, combattendo la discriminazione nei confronti delle
persone malate e sostenendo economicamente le comunità più duramente colpite.
La diffusione dell'HIV/AIDS
non è più limitata all'Africa subsahariana,
come siamo stati abituati a pensare nel corso degli anni
Novanta.
In quest'ultimo periodo della nostra storia, l'epidemia
si è espansa in tutte le aree del mondo in via di
sviluppo, con tassi di diffusione particolarmente
allarmanti in America Centrale, nei Caraibi, in Europa
orientale e in alcune regioni asiatiche.
Al contrario, in Europa, America settentrionale e negli
altri paesi ad alto reddito
l'epidemia
è stata contenuta grazie ai
progressi della ricerca farmaceutica e all'efficienza
dei servizi di monitoraggio e prevenzione.
Qui il pericolo principale è rappresentato da un
abbassamento della guardia
che potrebbe facilitare il ritorno in auge di
comportamenti a rischio, soprattutto fra i giovani che
non beneficiassero di un'efficace azione di informazione
e sensibilizzazione.
|
|
Per definire il grado di diffusione dell'infezione si
ricorre ai termini di "epidemia
bassa" o "concentrata", e di "epidemia
generalizzata", o "pandemia".
Nella maggior parte dei paesi, la diffusione dell'HIV/AIDS è
confinata all'interno dei cosiddetti "gruppi
a rischio", ossia categorie di soggetti che
praticano comportamenti che favoriscono il contagio:
omosessuali maschi, tossicodipendenti che fanno uso di
droghe iniettabili, persone coinvolte nel mercato del sesso.
Un'epidemia di HIV/AIDS è concentrata quando coinvolge meno
dell'1% della popolazione complessiva ma
almeno il 5% dei membri di uno
dei gruppi a rischio.
L'epidemia è invece di tipo generalizzato quando ad essere
colpito è oltre l'1% degli
abitanti di uno Stato e il virus si diffonde
trasversalmente fra i gruppi a rischio e il resto della
popolazione. È questo il caso di gran parte dei paesi
dell'Africa e di altri continenti del Sud del mondo.
È tuttora la regione maggiormente colpita dalla pandemia di
HIV/AIDS: qui vivono 30 milioni di soggetti portatori di HIV
(pari a tre quarti dei
sieropositivi del mondo) e addirittura il
90% dei bambini infetti dal
virus. In questa parte del mondo l'AIDS è
rapidamente divenuta a prima causa di morte, superando in
negativo mali atavici come la malaria o la tubercolosi.
In 12 Stati africani il tasso di diffusione del virus nella
popolazione adulta (15-49 anni)
supera il 10%, ossia dieci volte la soglia oltre la
quale l'epidemia si considera generalizzata.
La tragedia assume proporzioni spaventose in alcuni paesi
dell'Africa australe, come il
Botswana o lo Swaziland,
dove un adulto su tre ha già contratto il virus e gli
epidemiologi stimano che per un quindicenne di oggi vi siano
più probabilità (60%) di ammalarsi che non di arrivare sano
all'età adulta.
|
|
L'epidemia è considerata di tipo generalizzato in
Cambogia, Thailandia e Myanmar,
mentre in Indonesia, Nepal e Vietnam i tassi di diffusione
fra i giovani inducono a prevedere scenari analoghi nel giro
di pochissimi anni.
Massimo allarme destano però i due giganti del continente,
Cina e India, dove si
concentra un quarto della popolazione mondiale e dunque
anche un lieve aumento del tasso di diffusione si
tradurrebbe in milioni di contagi. In numerose province
cinesi si è già raggiunto un livello di epidemia
concentrata, nonostante il tentativo del governo di Pechino
di minimizzare le dimensioni del
fenomeno.
In questi ultimi anni, i territori dell'ex Unione Sovietica
e dell'Europa orientale fanno registrare tassi di diffusione
dell'HIV/AIDS più rapidi di
qualsiasi altra area del mondo, Africa inclusa.
Ciò avviene a causa del collasso economico e sociale di
queste realtà, dove una liberalizzazione selvaggia ha
gettato nella miseria larghi strati della popolazione e la
qualità dei servizi sanitari di base è precipitata a livelli
da Terzo Mondo o ha raggiunto costi inarrivabili per la
maggior parte della popolazione.
Il numero dei sieropositivi in questa regione è prossimo ai
due milioni, e sebbene
l'infezione riguardi ancora in massima parte i gruppi a
rischio (tossicodipendenti in primo luogo), il contagio per
via sessuale sta dando all'epidemia un carattere quasi
generalizzato.
L'età delle persone contagiate è
sorprendentemente bassa: in Russia, ogni anno
contraggono il virus migliaia di teen-ager del tutto ignari
delle più elementari norme di prevenzione
Anche qui l'epidemia è prossima ad assumere carattere
generalizzato, in verità già raggiunto
nell'area caraibica con
un tasso di prevalenza dell'HIV/AIDS del 2,3% fra gli adulti
- il più alto al mondo dopo
l'Africa.
La modalità prevalente del contagio è stata finora quella
dei rapporti omosessuali fra maschi, ma negli ultimi tempi
il fatto che il maggior numero dei nuovi casi di infezione
riguardi giovani donne fa ritenere che il virus abbia ormai
valicato il confine dei gruppi a rischio.
È la regione di cui si hanno i
dati più incerti. Gli esperti indicano epidemie
concentrate nel gruppo a rischio dei tossicodipendenti in
metà dei paesi del Maghreb e del Medio Oriente, Iran
incluso.
La modalità di trasmissione sessuale del virus è
probabilmente rallentata da influenze
culturali e religiose.
Da sempre la guerra è nemica giurata
dell'infanzia, poiché con il suo carico di lutti e distruzioni
interrompe tragicamente l'età in cui un essere umano ha un bisogno assoluto
dell'affetto e della protezione da parte del mondo adulto.
Ma se per secoli le guerre avevano la forma di scontri fra soldati, con i
civili nel ruolo di spettatori e vittime occasionali, quelle della nostra epoca
sono quasi esclusivamente stragi di persone inermi.
|
|
Dal secondo conflitto mondiale in poi, oltre il 90%
dei caduti nelle guerre sono civili, in metà dei casi bambini. Questi
sono gli effetti dei conflitti moderni, i cui teatri non sono più trincee o
campi di battaglia, bensì città, villaggi, scuole e ospedali.
E ciò non a caso, poiché l'obiettivo non è quasi mai quello di conquistare un
territorio, ma di distruggere un nemico: i
ribelli che ricercano l'indipendenza, i seguaci di un'altra fede, la minoranza
che impedisce la purezza etnica della nazione.
Accade così che le donne e i bambini non
siano più soggetti neutrali, degni della massima tutela, ma
obiettivi bellici in piena regola.
Lo stupro etnico è una nuova arma di
guerra, escogitata per punire e umiliare l'avversario impedendo la riproduzione
del "nemico", mentre lo sterminio di bambini e ragazzi è un freddo calcolo
militare - l'eliminazione dei nemici di domani.
Anche arruolare ragazzini per combattere
ed eventualmente fare strage di altri bambini non è che la coerente conseguenza
di questo folle ragionamento.
L'acqua è un diritto irrinunciabile, per ogni
essere umano. Senza acqua non sopravviverebbe la specie umana né alcuna
forma di vita evoluta sul nostro pianeta.
Ma l'acqua sta diventando un bene sempre più scarso,
per la cattiva gestione che se ne fa.
Nei paesi a basso reddito, 500 milioni di bambini
(uno su tre) non hanno accesso a servizi igienici degni di questo nome, e
un bambino su cinque non usufruisce nemmeno di
fonti di acqua potabile.
L'importanza dell'elemento idrico è tale da avere assunto carattere
strategico, al pari - e in prospettiva, anche più - del petrolio. Nelle aree
semiaride del pianeta già si consumano conflitti
più o meno direttamente legati al controllo delle fonti
idriche.
L'acqua è dunque anche un bene su cui si fonderà, in un futuro sempre più
prossimo, la tutela della pace e della sicurezza globale.
Il settimo degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio,
sottoscritti nel 2000 dalla più vasta assemblea di Capi di Stato e di
governo della storia, pone come traguardo per il 2015 il dimezzamento nel
numero di abitanti del pianeta senza accesso all'acqua potabile e a servizi
igienici adeguati, nonché l'installazione entro la medesima data di
infrastrutture igieniche in tutte le scuole del mondo.
Questi traguardi sono stati successivamente ribaditi in sedi internazionali
della massima rilevanza, come il Vertice mondiale sullo
sviluppo sostenibile (Johannesburg, settembre 2002), la
Sessione speciale delle Nazioni Unite sull'infanzia
(maggio 2002) e il terzo Forum mondiale sull'acqua
(marzo 2003). Un grande impulso verso il conseguimento dell'Obiettivo del
Millennio 7 è atteso nel 2008,
proclamato dall'ONU "Anno internazionale per i
servizi igienici": un anno denso di appuntamenti ad alto livello,
per aumentare la consapevolezza e la mobilitazione di risorse economiche al
fine di assicurare l'accesso a servizi igienici adeguati al 40% della
popolazione mondiale (2,6 miliardi di persone) che ne è ancora privo.
Milioni di bambini nei Paesi a basso reddito soffrono e muoiono ogni anno a
causa della scarsità di igiene e di acqua potabile.
|
|
Tutte le malattie veicolate dall'acqua infetta e dalla mancanza di latrine
e fognature potrebbero essere prevenute, come da
tempo accade in Occidente, se soltanto la comunità internazionale accettasse
di estendere a tutti gli abitanti del pianeta l'elementare diritto all'acqua
e all'igiene, e di investire a tal fine i fondi necessari.
I bambini, a causa della fragilità dell'organismo in fase di sviluppo e
delle imperfette difese immunitarie, sono di gran
lunga i soggetti più vulnerabili di fronte al nemico invisibile
rappresentato da virus e batteri.
La sola diarrea - un banale disagio transitorio,
per chi ha facile accesso ai farmaci e alle cure pediatriche -
uccide ogni anno 1,8 milioni di bambini nel Sud
del mondo. Nelle realtà meno sviluppate, un bambino ha in media 4-5 episodi
di dissenteria l'anno, che in mancanza di cure tempestive possono condurre a
una disidratazione letale, ma che lasciano
comunque tracce a volte indelebili nel fisico.
Ad esempio, ricorrenti crisi diarroiche indeboliscono il sistema
immunitario del bambino, esponendolo a un elevato rischio di mortalità per
malattie "opportunistiche", come le infezioni
dell'apparato respiratorio.
L'acqua infetta e stagnante è anche un mezzo di trasmissione di altre
malattie mortali, come il colera, la malaria (in
quanto favorisce la proliferazione della zanzara anofele) e infezioni
intestinali di origine parassitaria come la
schistosomiasi, il tracoma o il verme di Guinea, che affliggono
400 milioni di bambini in età scolare ogni anno.
I parassiti intestinali sottraggono nutrimento
all'organismo, aggravando lo stato latente di malnutrizione e rallentando lo
sviluppo e le capacità di apprendimento del bambino
Ancora più grave è il pericolo di infezioni che si cela nei luoghi in cui
tutta la popolazione di una comunità si reca per defecare o gettare rifiuti
organici, quando mancano infrastrutture come gabinetti,
fognature e discariche.
Ai danni provocati dagli agenti patogeni naturali si aggiungono,
sempre più numerosi, quelli legati all'inquinamento delle
sorgenti e dei bacini acquiferi per mano dell'uomo.
Soprattutto in Cina e nel subcontinente indiano, il tumultuoso processo di
industrializzazione sta producendo un rapido degrado nella qualità
dell'acqua e dell'aria, senza che siano stati predisposti efficaci
meccanismi di tutela ambientale.
La malnutrizione è una
emergenza invisibile. Proprio come in
un iceberg, la sua minaccia reale giace non
vista, sotto la superficie.
Ogni anno essa incide all'incirca per il
40% della mortalità infantile
globale (pari a 10,6 milioni
di decessi annui fra i bambini da 0 a 5
anni), cifra alla quale vanno aggiunti un
milione e mezzo di
morti per conseguenze legate al mancato
allattamento al seno.
A differenza di quanto ritiene la maggioranza
delle persone, solamente una
piccola frazione delle morti per
malnutrizione consiste in vere e proprie morti
per fame, a seguito di eventi catastrofici come
una carestia o una guerra.
Nella assoluta preponderanza dei casi, la
malnutrizione colpisce
lentamente e silenziosamente,
rallentando lo sviluppo fisico e intellettivo
del bambino, provocando ritardi permanenti e
infine erodendo la capacità dell'organismo di
reagire con successo alle infezioni e alle
malattie.
Dietro la morte di un bambino per dissenteria o
polmonite, c'è spesso una storia di
malnutrizione trascurata.
|
|
La malnutrizione non va confusa
con la mera scarsità di cibo (denutrizione), ma è la
combinazione di vari fattori:
insufficienza di proteine, zuccheri e
micronutrienti,
frequenza di malattie e infezioni, ignoranza alimentare,
consumo di acqua non potabile, carenza di controlli
medici e scarsità di igiene.
La malnutrizione produce effetti devastanti già durante
la gestazione, allorché impedisce lo sviluppo regolare
del feto, e nei primi anni di vita del bambino.
In generale, si stima che
300 milioni
di bambini soffrano qualche forma di
malnutrizione. Vi sono tuttavia diverse forme di
malnutrizione infantile, e un bambino può soffrire anche
di più di esse simultaneamente.
Nel Sud del mondo, un neonato su sei è
sotto peso (meno di 2,5 kg. alla nascita). Con
il passare dell'età, un numero sempre maggiore di
soggetti ricade in questa anomala condizione:
attualmente, nei paesi poveri, 150
milioni di bambini tra 0 e 5 anni fanno
registrare un peso moderatamente o gravemente inferiore
a quello previsto per la loro età.
Ancora di più (171 milioni)
sono quelli che soffrono di deperimento e ritardi cronici nella crescita a
causa di una dieta povera.
E oltre il 60% dei bambini non è
allattato esclusivamente al seno nei primi 6
mesi di vita.
L'allattamento naturale è la prima fonte di
approvvigionamento di micronutrienti e altri fattori
della crescita: nessun alimento può
competere con il latte materno quanto a
proprietà nutritive, potere immunizzante e proprietà
benefiche per l'equilibrio psicofisico del nuovo nato.
Si calcola che ogni anno 1,5 milioni di bambini
soccombano per effetto del mancato o insufficiente
allattamento al seno, e per le conseguenze nefaste di
uno scorretto allattamento con surrogati del latte
materno.
|
|
L'infanticidio femminile
L'infanticidio femminile consiste nell'uccisione (solitamente via
annegamento) delle neonate femmine. Usanza tradizionale cinese, la tendenza a
questi omicidi è alimentata da innumerevoli motivi che convincono le coppie a
avere un figlio, o al massimo due.
Le ragioni che spingono a preferire un neonato maschio piuttosto di una femmina
sono di diversa natura: l'individuo maschile potrebbe aiutare nel lavoro nei
campi, sarebbero sostentamento per i genitori diventati anziani, e soprattutto
garantirebbero il perpetuare del nome di famiglia, mentre le donne, una volta
sposate, assumerebbero il cognome del marito.
Soprattutto quest'ultimo motivo è di particolare rilevanza nei paesi dove vige
il culto degli antenati; inoltre, l'avere una figlia femmina porta con sè anche
il bisogno di trovare una dote per maritarla.
Associazioni che
contribuiscono a fermare la mortalità infantile
La speranza per fermare questo dramma è rappresentato da
numerose associazioni umanitarie dedite alla salvaguardia dei
bambini: Save the Children, Amnesty International, Emergency, e
L'UNICEF(Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia), la
principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e
delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza.
|
|
Fondato nel 1946 su decisione dell'Assemblea
Generale dell'ONU, l'UNICEF opera attualmente in 156 Paesi in via di
sviluppo attraverso 126 uffici permanenti sul campo (Country
Offices) e in 36 Paesi economicamente avanzati tramite una rete di
Comitati Nazionali.
La missione dell'UNICEF è di mobilitare in tutto
il mondo risorse, consenso e impegno al fine di contribuire al
soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni
bambino, ragazzo e adolescente.
L'UNICEF esplica la propria azione
attraverso programmi e progetti di sviluppo umano concordati e
realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle
organizzazioni e associazioni locali, nel totale rispetto delle
diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono
svantaggiati per ragioni legate al sesso, alla condizione sociale,
all'appartenenza etnica o religiosa.
La Convenzione Internazionale
sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata
finora da 193 Stati, è il quadro di riferimento della nostra
organizzazione, caratterizzata da un approccio centrato sui diritti e da
una strategia volta a dare ad essi concreta realizzazione in tutte le
fasi dello sviluppo della persona e in tutte le circostanze, situazioni
di emergenza comprese.
Inoltre celebrità internazionali molto spesso
si abilitano a combattere questo problema, con concerti gratuiti contro
le principali cause.
|
|