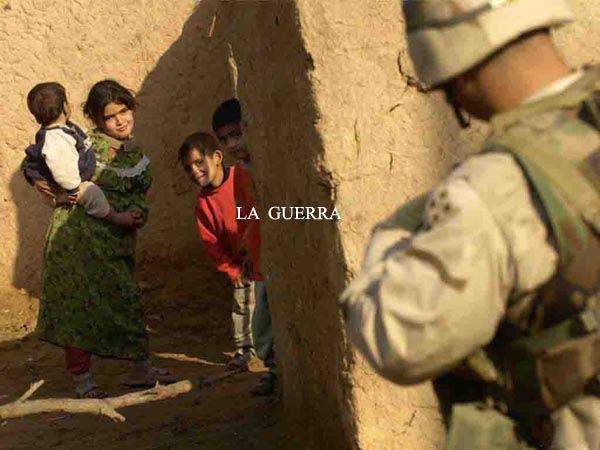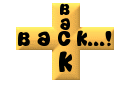La povertà è causata da un insieme di fattori che riducono la speranza di
vita e la felicità della popolazione nei paesi del Terzo mondo. Le cause principale di cui vorremmo parlarvi
sono la fame, la guerra e la conseguenza più ovvia,ovvero l'emigrazione nei paesi
ricchi.
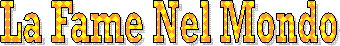
Contrariamente alle numerosi
affermazioni di principio e dalle altrettanto molteplici dichiarazioni di
intenti da parte dei Paesi ricchi del pianeta, la fame continua a rappresentare
una quotidiana emergenza mondiale. Ogni anno si valuta che circa 9 milioni
di persone (in buona parte bambini) muoiano appunto di fame e di malattie di
denutrizione. Circa 500 milioni di persone (pari a un decimo dell'umanità)
sopravvivono dunque in condizione di fame cronica. Alcune conseguenze di questo
fatto sono appunto le malattie e la malnutrizione che ostacola la crescita
normale dei bambini, lo sviluppo fisico-mentale e le capacità lavorative.
Inoltre le siccità molto frequenti e le inondazioni dei grandi fiumi asiatici si trasformano spesso in drammatiche carestie.
La malnutrizione,come già detto prima, è una delle principali cause della
nascita di bambini con insufficienza di peso e con crescita ritardata. I bambini
con insufficienza di peso alla nascita che sopravvivono, tendono a soffrire di
ritardi nella crescita e di malattie durante l'infanzia, l'adolescenza e fino
alla maggiore età. Le donne adulte che soffrono di crescita ritardata tendono
verosimilmente ad incrementare il cerchio vizioso della malnutrizione partorendo
bambini con peso insufficiente già alla nascita.

Bambino che cerca l'acqua nel deserto,Kenia |
Stanno anche emergendo dei legami tra malnutrizione nella prima età, compreso lo
stato fetale, e lo sviluppo di successive malattie croniche come la cardiopatia,
il diabete e l'ipertensione. Ogni anno, nei Paesi in via di sviluppo, circa 30
milioni di bambini nascono con crescita menomata a causa della
malnutrizione
durante la gravidanza. I paesi ricchi hanno contribuito a rendere questo grave
problema meno drastico, fornendo aiuti alimentari in caso di carestia o altre
situazioni di emergenza; assistenza sanitaria; finanziamento di progetti di
sviluppo e l'assistenza tecnica. Per questo motivo si può affermare che nel
mondo ricco vi sia un'inevitabile interdipendenza, e che il benessere in questi
paesi non possa a lungo coesistere con la povertà di una parte cospicua del
Terzo mondo. Un altro problema che contribuisce alla malnutrizione è la mancanza di una
risorsa fondamentale per la sopravvivenza: l'acqua. Quest'ultima risorsa,
essendo in quantità minima, non permette la sopravvivenza di animale e vegetali
ma soprattutto dell'uomo. Queste brevi considerazione possono
affermare che questo problema è da attribuire principalmente al comportamento
dell'uomo e non all'ambiente naturale. Infatti oggi i popoli ricchi,
specie in Europa, Nord America e Giappone, se ne stanno "appollaiati" in cima a
questa catena alimentare divorando il patrimonio dell'intero pianeta. Alcune
cause per le quali si determinano e si aggravano le disuguaglianze tra paesi
ricchi e paesi poveri, sono due. In primo luogo sulla speculazione sui prezzi
degli alimenti di prima necessità condotta da un "manipolo
di banchieri" che
controllano il mercato mondiale dei prodotti alimentari per mezzo della Borsa di
Chicago. Conseguenza di tale speculazione sono:
- l'incapacità dei paesi poveri di
acquistare generi alimentari per l'alto prezzo di vendita;
- la necessità per gli stessi paesi
di abbandonare le tradizionali colture agricole per dedicarsi a monocolture
che possano trovare uno sbocco commerciale;
- in definitiva, la totale
dipendenza delle popolazioni che soffrono la fame dalle decisioni del
predetto gruppo di banchieri che hanno come unico obbiettivo la pura e
semplice massimizzazione del profitto.
Viene da chiedersi perché succede tutto
questo in un mondo in cui essendo la torta più grande rispetto al passato le sue
porzioni non sono tali da garantire che chi ha più bisogno di cibo lo ottenga. La fame purtroppo continua ad essere la condizione quotidiana in cui
versano centinaia di milioni di persone nel nostro pianeta. Oggi si calcola che
muoiano nel mondo circa 40 milioni di persone per cause legate alla fame o alla
sottoalimentazione e malnutrizione. Concludendo vorremmo mostrarvi la mappa della fame che persiste nel mondo:
La mappa
della fame nel mondo
Le proporzioni delle persone sottonutrite

Africa
Asia
Europa
Nord-centro
America
Oceania
Sud
America
|
Da questa mappa possiamo vedere come l'Africa sia il
continente con il livello di popolazione denutrita maggiore.
La zona in cui si condensa il problema è l'area centro-meridionale africana,
seguita dal Madagascar e dal cuore dell' Asia, dove più del 35% delle persone è
malnutrito o con problemi alimentari. Nell' America settentrionale, Europa e
Oceania invece il problema è quasi assente, poiché la proporzione di popolazione
denutrita è inferiore al 5%.

Non so con quali armi si combatterà
la terza guerra mondiale, ma la quarta sicuramente con le pietre.
Albert Einstein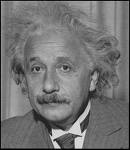 (Fisico e Filosofo)
(Fisico e Filosofo)
Quando si dichiara una guerra la
prima vittima è la verità.
Arthur
Ponsonby (Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)
(Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)
La guerra è un evento sociopolitico che consiste
nel confronto tra due o più soggetti. Il termine "guerra" deriva
dalla parola "gwarra" dell'antico alto tedesco, che significa mischia. Nonostante la storia dell'uomo sia millenaria, l'umanità non sembra aver
attraversato nessun periodo prolungato senza guerre. Questo ci dovrebbe fare
riflettere... Infatti la guerra, con i suoi orrori e le sue crudeltà, sembra appartenere al patrimonio
genetico della specie umana. È un poema sulla guerra, quella fra Greci e Troiani, il primo grande libro della
civiltà occidentale, l'Iliade e anche oggi, che abbiamo ormai superato il terzo
millennio, la guerra divampa in varie parti del globo, guerre fra nazioni, ma
anche guerre civili, interne ai singoli stati. Infatti oggi ci sono sette stati
che hanno, dichiaratamente, armi nucleari (USA, Russia, Cina,
Regno Unito, Francia) che sono i cinque stati che occupano i seggi
permanenti del consiglio di sicurezza ONU , più India e Pakistan. Alcuni paesi vengono ufficialmente
definiti "in disarmo nucleare", perchè affermano di aver rinunciato
volontariamente a portare avanti un programma per la realizzazione dell'atomica.
Sono: Brasile, Argentina, Sudafrica, Algeria, Taiwan, Corea del Sud, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan (questi ultimi tre paesi sono divenuti indipendenti dopo
la dissoluzione dell'Unione Sovietica, e ne avevano in parte ereditato
l'armamento). Ci sono infine paesi fortemente sospettati di possedere l'atomica
(Isrlaele) o di aver in atto dei progetti, più o meno avanzati per realizzarla.
L' Iraq era stato a lungo sospettato di aver accumulato armi di distruzione di
massa (Atomiche,chimiche e battereologiche), e questa è stata una delle ragioni
invocate dagli Stati Uniti e dalla coalizione da essi formata per la guerra
della primavera 2003. Dopo la fine della guerra, si sono trovate solo poche
tracce di questi tipi di armi (e nessuna di armi atomiche), anche se è
innegabile che il dittatore Saddam Hussein ne avesse progettato (e in parte
avviato) lo sviluppo in anni precedenti (certamente dopo aver usato i gas contro
gli iraniani nella guerra del 1980-'89 e contro i villaggi curdi in più
occasioni tra il 1988 e il 1991)
|
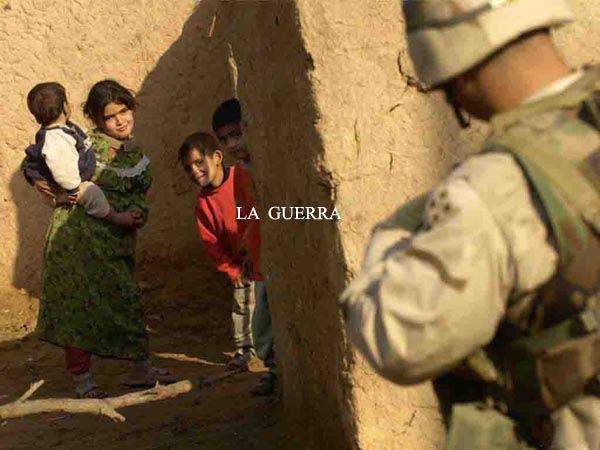
Soldato americano con bambini che giocano
|
Eppure l'aspirazione alla pace fa ugualmente parte dei sogni dell'uomo, tanto
che il massimo filosofo della modernità, Immanuel Kant, dedicò un volumetto
importante allo studio delle condizioni che avrebbero condotto alla pace
perpetua. Perché allora l'uomo vuole il bene e fa il male? Perché la storia umana è un
succedersi ininterrotto di atrocità, un "immenso mattatoio", secondo la
definizione datane da Hegel nella sua Filosofia della storia? Perché la guerra?
Freud rispose a quest'ultima domanda affermando che nell'uomo c'è
un'ineliminabile spinta aggressiva e distruttiva, che solo l'incessante processo
di civilizzazione può tentare di tenere a bada. Ma la guerra, questo "duello su vasta scala per costringere l'avversario a
piegarsi alla propria volontà", come la definì Von Clausewitz, riconosce a mio
avviso, ragioni supplementari; di carattere economico e ideologico. Gli uomini entrano costantemente in conflitto, a causa di interessi e di visioni
del mondo contrapposte e, almeno in apparenza, inconciliabili.
E, ritornando nell'ambito della psicologia, possono affacciarsi alla ribalta
della Storia, favoriti da un preciso contesto economico e culturale, leader
animati da una volontà di potenza distruttiva, dalla personalità gravemente
disturbata, capaci di convincere le masse della giustezza dei loro propositi.
Di personaggi sanguinari e affascinanti allo stesso tempo, ne incrociamo di
continuo, sfogliando qualsiasi manuale di Storia. Hitler, Stalin, Gengis Kahn,
Caligola, Nerone, Tamerlano... E, spiace ammetterlo, per un imperscrutabile mistero della natura umana persino
persone colte e capaci di affetto autentico nei confronti dei propri familiari e
della cerchia degli amici, riescono a macchiarsi di crimini infami nei confronti
dell'umanità. È il caso, per esempio, di molti gerarchi nazisti, affabili nella
quotidianità, che leggevano buoni libri e ascoltavano buona musica, capaci poi
di pianificare freddamente lo sterminio di esseri umani innocenti.
I pacifisti sostengono che la guerra è diventata ormai nella coscienza evoluta,
uno strumento obsoleto nella risoluzione dei conflitti. E hanno sostanzialmente
ragione. Purtroppo non riescono a dirci cosa dobbiamo fare, in concreto, se
imperi o nazioni sono pronti ad annientarci senza pietà.
La speranza di tutti va riposta nella costruzione di una Società delle Nazioni,
giudice super partes, che abbia l'autorevolezza e la forza di dirimere le
contese in nome di leggi e di regole chiare, stipulate in precedenza. Qualcosa
che assomigli all' Onu di oggi, ma riveduta e corretta, più giusta ed efficiente.
La pace e non la guerra è ciò di cui noi e le generazioni future abbiamo
bisogno. Ma sembra che i conflitti nel mondo stiano cessando infatti
Uno studio spiega come il mondo stia diventando sempre
più pacifico grazie a tre motivi: la fine della guerra fredda, le missioni di
peacekeeping, la diffusione della democrazia. In questo scenario anche sviluppo
economico e culturale giocano un ruolo importante
In
quindici anni il numero dei conflitti si è più che
dimezzato: dai 51 del 1991 fino ai 20 dell’anno scorso.
Esplosioni quotidiane in Iraq, massacri in Sudan,
le due Coree che si scrutano attraverso le rispettive
artiglierie, una guerra hobbesiana di tutti contro tutti
nel Congo orientale—i conflitti tormentano la società
umana da tempo immemorabile, forse da quando i nostri
antenati scoprirono che un ramo d’albero può essere
usato anche per percuotere. Eppure, anche se sembra
impossibile immaginarlo guardando i notiziari, la guerra
è entrata in una fase di declino.

Marines in
in Iraq |
I combattimenti in
Iraq e in alcuni altri paesi rappresentano un’eccezione
a una tendenza globale che viene ampiamente ignorata: da
circa 15 anni è in atto nel mondo una costante
diminuzione dei conflitti armati. Negli ultimi decenni,
le probabilità che una persona muoia a causa di una
guerra sono scese probabilmente ai valori più bassi
dell’intera storia dell’umanità.
Cinque anni fa due studiosi — Monty Marshall,
direttore delle ricerche presso il Center for Global
Policy della George Mason University e Ted Robert Gurr,
docente presso l’Università del Maryland— hanno raccolto
per alcuni mesi tutti i dati disponibili sulla frequenza
e sulla mortalità dei conflitti del XX secolo,
aspettandosi di dover compilare un registro di orrori e
distruzione in continuo peggioramento. Hanno invece
riscontrato, dopo i terribili anni delle due Guerre
Mondiali, un incremento globale dei conflitti armati
dagli anni ’60 fino a metà degli anni ’80, a cui è
seguita una diminuzione costante e pressoché
ininterrotta a partire dal 1991. Hanno inoltre
osservato, a partire da metà degli anni ’80, un aumento
costante nel mondo di diversi fattori in grado di
ridurre le probabilità di un conflitto: prosperità
economica, libere elezioni, governi centrali stabili,
comunicazioni migliori, un maggior numero di
«istituzioni di pace» e un maggior impegno
internazionale. Nel 2001 Marshall e Gurr, insieme a
Deepa Khosla, hanno pubblicato i risultati del loro
studio nel rapporto «Peace and Conflict», redatto per il
Centro per lo sviluppo internazionale e la gestione dei
conflitti (Center for International Development and
Conflict Management) dell’Università del Maryland.
Esaminiamo in primo luogo le cifre. Secondo il
rapporto il numero delle guerre e dei conflitti armati a
livello mondiale ha toccato il suo picco nel 1991 (51
conflitti), anno che può essere considerato il più denso
di guerre dell’intera storia. Dal 1991 in poi, questo
valore è sceso in modo costante. I conflitti armati sono
stati 26 nel 2000 e 25 nel 2002, anche considerando
l’attacco di Al Qaeda agli Stati Uniti e il contrattacco
americano contro l’Afghanistan. Nel 2004, secondo
l’ultimo studio di Marshall e Gurr, il numero dei
conflitti armati nel mondo era sceso a 20, anche
includendo l’invasione dell’Iraq. Sulla base di questi
dati, i conflitti in atto nel 2004 sono diminuiti di
oltre la metà rispetto al 1991.
Come si spiega questa diminuzione delle guerre di
fronte alle immagini di massacri che ci vengono proposte
quotidianamente dai notiziari? Una delle ragioni per cui
la guerra sembra imperversare ovunque è che, grazie
all’aggiornamento costante delle notizie sui canali
satellitari e via Internet, si trasmettono molte più
immagini di combattimenti rispetto al passato. Appena
vent’anni fa, la rivolta in Eritrea è passata quasi
inosservata agli occhi del mondo; l’instancabile Robert
Kaplan ha descritto la speranza di un gruppo di ribelli
eritrei di essere inquadrati almeno dai satelliti spia,
in modo che si venisse a sapere della loro lotta. Oggi,
i combattimenti che si consumano in Iraq, in Sudan e in
altri paesi vengono descritti in modo sofisticato, con
una grande ricchezza di filmati ripresi con minicamere o
addirittura con videotelefoni. Per le agenzie di stampa
è naturalmente un dovere dare ampio spazio ai conflitti.
Ma la visibilità di un così grande numero di
combattimenti crea l’impressione che il problema sia in
aumento: in realtà, ad aumentare sono le notizie, non i
problemi in sé.
Mueller calcola che nel XX secolo circa 200 milioni di
persone siano state uccise in eventi bellici o in
altri conflitti violenti, oppure a causa di decisioni
politiche legate alla guerra, come nel caso
dell’Olocausto. In quel secolo hanno vissuto circa
dodici miliardi di persone; ciò significa che ognuna di
queste aveva una probabilità dell’1%-2% di morire a
causa di una guerra internazionale, di un conflitto
etnico o di un genocidio. È la stessa probabilità,
osserva Mueller, che ha oggi un cittadino americano di
morire in un incidente automobilistico. Vista l’attuale
diminuzione delle guerre, per il momento uomini e donne
di tutto il mondo rischiano molto di più per il traffico
che per la guerra. Questo dato è suffragato dalle
statistiche dell’Organizzazione mondiale della sanità:
nel 2000, ad esempio, 300.000 persone sono decedute in
combattimento o per ragioni connesse alla guerra (ad
esempio per malattie o condizioni di malnutrizione),
mentre 1,2 milioni di persone hanno perso la vita in
incidenti stradali. Trecentomila decessi causati dalla
guerra nel 2000 sono un costo terribile, ma in termini
quantitativi rappresentano appena lo 0,005% sul totale
della popolazione vissuta in quell’ anno.
Un altro dato straordinario è quello che indica
come anche la spesa militare mondiale sia in declino.
Secondo i dati del Center for Defense Information, un
istituto di ricerca indipendente di Washington, la spesa
militare annua globale ha raggiunto il suo massimo nel
1985, con 13.000 miliardi di dollari, e da allora è
stata in continua discesa arrivando a poco più di 1.000
miliardi di dollari nel 2004. Poiché nello stesso
periodo la popolazione mondiale è aumentata del 20%,
sarebbe stato lecito aspettarsi un incremento della
spesa militare. Viceversa, in rapporto alla crescita
della popolazione, la spesa militare è diminuita di
oltre il 30%: da 260 dollari pro capite nel 1985 a 167
dollari nel 2004.
A che cosa è dovuta la diminuzione delle guerre?
Il fattore più rilevante sembra essere la fine della
guerra fredda, che ha allentato le tensioni
internazionali e ha ridotto il sostegno fornito da
americani e sovietici agli eserciti amici nei Paesi in
via di sviluppo. I combattimenti nelle nazioni più
povere si nutrono degli approvvigionamenti di armi
dall’estero. Con la riduzione del mercato internazionale
di armi e la maggiore difficoltà che incontrano molti
paesi in via di sviluppo nel procurarsi armamenti
pesanti, le fazioni in lotta nelle nazioni più povere
sono più motivate a cercare una soluzione pacifica ai
conflitti. Ad esempio, il lungo e violento conflitto in
Angola è stato sostenuto da uno strano mix di armi
sovietiche, americane, cubane e sudafricane fornite a
molteplici fazioni. Quando queste nazioni hanno
interrotto gli approvvigionamenti di armi, i leader
delle fazioni si sono seduti loro malgrado al tavolo
delle trattative.
Un’altra ragione della diminuzione delle guerre è
stato l’aumento delle operazioni di peacekeeping. Il
mondo spende ogni anno di più in questo tipo di azioni,
che si stanno dimostrando un eccellente investimento.
Migliaia di soldati e unità di peacekeeping dell’Onu,
della Nato, americani e di altre organizzazioni
pattugliano le aree più turbolente del pianeta, con un
costo di almeno 3 miliardi di dollari l’anno: in termini
economici è molto più efficace prevenire i conflitti che
dover poi intervenire con la forza.

La guerra forse potrà finire... |
La diffusione della democrazia ha rappresentato
un altro importante contributo alla diminuzione delle
guerre. Nel 1975, solo in un terzo delle nazioni del
mondo si tenevano vere elezioni con più candidati; oggi
la percentuale ha raggiunto i due terzi ed è in continua
crescita. Negli ultimi vent’anni, circa 80 paesi hanno
adottato una forma di governo democratica, mentre gli
spostamenti in senso opposto sono stati minimi. I leader
dei paesi in via di sviluppo sono sempre più consapevoli
del fatto che le nazioni libere sono anche le più forti
e le più ricche, e questa constatazione crea una
motivazione molto forte per la diffusione della libertà.
Per le grandi potenze, il deterrente nucleare ha
rappresentato un ovvio fattore di limitazione dei
conflitti. La bomba atomica ha fatto la sua comparsa nel
1945 e l’ultimo combattimento tra grandi potenze, quello
tra gli Stati Uniti e la Cina, si è concluso poco dopo,
nel 1953. Dal 1871 al 1914, l’Europa ha goduto di quasi
mezzo secolo di pace; i 52 anni trascorsi dalla fine
dell’ultima guerra tra grandi potenze rappresentano il
periodo di pace più lungo dalla nascita del moderno
sistema di stati.
È possibile che le guerre diminuiscano a causa
del progresso culturale? Questa ipotesi sembra più
azzardata. La natura umana ci ha deluso molte volte
nella storia. Alcuni hanno sostenuto che la filosofia
militarista sia stata distrutta con la Seconda Guerra
Mondiale, quando gli stati dediti totalmente allo sforzo
bellico e alla conquista violenta sono stati non solo
sconfitti, ma anche ridotti in macerie dalle nazioni
libere, inizialmente restie a partecipare al conflitto.
La Seconda Guerra Mondiale ha rappresentato il trionfo
della libertà sul militarismo.
Esiste anche la possibilità che l’enorme rilevanza
dell’economia nella vita moderna svolga un ruolo
importante nella limitazione delle guerre. Gli stati
legati da relazioni commerciali sono forse meno inclini
a combattersi l’un l’altro: se nascesse un conflitto tra
la Cina e gli Stati Uniti, è probabile che entrambe le
economie subirebbero un crollo. È vero che, anche nei
decenni che hanno preceduto la Prima Guerra Mondiale, si
riteneva che l’intensificazione del commercio avrebbe
prevenuto lo scoppio di una guerra. Ma è altrettanto
vero che le circostanze attuali sono molto diverse da
quelle del tardo XX secolo. Prima della Prima Guerra
Mondiale, le grandi potenze coltivavano ancora
l’illusione che si potesse fare una guerra senza causare
una devastazione generale; le due Guerre Mondiali sono
state iniziate da governi convinti di poterle sfruttare
per acquisire una posizione di vantaggio. Oggi, nessun
governo importante sembra credere che la guerra
rappresenti la strada migliore per ottenere un vantaggio
nazionale o economico; il commercio sembra offrire
prospettive molto più promettenti.
Il compianto economista Julian Simon sosteneva
che, in un’economia basata sulla conoscenza, le persone
e le loro capacità intellettuali sono più importanti
delle risorse fisiche, e che perciò le vite dei
cittadini valgono più di qualsiasi oggetto che si possa
conquistare con la guerra. Simon aveva una visione
fortemente ottimistica — riteneva che i governi fossero
fondati sulla ragione — ma esiste comunque la
possibilità che questa sua visione si avveri. Già oggi,
nella maggior parte delle nazioni occidentali la vita
dei cittadini possiede un valore economico superiore a
quello dei territori o delle ricchezze che si potrebbero
acquisire con un conflitto. La progressiva diffusione
dell’economia basata sulla conoscenza potrebbe far
diminuire parallelamente l’importanza delle risorse
fisiche e, d’altra parte, accrescere il valore della
vita. E questo è indubbiamente un progresso culturale.
 Gregg Easterbrook
Gregg Easterbrook
Redattore capo di
«The New Republic»
Certo il numero dei conflitti sta diminuendo
ma bisogna dire che è nata una nuova forma di guerriglia:
il TERRORISMO.
Il terrorismo è una forma di lotta politica che consiste
in una successione di azioni clamorose, violente e premeditate
(attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, ecc.) ai
danni di nazioni, governi, gruppi etnici o fedi religiose. Tutte
le azioni terroristiche hanno per scopo principale non la
distruzione e la morte generate, anche se grandi, ma la
risonanza mediatica che queste azioni hanno: lo scopo del
terrorismo è la modifica (o la distruzione) dello status quo
sfruttando i mass-media come cassa di risonanza che amplifica le
gesta dei gruppi terroristici e ne crea la "leggenda" e un'aura
di potenza che richiama nuovi aderenti alla causa e scoraggia la
popolazione dall'opporsi.
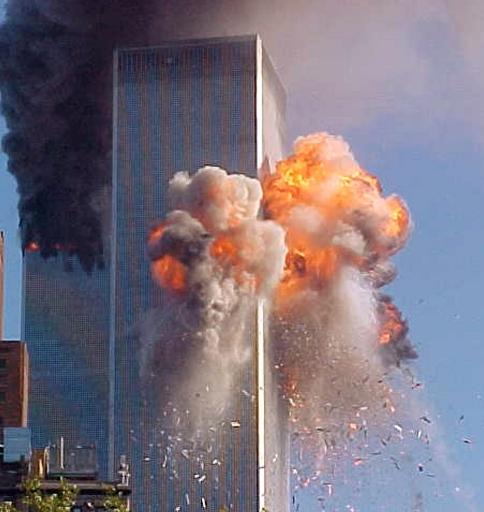
L'attentato alle Torri Gemelle
l'undici settembre 2001 |
Per questo motivo molte azioni
terroristiche prendono di mira persone, monumenti, edifici o
luoghi con un forte valore simbolico e molto presenti
nell'immaginario popolare: ciò che importa nell'attentato
terroristico, oltre al danno in sè, è fare in modo che si
parli molto del danno provocato. Funzionale a questo effetto
di risonanza è anche l'efferatezza, la ferocia e l'enormità dei
gesti stessi di distruzione: sequestrare 100 bambini in una
scuola è più efficace, ai fini della strategia del terrore, che
sterminare 100 adulti in una caserma, perché il risalto
mediatico dato all'evento (l'audience, se vogliamo) sarà
maggiore. Per questo motivo il terrorismo propriamente detto è
un fenomeno caratteristico del XX secolo, il primo periodo
storico in cui l'umanità dispone di mass media.
Generalmente i gruppi terroristici sono organizzazioni
segrete costituite da un numero ridotto di individui: a volte i
terroristi si considerano l'avanguardia di un costituendo
esercito, dei guerriglieri che combattono per i diritti di un
gruppo o per una ideologia. Per sua stessa natura (imporre a
tanti la volontà di pochi) il terrorismo è antidemocratico e
tende all'instaurazione di una dittatura. Un movimento
terroristico che ha successo può effettivamente portare a una
resistenza armata e/o alla costituzione di un esercito
guerrigliero, nel qual caso tattica e strategia cambiano per
adattarsi a uno scontro più aperto, e anche la politica del
movimento subisce delle modifiche, diventando meno radicale e
più concreta.
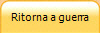
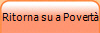
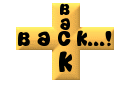
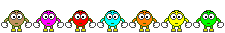
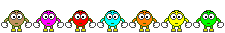
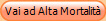
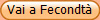
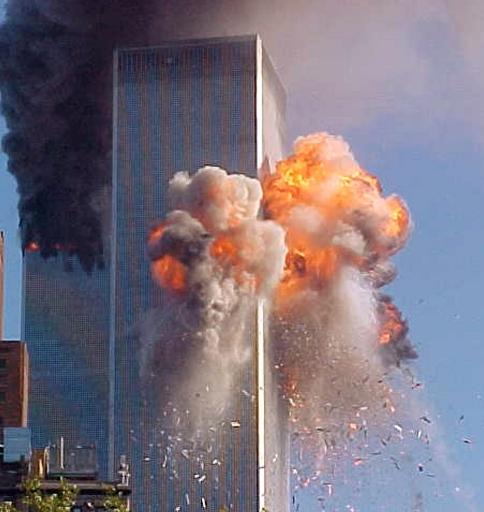




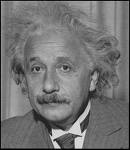 (Fisico e Filosofo)
(Fisico e Filosofo) (Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)
(Politico inglese,Scrittore e Segretario Privato della Regina Victoria)