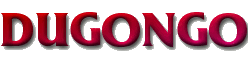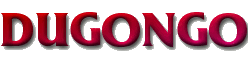Il dugongo è un mammifero dell'ordine dei
Sirenii; l'unica specie del genere Dugong e della famiglia dei
Dugongidi. È un parente relativamente prossimo del
lamantino, da cui si differenzia soprattutto per la forma biforcuta della
coda. Per secoli oggetto di
caccia, è oggi
a rischio di estinzione.
 |
Il dugongo è un animale
acquatico di
grossa mole e di colore grigio-biancastro che può superare i 3
metri di
lunghezza,
per un
peso
compreso tra 400 e 500
kg.
La
femmina risulta spesso leggermente più lunga e pesante del
maschio ma non abbastanza da poter parlare di
dimorfismo sessuale.
Il dugongo ha una struttura fisica tozza e compatta che gli ha fatto
guadagnare il popolare
soprannome di "mucca di mare"; in questo sirenide, infatti, una pinna
caudale orizzontale divisa in due lobi simile a quella dei
cetacei si
associa ad un corpo estremamente massiccio provvisto di due
ghiandole mammarie
toraciche e di
due grosse pinne
anteriori appiattite, a forma di spatola. Queste ultime hanno una doppia
funzione: esse servono sia da mezzo di locomozione
sia, in
pochi casi, da arti
prensili. Anche la
testa ha una
forma insolita, caratterizzata da minuscoli
occhi e
orecchie e
da un grosso paio di spesse labbra:
mentre i primi sono però fattori propri di molti mammiferi marini (si pensi alla
balena o all'orca),
il secondo è posseduto solo da questa specie, ed è dovuto alla sua particolare
dieta.
La sua pelle
è, al pari degli altri sirenii, usata principalmente come accumulatore di
materia grassa, risorsa che torna utile durante l'inverno come protezione
termica dalle basse temperature. Essa è inoltre estremamente resistente e dotata
di buone capacità rigenerative: una profonda ferita inflitta da una rete da
pesca d'alto mare può guarire infatti anche in un solo giorno. Nonostante la sua
vita si svolga completamente in mare, come i cetacei il dugongo è costretto a
salire a galla periodicamente per prendere aria.
I dugonghi sono animali sociali,
che spesso vivono anche in gruppi composti da
tre o quattro individui; in ogni gruppo
può essere presente anche più di un maschio,
comportamento questo
non riscontrabile che in poche altre specie viventi. La socialità è per questa
specie più un mezzo di difesa
che un sistema di attacco:
ciò avviene perché i dugongidi
non si dedicano alla caccia, e quindi non hanno bisogno di
alleati che li aiutino a
tendere trappole alle
prede (si pensi al
comportamento del leone, un
mammifero terrestre carnivoro).
Il dugongo è un mammifero
erbivoro marino, uno dei pochi esistenti; per questo motivo la sua dieta è
basata esclusivamente sulle
piante marine (della
famiglia
Potamogetonaceae, anche se non disdegna le Hydrocharitaceae e le Cymodoceaceae),
che è solito brucare nelle acque più basse, dove i
predatori (come ad esempio
gli squali) non si avventurano
quasi mai. Analisi effettuate sulle
feci di questi animali hanno spesso rilevato la presenza di piccoli
invertebrati; è
plausibile che siano inghiottiti durante il
pascolo delle piante
acquatiche. L'alimentazione
è l'attività cui il dugongo si dedica maggiormente durante la
giornata: può arrivare a
mangiare ben 30 kg di
alghe al giorno; per agevolarsi
il dugongo adopera le sue muscolose labbra, molto utili per strappare le alghe
dal fondale, e le pinne
anteriori, che usa quasi come mani per reggere il cibo (si veda l'immagine a
sinistra).
 |
L'accoppiamento è un'operazione molto lunga e lenta, che può durare anche diverse ore;
la femmina partorisce un solo cucciolo, che subito provvede ad allattare, anche questa volta adoperando le pinne anteriori come braccia per
mantenere il piccolo vicino a sè.
Spesso la scelta del partner avviene secondo un rituale per il quale più maschi si contendono,
lottando, la stessa femmina; è stato però documentato anche un comportamento differente, per cui un
gran numero di individui maschi si reca in un'unica zona, e le femmine scelgono liberamente con chi accoppiarsi.
Durante questo periodo i dugonghi maschi, solitamente non molto territoriali, divengono estremamente aggressivi,
al punto che anche per un essere umano può essere pericoloso avvicinarli.
Il più antico resto di dugongo, risalente a 6000 anni fa, si trova in Giappone, nell'arcipelago di Ryu Kyu: le ossa di questo primitivo animale ci hanno rivelato che esso è stato lasciato praticamente invariato dall'evoluzione fino al giorno d'oggi. Oggi esiste una sola specie di dugongo, il D. dugon, ma non è sempre stato così: fino al XVIII secolo, infatti, ne era esistita una seconda, l'Hydrodamalis gigas, poi estintasi per l'eccessiva caccia da parte dalle popolazioni locali e dai colonizzatori europei all'inizio del 1700. L'unica specie di dugongo sopravvissuta è dunque oggi considerata protetta, malgrado la caccia abusiva o la pesca disattenta ne stiano lentamente causando la completa estinzione.
In alcuni altri stati, specialmente appartenenti al sud-est asiatico, si sono create diverse leggende sui dugonghi: alcune culture lo vogliono portatore di sfortuna, mentre altre ritengono la sua presenza di buon augurio; ci furono civiltà, sempre in quei luoghi, che credevano le lacrime di dugongo una magica pozione amorosa, mentre infine altre (appartenenti alle isole Filippine) utilizzavano le sue ossa per fabbricare amuleti contro la sorte avversa.
Oggigiorno il dugongo è diffuso solamente nell'Oceano Indiano, all'estremità occidentale di quello Pacifico, in corrispondenza a particolari gruppi di isole equatoriali e tropicali come l'Australia, l'Indonesia, la Thailandia (in particolare nel mare nelle andamane nell'arcipelago di Trang, spesso avvistato nei pressi dell'isola di koh Libong) o lo Sri Lanka, e nel Mar Rosso; solo pochi secoli fa la mappatura avrebbe compreso anche l'Oceano Atlantico ed il Mar Mediterraneo, zone da cui ora il dugongo è completamente estinto.
Il luogo in cui la densità della popolazione di dugonghi raggiunge il valore massimo è l'Australia, soprattutto nelle sue coste settentrionali, seguita dalle sponde egiziane del Mar Rosso; negli altri stati i dugonghi sono invece una specie rara, raggiungendo al massimo i 100 individui a nazione: basti pensare che il Kenia, luogo dove una volta i manatee abbondavano, oggi conta una popolazione totale di soli 6 individui. Anche nelle già nominate isole giapponesi Ryu Kyu, habitat da millenni di questi animali, la situazione è tragica, così come in Madagascar e nelle isole al largo della costa orientale africana: ciò ha spinto importanti organizzazioni mondiali, come il WWF, a dichiarare il dugongo un animale in via d'estinzione da salvaguardare.
 |
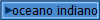 |