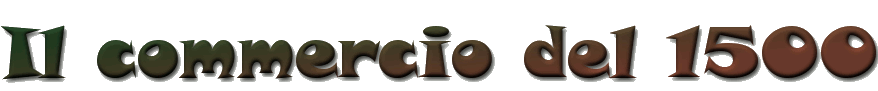
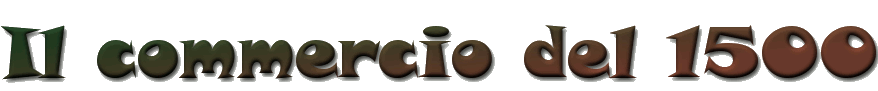
IL COMMERCIO TRIANGOLARE
I mercanti portoghesi introdussero i primi schiavi africani in Europa intorno al 1450, come elementi decorativi delle corti. Usare i prigionieri come schiavi domestici era una pratica diffusa fra le tribù della costa dell'Africa Occidentale e i mercanti locali vendevano gli schiavi in cambio di beni di produzione europea: tessuti, vetro e armi. Nel Cinquecento la colonizzazione del Sud America ampliò le prospettive di questo modesto commercio bilaterale, creando un nuovo polo con il traffico di schiavi africani attraverso l'Atlantico.
In un primo tempo le colonie inglesi e francesi delle Indie Occidentali si affidarono a lavoratori europei, ma il caldo torrido e le malattie tropicali sterminarono tre quarti dei coloni bianchi nel giro di due anni. Quando il boom dello zucchero, a metà Settecento, provocò il bisogno urgente di manodopera numerosa e a poco prezzo, più adattabile al clima e al duro lavoro nelle piantagioni, si determinò il "commercio triangolare".
|
|
Questo sistema conosceva una triste e ricca gamma di variazioni : ad esempio, dall'Africa gli schiavi raggiungevano i paesi dell'America Latina e lavoravano per l'agricoltura, la quale forniva zucchero da esportare in Nord America. Dal Nord America, i beni prodotti con queste risorse (ad esempio i liquori come il rum) attraversavano l'Atlantico, venendo trasportati nel nuovo mondo: essi erano destinati ai mercanti di schiavi in Africa o alla vendita in Europa, e così si chiudeva il ciclo. Quest'ultimo aveva una durata annuale. Ogni percorso veniva coperto da navi diverse.
La fonte principale di manodopera era la cosiddetta Costa degli Schiavi, che si estende, a Sud del Sahara. Dal punto di vista sociale, c'è da dire che la detenzione ed il commercio degli schiavi fiorivano anche perché in Africa erano attività legali, e a partire dalla Costa degli schiavi si sviluppava un ricco commercio che esportava manodopera in diverse direzioni. Una parte degli schiavi era infatti destinata al mercato interno africano: soprattutto, era in voga l'esportazione di schiavi destinata ai porti mediterranei dell'Africa del Nord. I
Il commercio degli schiavi era controllato da compagnie francesi, olandesi tedesche ed inglesi. Fra tutte spiccava la English Royal African Company, che vendeva schiavi alle colonie più disparate. Di questo enorme movimento, la traccia più appariscente rimasta fino al giorno d'oggi è la mescolanza di etnie e lingue sul continente americano.
Pagine correlate: La tratta degli schiavi.