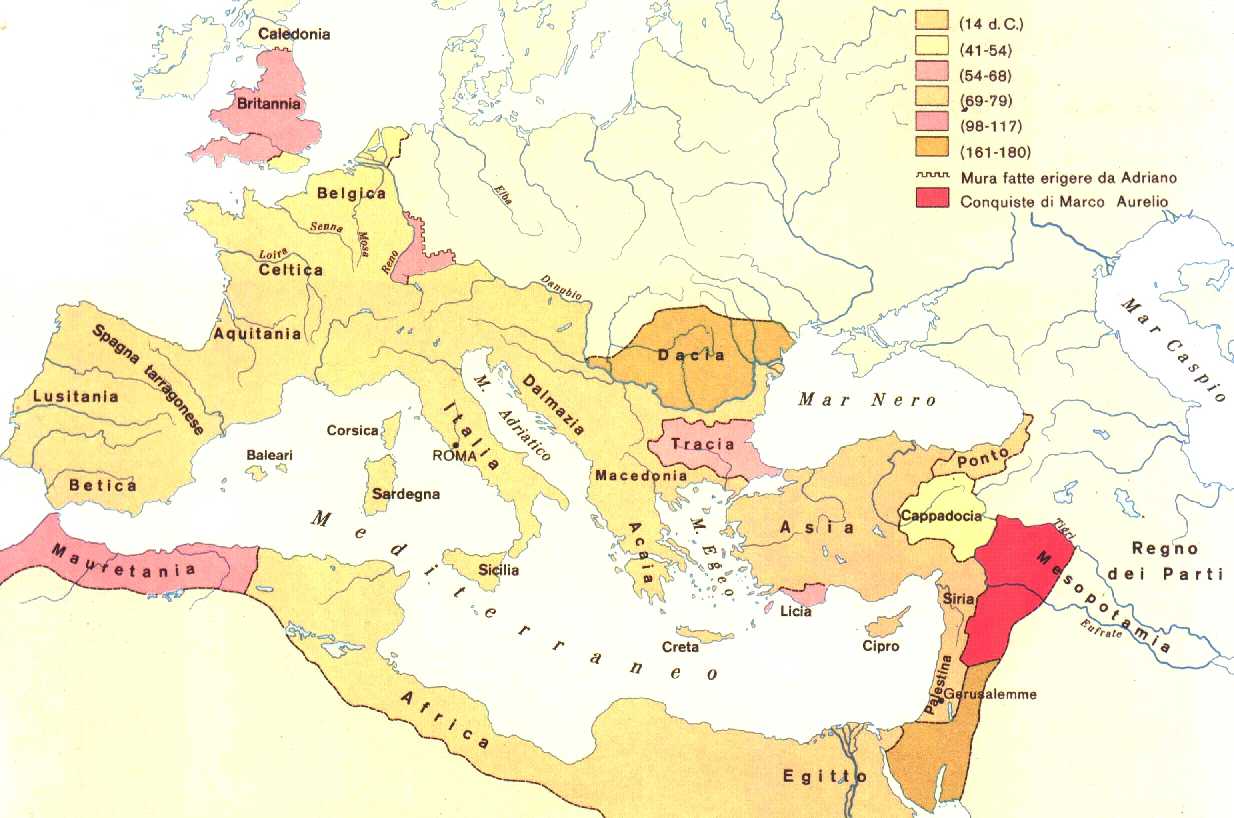![]()
L'impero
Dopo
l'austera Roma del tempo monarchico e quella ricca e raffinata del periodo
repubblicano, vediamo ora il terzo e ultimo volto della "città
eterna", quello della Roma imperiale, il più fastoso e inquietante per la
molteplicità e drammaticità dei suoi aspetti.
Le famiglie o dinastie che si susseguono nel periodo
imperiale nei primi due secoli dopo Cristo procedono ad un costante
potenziamento dello Stato romano.
Questa
fase raggiunge il suo apice sotto gli Antonini, o "imperatori
d'adozione", in quanto scelti e adottati dal proprio predecessore, ancora
in vita. Nei quasi novant'anni in cui essi governarono, la pax romana regna
indisturbata all'interno dei vastissimi territori che costituivano l'impero,
che in quell'epoca raggiunse il massimo della sua espansione.
Fiorivano
i commerci, le arti, le attività industriali.
Alcuni
fra i più famosi imperatori, letterati, filosofi, furono iberici, galli e
africani.
Le
particolari cure rivolte all'amministrazione statale, permisero la costruzione
di un edificio che, nel suo complesso, doveva reggere ancora per due secoli e
mezzo ad enormi pressioni disgregatrici interne ed esterne.
Infatti,
già nel III secolo il panorama cambia totalmente.
Un
tragico susseguirsi di guerre civili fra capi militari di origini diverse,
conseguenza della mancanza di capacità decisionali o moderatrici da parte del
governo centrale, portò rapidamente il sistema imperiale sull'orlo dello
sfacelo. L'intervento della dinastia Illirica, che ebbe come suo massimo
esponente Diocleziano (243-313), ristabilì momentaneamente le sorti dello Stato
romano, gettando le basi dell'organizzazione amministrativo-sociale che ne
permise la parziale continuità, almeno in un settore orientale.
Ma
non precorriamo ora i tempi; diamo invece uno sguardo alla Roma imperiale del
primo periodo, l'orgogliosa caput mundi, nel momento del suo massimo fulgore.
La città sotto Augusto e Nerone
Già
con il primo degli imperatori, Ottaviano Augusto, Roma subì una trasformazione,
assume l'aspetto di una città fastosa. Edifici monumentali si affacciano sulle
piazze, i palazzi si rivestono di marmi e si adornano di statue e colonne, le
vie si allargano, e il verde arricchisce giardini e viali.
Ancora
negli ultimi tempi della Repubblica, gran parte della città aveva un aspetto
grigio e dimesso. I successori di Augusto, della gens Julia Claudia,
proseguirono la sua opera urbanistica.
Nerone,
nei soli ultimi quattro anni del suo regno, fece costruire quella enorme Domus Aurea,
la dimora d'oro, che doveva sostituire l'antica reggia distrutta da un incendio
in cui vi erano sale alte quaranta metri con soffitti che si aprivano per far
cadere fiori sugli ospiti ai banchetti. Allo stesso imperatore si devono la
costruzione di un complesso di sontuosissime terme e la riedificazione in stile
già "imperiale" dei quartieri poveri, distrutti dallo stesso
colossale incendio cui abbiamo accennato sopra.
Tutti questi imponenti lavori poterono essere
eseguiti con facilità. La mano d'opera, fra schiavi e corporazioni di liberi
lavoratori non era certo mancante. D'altra parte, numerose erano le opere
d'arte che venivano prelevate da antiche città greche, che spesso erano saccheggiate anche dei materiali indispensabili all'edilizia romana. In
questo modo Roma si arricchisce anche di opere di pubblica utilità, come
acquedotti, strade, edifici pubblici, porti.
Purtroppo
però, il popolo romano, di tutti i livelli sociali, in questa particolare
situazione di fasto della città, si orienta sempre più all'ozio e ai
divertimenti.
Il costume durante l'Impero
Ancora
al tempo di Augusto, la candida toga era per eccellenza la veste romana.
Augusto stesso si vantava di indossare una toga tessuta in casa dalle sue
donne, come un Romano dei tempi antichi. Adesso i Romani ricchi disprezzano
quel classico costume e indossano al suo posto raffinate tuniche di lana e di
seta, colorate in verde pallido, in rosa o addirittura in porpora, in viola
intenso o in bruno e sulle quali portano sciarpe o mantelli ricamati.
Col
terzo secolo verranno di moda le vesti di pura seta, stoffa pregiata che arriva
dalla Cina attraverso l'India e l'Asia Anteriore. Le fogge sono innumerevoli
perché i Romani durante l'Impero, si compiacciono di imitare mode straniere,
specialmente orientali e se compare qualche tipo nuovo di abito presto il suo
uso si diffonde fra gli eleganti (si precorre il moderno concetto di moda).
Naturalmente
il costume femminile non è meno ricco. Piacciono adesso le lunghe
"stole" che giungono ai piedi su cui si indossa la corta e preziosa
"tunichella" di stoffa ricamata o damascata, decorata con frange
d'oro.
Per
proteggere la testa si usano lunghi e sottili veli ed è segno di raffinatezza
tenere in mano un leggero drappo ricamato per asciugarsi il sudore.
Le
donne, in questo periodo, vanno a passeggio al pari degli uomini, accompagnate
da un'ancella o in ricche portantine dorate con tende di seta, fra le quali si
affacciano ogni tanto mostrando il volto truccato e le alte capigliature
arricciate tenute ferme con pomate resinose e ornate di gioielli.
La giornata di una dama
Una
donna ricca ha adesso tre principali interessi e vi dedica tutta la sua
giornata: farsi bella, andare a far compere nei negozi e visitare i templi
delle divinità straniere o consultare le fattucchiere.
Le
cure di bellezza sono molto simili alle nostre: un famoso poeta dell'epoca,
Giovenale, scrive che la donna romana, quando è in casa, ha sempre il volto
coperto di mollica di pane inzuppata nel latte, o di pomate e di unguenti, e
che si presenta con la faccia pulita solo quando arrivano ospiti; passa ore ed
ore davanti allo specchio costringendo la schiava pettinatrice a montarle
ricciolo per ricciolo una pettinatura alta come una torre; si copre di collane
e di braccialetti e porta orecchini così pesanti che le allungano le orecchie.
La
visita ai negozi è certo per lei la vicenda più piacevole della giornata. In
ogni via si susseguono botteghe a non finire, dove si vende di tutto: stoffe,
ninnoli, profumi, gioielli, calzature, libri, parrucche.
Alcune
di queste botteghe sono veri salotti: le dame si danno convegno, si siedono e
chiacchierano mentre il negoziante espone davanti a loro tutta la sua
mercanzia, che esse guardano distrattamente. Ogni tanto fanno un cenno di
assenso e subito l'oggetto così acquistato viene consegnato ad uno schiavo del
seguito.
Infine
si dilaga per le dame dell'aristocrazia romana, la mania delle
fattucchiere. Esse non hanno più molta
fiducia nelle antiche divinità romane ma ripongono una fede superstiziosa in
quelle venute dall'Egitto, dalla Siria, dalla Persia, dall'Asia Minore.
Roma
pullula di templi stranieri grandi e piccoli, di forma strana, intensamente
decorati e dipinti, custoditi da sacerdoti con strani cappelli e vesti a vivaci
colori. E una dama del bel mondo ha sempre numerose amicizie fra quei sacerdoti
che le predicono il futuro, le insegnano come poter mantenere la salute e la
bellezza, scongiurare i malanni, ottenere tutto quello che desidera, e, in
cambio, si fanno elargire generosi doni. Né diversamente si comportano le
indovine e le fattucchiere. Vanità e superstizione sono le caratteristiche
principali della donna di questo periodo.
Vita del Romano ricco
La
giornata di un "ricco romano", in quest'epoca, che limiteremo per ora
al periodo fra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, è dedicata soprattutto
ai piaceri.
Al
mattino si alza tardi perché il giorno prima ha banchettato fino a notte, si fa
massaggiare energicamente dagli schiavi, consuma una colazione leggera e va un
poco a spasso, a piedi o in lettiga. Anche lui, come le dame, dà un'occhiata ai
negozi, si ferma in una libreria più che altro per incontrare qualche amico,
perché le librerie sono, per gli uomini, quello che per le dame sono i negozi
di calzature, di gioielli o di stoffe: dei luoghi di ritrovo.
Non
che i Romani amino adesso particolarmente la cultura, ma in questi ultimi tempi
dell'ellenismo il libro è divenuto una moda. Non sono libri dotti, quelli che i
Romani preferiscono, si tratta di racconti più o meno avventurosi o di raccolte
di versi scherzosi in cui si mettono in caricatura fatti e personaggi del
giorno, le cosiddette "satire".
A
mezzogiorno, secondo l'uso antico, si fa un pranzo non molto abbondante poi una
siesta e infine ci si reca al più gradito luogo di convegno, le terme, ossia il
bagno pubblico.
Le terme
Le
terme, numerose e vaste, sono gli edifici pubblici più frequentati, spesso
sontuosi. Ne sono sorte un po' dappertutto. Gli imperatori ne fanno costruire
di magnifiche e amano legarle al loro nome. Ve ne sono per il popolo e per i
ricchi, sempre con grande sfoggio di marmi scolpiti e di saloni imponenti. Si
aprono a mezzogiorno o poco dopo, e si chiudono dopo il tramonto del sole o
addirittura a notte. Vi è chi, saltando addirittura il pranzo, entra nelle terme
appena si aprono e mangiucchia qualche cosa in attesa del complicato rito del
bagno . Altri vi arrivano dopo la siesta, verso le tre, con un seguito di
schiavi che recano tutto l'occorrente: ampolle d'olio, soda, che serve come
sapone, "strigili", ossia speciali strumenti di ferro o di bronzo per
un energico massaggio, vari panni per asciugare il volto e il corpo.
Il
luogo è sempre affollato e rumoroso siccome si chiacchiera, si fa ginnastica,
si giuoca e addirittura si trattano affari.
Il bagno
Il
rito del bagno, in questa epoca, ha raggiunto una estrema raffinatezza ed è
regolato da norme precise e complicate a seconda dei risultati che si vogliono
ottenere. Ma in genere si svolge così: anzitutto si cerca di riscaldare il
corpo con degli esercizi ginnastici e con il popolarissimo giuoco della palla
che consiste nel lanciarsi e nel prendere a volo una sfera riempita di stoppa.
Chi lo fa con degli amici, chi con i propri schiavi, ma è pur sempre lo stesso
esercizio, ravvivato da grida e da risa. Quando si è tutti in sudore si fa un
bel tuffo nella piscina natatoria, una grande vasca dove si può nuotare in
acqua profumata, tiepida o a temperatura naturale. Oppure si passa nel calidarium per fare un bagno caldissimo
che apre bene i pori della pelle. Usciti di lì, ci si sottopone al massaggio:
schiavi addestrati, o massaggiatori pubblici, passano energicamente lo strigile
sulla pelle sudata e ne fanno sprizzar fuori sudore e grasso. Distesi sui
lettucci, con gli occhi chiusi, i bagnanti si lasciano strofinare così per un
bel pezzo, intrecciando lenti dialoghi con i vicini. Poi passano in sale tenute
a calore moderato, il tepidarium, per
lasciar calmare il fervore del sangue. In queste sale le conversazioni
continuano: ci si raccontano a bassa voce barzellette o gli ultimi pettegolezzi
di corte . Infine si entra nelle sale del bagno freddo, il frigidarium, nelle cui vasche l'acqua è rinfrescata da neve portata
dai monti vicini. La reazione è violenta e tonificante: per vincere il freddo i
bagnanti gridano, ridono, si dibattono, finché tremanti, escono e si
abbandonano ancora ad un altro massaggio che, adesso, è assai meno violento,
non viene fatto con gli strigili ma con le mani, e i massaggiatori usano in
abbondanza olii profumati e unguenti.
Le Abitazioni
La
domus
Molte
delle case, dei palazzi, degli edifici romani sono andati distrutti.
Ai
giorni nostri disponiamo però d'un campionario straordinariamente interessante
di case comuni che si sono conservate a causa di una grande tragedia naturale:
l'eruzione del vulcano Vesuvio avvenuta il 24 agosto del 79 d.C. che ha sepolto
sotto lava, ceneri e fango diverse floride città dell'area napoletana: Pompei, Ercolano, Oplontis, Stabia.
Poiché
queste città sono state "fermate nel tempo" mentre erano ancora in
piena efficienza, gli scavi ci forniscono una testimonianza di vita quotidiana.
La città maggiore, Pompei, era costituita da vari edifici: botteghe,
laboratori, osterie, case con stanze in affitto, case di cittadini ricchi,
ville (al di fuori delle mura) e naturalmente templi, bagni pubblici, palestre,
teatri. Di solito le case avevano muri di mattoni a cui potevano anche essere
mescolate pietre, ed erano ad un solo piano. La casa di una famiglia benestante
poteva avere nella parte affacciata sulla via alcune botteghe gestite da
persone estranee. Tipicamente le case romane avevano una corte circondata da
colonne (atrio) in cui una vasca quadrata raccoglieva l'acqua piovana
proveniente dai tetti inclinati verso l'interno. La parte padronale della casa
comprendeva varie camere da letto e una sala da pranzo arredata su tre lati con
dei letti su cui mangiavano comodamente i commensali. A Pompei si sono
conservate assai bene le decorazioni alle pareti: sono affreschi che ritraggono
paesaggi, scene mitologiche o anche finti elementi architettonici, come
colonne, cornici, porte e finestre; negli ambienti più modesti le pareti sono
trattate a calce.
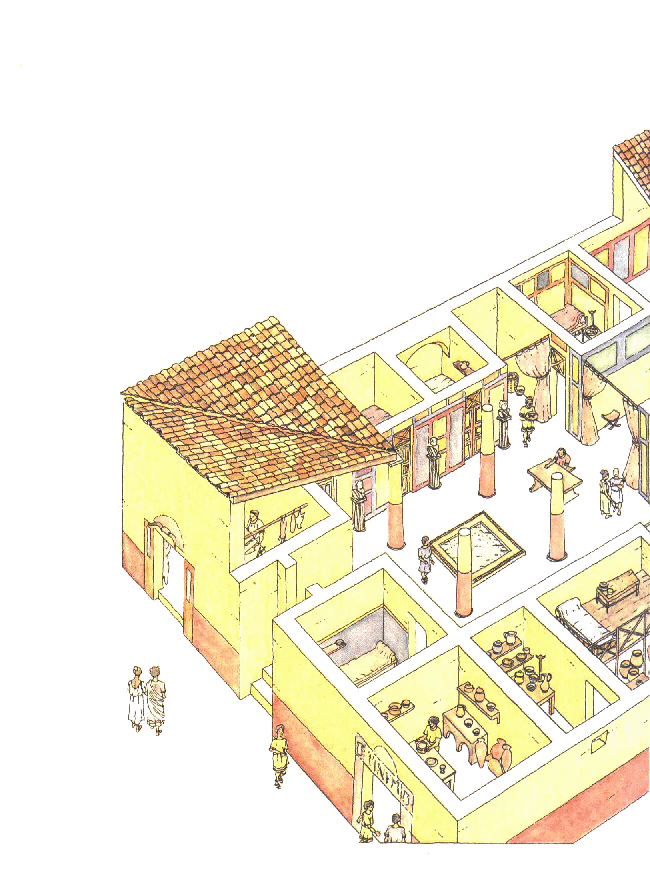
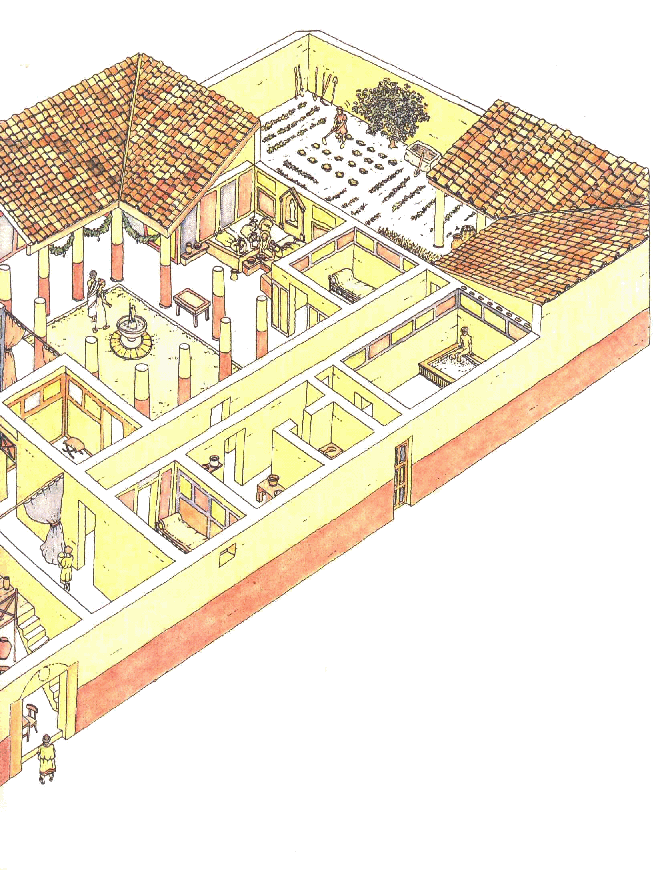
L'insula
Gli
edifici per abitazione delle grandi città erano diversi dalle case a un piano
di Pompei ed Ercolano: di solito essi comprendevano parecchi appartamenti
dislocati su più piani (fino a quattro o cinque).
In
queste case non si viveva molto bene, sia per il gran numero di inquilini e per
la scarsa disponibilità d'acqua (di solito ogni gruppo familiare prelevava da
una fontana pubblica nella via la quantità necessaria per la giornata e la
portava all'interno), sia per l'igiene scarsa, non esistevano latrine nelle
case.
I
locali erano angusti, i soffitti bassi, le scale scomode.
Questi
complessi abitativi potevano essere molto grandi e quando erano circondati da
quattro strade formavano una insula
("isola"), da cui deriva il nostro isolato.
Evidentemente
tali soluzioni erano adottate nelle grandi città perché, come in quelle
attuali, il terreno era prezioso, e numerosissimi cittadini (1.200.000 nella
Roma Imperiale) dovevano abitare vicini al luogo di lavoro. Tra gli esempi
meglio conservati di insulae a molti
piani vi sono quelle di Ostia, il porto di Roma, dove un progressivo
abbassamento dei terreni ha seppellito edifici anche molto alti.
L'insula
popolare era costruita con mattoni e materiali di reimpiego. La solidità delle
strutture, anche a causa dei molti piani sovrapposti era mediocre: sono
documentati crolli in cui vennero travolte molte persone. I costi di locazione
erano alti, in uno stesso locale venivano disposti sia i letti sia gli attrezzi
per cucinare e scaldarsi, spesso causa di incendi disastrosi.
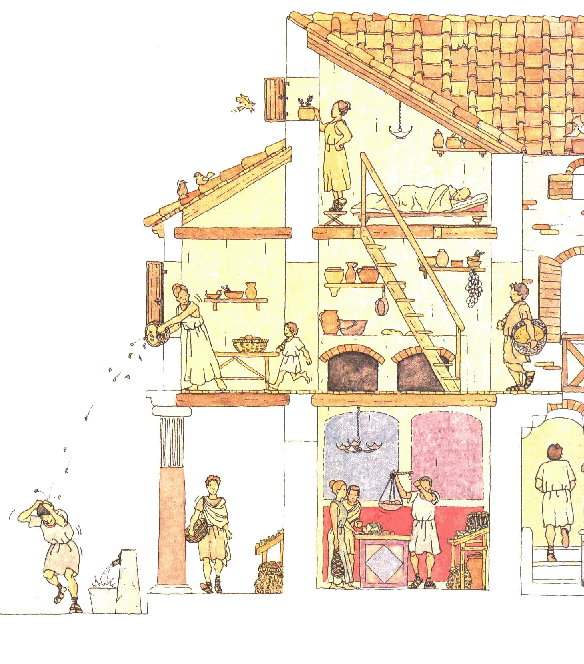
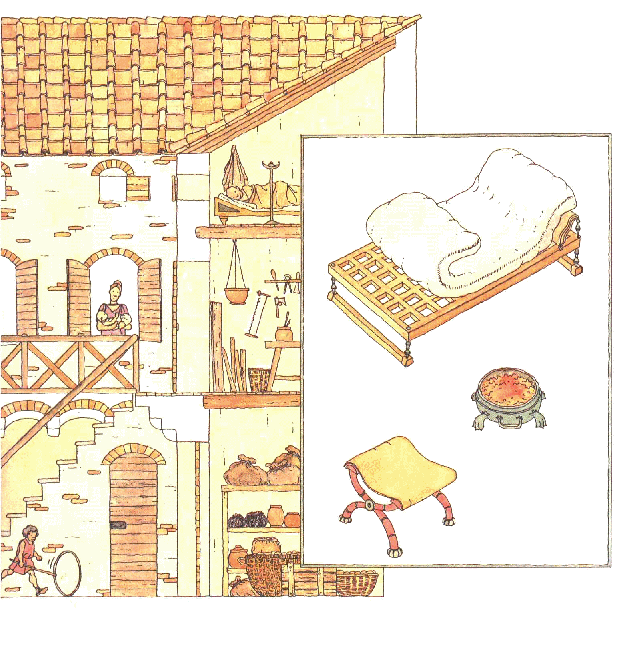
Classi nuove
Fin
dai tempi della Repubblica i Romani hanno amato il banchetto serale. Durante
l'impero, nel bel mondo, questo banchetto è divenuto la funzione più
caratteristica e più importante della vita di Roma. Sono passati i tempi in cui
il numero dei convitati, in un festino elegante, non doveva sorpassare quello delle
nove Muse, le gentili divinità che presiedevano alle scienze e alle arti.
Adesso
i festini sono molto numerosi e assai meno legati alle regole della buona
educazione e del buon gusto. Ma il fatto è che a Roma abbondano ora i nuovi
ricchi, molti dei quali sono stati addirittura schiavi in gioventù, hanno
ottenuto la libertà compiacendo in tutti i modi leciti e illeciti i loro
padroni e infine hanno raggiunto la ricchezza. Costoro mirano soprattutto a
fare sfoggio della loro opulenza invitando alla loro mensa personaggi di ogni
classe: nobili che non disdegnano l'invito perché con quegli arricchiti c'è
sempre qualche buon affare da combinare; antichi compagni di servitù che hanno
fatto fortuna come loro, poveri diavoli che vivono delle briciole di quei festini
e sono sempre pronti, in contraccambio, a fare qualsiasi servigio.
Di
educazione e di buon gusto non è più il caso di parlare, l'ostentazione di
lusso e di potenza diviene perfino brutale. Non a tutti, ad esempio, si servono
gli stessi cibi: i migliori sono riservati ai personaggi più importanti, quelli
di minor conto hanno portate più modeste e i poveri diavoli si devono
accontentare di quel che capita.
Il teatro
Un
nuovo divertimento è offerto dal teatro. L'antica commedia non interessa più e
neppure la tragedia, che ha avuto tuttavia un momento di popolarità nel primo
secolo dell'impero. Ma vi sono adesso rappresentazioni più spettacolari ed
anche più eccitanti: le "pantomime".
Si
tratta di recite senza parole, in cui appaiono anche le donne, cosa che non si
sarebbe neppur sognata nell'antico teatro, affidate solo alla mimica, alla
danza e alla musica. L'abilità degli attori consiste nel far capire agli
spettatori, con i soli gesti, il significato di quel che viene rappresentato,
in genere miti leggende dell'antica Grecia oppure della storia romana. La
pantomima in questa epoca è divenuta popolarissima. Gli attori più abili sono
segnati a dito e gli imperatori, a seconda che risultino loro graditi o
sgraditi, li colmano di doni o li condannano a morte. Dato il carattere
violento degli spettacoli popolari romani, nella pantomima si sono facilmente
infiltrati motivi sensazionali: giuochi acrobatici e addirittura episodi
cruenti. D'altra parte sono più che mai graditi gli spettacoli di gladiatori, che
vengono sacrificati a centinaia per il piacere di una folla che ormai esige
solo emozioni forti e brutali.
La cultura e il pensiero
Nel
mondo patrizio ci sono famiglie che mantengono gelosamente le antiche usanze e
le antiche tradizioni: anche nella sua fastosa decadenza, Roma è pur sempre
Roma.
Non
mancano gli studiosi che si appartano, padri di famiglia che dedicano la
maggior parte del loro tempo a scrivere le loro memorie o a meditare sulle
opere dei filosofi.
Perfino
alcuni imperatori, come il saggio Marco Aurelio, fanno degli studi la loro
attività preferita e cercano di essere giusti in tutte le loro azioni. E'
l'altro volto dell'epoca imperiale: ci si accorge che la vita va perdendo le
sue basi, che i costumi decadono, che le leggi morali si indeboliscono e si
cerca rifugio nella cultura e nella meditazione.
Purtroppo
tutto ciò non basta a far cambiare l'indirizzo che la vita ha ormai preso: la
cultura e la meditazione possono permettere ai migliori di difendere la propria
serenità e la propria saggezza, ma non riescono a far divenire serena e saggia
la capitale del mondo che si abbandona ai piaceri.
Tra
gli uomini di pensiero si va sempre più diffondendo una filosofia creata già da
alcuni secoli in Grecia, agli inizi della sua decadenza: quella filosofia
"stoica" che insegna a rendersi insensibili a tutto, al piacere come
al dolore, perché è l'unico modo di mantenere la propria serenità, di sottrarsi
alle follie e alle ingiustizie del mondo. Ma un simile modo di pensare aiuta
solo a sopportare i mali, non a superarli. D'altra parte anche la cultura di
questo periodo è sterile. Accumula nozioni, le ordina in trattati, ma non ne
trae nuovi orientamenti di vita.
La
letteratura è in grande decadenza anche perché adesso, quasi tutte le persone
colte parlano in greco e conoscono questa lingua meglio del latino.
Roma
ha perso la sua saggezza...
L'ombra cade su Roma
Nel
giro di pochi fastosi anni, Roma decade. La capitale dell'Impero romano si è
trasferito ad Oriente, a Costantinopoli, per ordine dell'ultimo Imperatore
romano Costantino. Insieme con la capitale, anche tutta la ricchezza si è
spostata: la città vede diminuire sempre più la sua popolazione e i suoi
traffici, non è più possibile arricchirsi con accordi fra uomini politici e
commercianti o appaltatori.
E
la vita di corte non esiste più, ora che l'imperatore è in Oriente e il suo
collega, che governa l'Occidente, ha posto la sua residenza a Milano, i ricchi
a Roma, sono adesso solo i grandi proprietari terrieri e gli alti funzionari
dello stato, eletti dagli imperatori.
Il
popolo minuto deve accontentarsi di sempre più rare distribuzioni di cibi e di
mediocri spettacoli circensi. La condizione delle classi umili è triste. Già da
tempo per impedire che gli artigiani meno fortunati abbandonassero il loro
mestiere e la loro residenza per cercare fortuna altrove, è stato stabilito che
nessuno possa cambiare attività e che i figli debbano esercitare lo stesso
mestiere dei padri. Molti riescono appena a vivere. Nelle campagne i contadini
sono ridotti praticamente in servitù lavorando per salari minimi le vaste terre
dei loro padroni.
Nella
totale decadenza del più grande impero che sia mai esistito, una nuova
religione ha contagiato milioni di anime. Arriva dalla Palestina, e ne è
profeta Gesù. Afferma l'amore tra i popoli, il perdono e altre regole scritte
nella Bibbia, il libro sacro dei Cristiani.
Non
so quanto questa trasformazione ideologica possa aver influenzato il
decadimento romano, resta comunque evidente che il Cristianesimo, (questa nuova
religione) aveva dato una speranza al popolo ormai ridotto alla fame.
L'ombra si è proiettata sulla città di Roma: è la sua fine.