

La struttura amministrativa imperiale
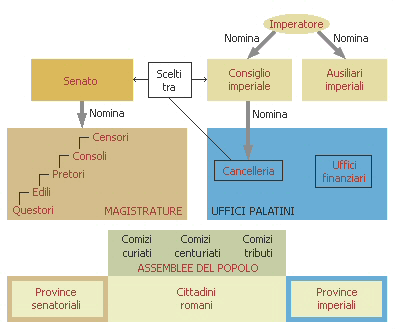
Nell’antica Roma il passaggio dall’età repubblicana a quella imperiale
avvenne senza rumore e senza traumi. La popolazione, esausta da decenni di
guerre civili, ben accettò le istanze di ordine e pace avanzate da Ottaviano
che parevano non mettere in discussione l’autorità delle tradizionali
istituzioni repubblicane. Senato, magistrature e assemblee popolari, pur continuando
a esistere a livello nominale nella medesima forma, vennero invece
progressivamente esautorate del potere esercitato nei secoli precedenti.
L’imperatore, circondato da fedeli funzionari, concentrò su di sé le principali
cariche del potere, acquisendo una sorta di ben mascherata onnipotenza
politica.
La
tetrarchia di Diocleziano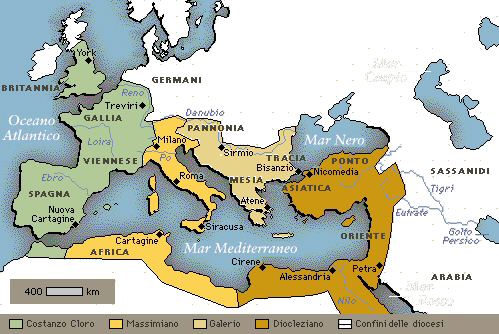
Nel corso del III secolo
l'impero romano attraversò una crisi profonda, caratterizzata da uno stato di
grave debolezza militare e politica e di caos amministrativo e istituzionale. A
questa situazione di continui disordini e di guerra civile, aggravata dalle
spedizioni di barbari che premevano ai confini, con imperatori eletti o deposti
dalle legioni senza che il senato riuscisse a imporre la propria volontà
(fenomeno che passò alla storia come "anarchia militare"), tentò di
mettere fine l'imperatore Diocleziano con l'istituzione della tetrarchia, un
sistema di governo a quattro che aveva lo scopo di ripristinare l'ordine entro
i confini dell'impero impedendo le lotte per la successione e assicurando un
funzionamento efficiente del potere imperiale. L'impero fu suddiviso in quattro
prefetture governate da due imperatori con il titolo di augusto (Diocleziano e
Massimiano) e da due cesari, associati al potere dai primi (Galerio e Costanzo
Cloro). La riforma di Diocleziano non diede tuttavia i risultati sperati: alla
morte dell'imperatore si scatenarono nuovamente sanguinosi conflitti per la
successione.