

L'attività edilizia romana
Il devastante incendio del 64 d.C., durante l’impero di Nerone, segnò
una nuova fase della vicenda urbanistica ed edilizia di Roma. La città venne
ricostruita secondo criteri di razionalità, sicurezza ed efficienza e quasi
ogni imperatore lasciò il proprio segno con edifici memorabili: la Domus Aurea
di Nerone, il Colosseo di Tito, il foro e i mercati di Traiano, il Pantheon di
Adriano, l’arco di Settimio Severo, le mura di Aureliano, le terme di
Diocleziano, l’arco di Costantino. La storia dello sviluppo urbanistico e
architettonico della città imperiale – che si arrestò nel 330 con
l’inaugurazione della nuova capitale, Costantinopoli – è raccontata nel brano
della Guida Rossa Roma del Touring Club Italiano.
L’attività edilizia dei 50 anni
che seguirono la morte di Augusto fu piuttosto contenuta. Determinante fu però,
a opera di Tiberio, la conferma del Palatino per la residenza imperiale, mentre
allo stesso Tiberio, oltre alla costruzione del tempio del Divo Augusto nel
Velabro e agli incentivi per la ricostruzione del Celio devastato da un
incendio (27 d.C.), si deve la grande caserma dei Pretoriani (“Castra
Praetoria”) edificata all’estremo margine nord-orientale dell’abitato con la
nuova tecnica dell’opus latericium destinata subito a notevole fortuna.
Un ampliamento verso il Foro
della residenza palatina, la prima edificazione del tempio di Serapide sulle
pendici occidentali del Quirinale e il parziale allestimento di un circo
privato (poi completato da Nerone) nei giardini di Agrippina nell’“ager Vaticanus”
furono le opere di Caligola. Quelle di Claudio: due nuovi acquedotti (“Aqua
Claudia” e “Anio Novus”) e un ulteriore ampliamento del pomerio che finalmente
incluse l’Aventino, devastato da un incendio e ricostruito come quartiere
aristocratico; subito dopo la morte dell’imperatore fu avviata la costruzione
di un grandioso tempio a lui dedicato, all’estremità nord-occidentale del
Celio, al centro di una vasta area libera, circondata e sostenuta da un
poderoso muro, con prospetto a due ordini d’arcate, in travertino.
Alcune importanti opere furono
realizzate nel decennio iniziale del principato di Nerone: un edificio termale
nel Campo Marzio, che introdusse nella tipologia balneare il criterio della
distribuzione regolare e simmetrica degli ambienti; un nuovo mercato coperto
(“Macellum Magnum”) sul Celio; e la prima vera e propria reggia (“Domus
Transitoria”) risultante dall’unificazione dei nuclei palatino ed esquilino
delle proprietà imperiali. Ma al nome di Nerone è legato l’inizio di una nuova
fase della storia urbanistica ed edilizia di Roma, in conseguenza dell’incendio
che nel luglio del 64 devastò 10 delle 14 regioni urbane.
La catastrofe segnò la fine di
una città incessantemente cresciuta in modo irregolare e disordinato, anche se
la ricostruzione non fu scrupolosamente attuata con quei criteri di razionalità
ed efficienza (ampiezza delle aree aperte e altezza limitata degli edifici e
loro isolamento, abbandono del legno e di altri materiali facilmente
infiammabili e uso generalizzato della pietra e dei mattoni, diffusione dei
portici al pianterreno dei caseggiati ecc.) che pure furono dettati per la
“nova urbs”. Furono soprattutto d’impedimento, nei quattro anni residui del
principato di Nerone, gli ingenti e onerosi lavori per la realizzazione della
nuova sontuosa dimora imperiale (Domus Aurea) che, estesa per una superficie di
oltre 100 ettari su buona parte del vecchio nucleo urbano – dal Palatino
all’Esquilino e al Celio – comprese costruzioni di vario genere (residenziali,
di rappresentanza e di svago, con sequenze e prospettive offerte dalla natura e
dall’artifizio) in mezzo ad ampi spazi aperti, con boschi e giardini e un lago
artificiale contornato di padiglioni.
La vera ricostruzione della città
fu pertanto opera dei tre successivi imperatori Flavi, che dovettero anche far
fronte alle conseguenze di altri due gravi incendi (del Campidoglio nel 69 e
del Campo Marzio e ancora del Campidoglio nell’80). Così Vespasiano e Tito (ai
quali si deve anche un allargamento del pomerio) provvidero in primo luogo a
restituire al pubblico godimento gli spazi urbani sottratti da Nerone, facendo
rientrare la reggia nei limiti del Palatino e smantellando la Domus Aurea
tranne l’edificio, nemmeno terminato, del colle Oppio. Poi, a sottolineare il
loro programma in termini di “servizi pubblici”, fecero costruire, al posto del
lago neroniano e col massimo sfruttamento della tecnica costruttiva basata
sull’arco e sulla volta per ottenere insieme praticità e sicurezza, il
grandioso Anfiteatro Flavio (o Colosseo) – inaugurato da Tito l’anno 80 –
quindi restaurare il tempio di Giove Capitolino e ripristinare quello del Divo
Claudio, che Nerone aveva trasformato in ninfeo; realizzare, sulle pendici del
“Fagutal”, l’edificio termale (terme di Tito) forse già previsto per la Domus
Aurea; infine costruire, al posto dell’antico “Macellum” bruciato nell’incendio
del 64, il tempio (o foro) della Pace, che con la sua ampia corte simile a una
piazza forense, dotata su un lato di una cella templare affiancata da grandi
aule, venne a costituire, con i vicini fori di Augusto e di Cesare e con
l’adiacente Foro Romano, un complesso sostanzialmente unitario.
Il completamento della
ricostruzione e il nuovo assetto della città sono opera di Domiziano. Questi,
ultimato il Colosseo con un sistema di gallerie per i servizi, aggiunse tra
l’Oppio e il Celio un “quartiere attrezzato” formato da quattro caserme-scuola (“Ludi”)
e un ospedale (“Saniarium”) con obitorio (“Spoliarium”) per i gladiatori, un
magazzino per le armi (“Armamentarium”) e uno per i macchinari scenici (“Summum
Choragium”) e una caserma per i marinai addetti al “velario” (“castra
Misenatium”). Sempre nella zona centrale della città, tra il Colosseo e il
Palatino, fece rifare la fontana monumentale della “Meta Sudans” ed erigere
l’arco in onore di Tito, mentre per sistemare lo spazio rimasto tra il foro di
Augusto e il tempio della Pace, percorso dall’antichissima via
dell’“Argiletum”, dette inizio alla costruzione di un nuovo foro (“Forum
Transitorium”, poi inaugurato da Nerva che gli dette il suo nome), lungo e
stretto, senza portici ma con colonnato sporgente dalle pareti e con il tempio
di Minerva sul fondo. Si procedeva intanto alla ricostruzione del Campidoglio
(con un nuovo rifacimento del tempio di Giove) e del Campo Marzio dove, oltre
alla riparazione dei danni degli incendi e al rifacimento dell’Iseo Campense,
furono edificati ex novo lo stadio, l’odeon, il portico dei Due Divi col tempio
di Minerva, e il tempio della Fortuna Reduce. Ma l’intervento più significativo
di Domiziano fu la costruzione del vero e proprio Palazzo imperiale che con la
residenza ufficiale (“Domus Flavia”) e quella privata (“Domus Augustana”)
occupò tutta la parte centrale del Palatino e, con terrazzamenti e piani
diversi e una facciata a esedra, anche le pendici verso il Circo Massimo: una
situazione che favorì prospettive ed effetti di scorcio che andarono ad
aggiungersi a una generale concezione simmetrica degli spazi e alla ricerca di
formule planimetriche mistilinee.
Nel II secolo Roma raggiunse i
vertici della sua espansione urbana e monumentale (nonché demografica, avendo
certamente superato il milione di abitanti). Al principio del secolo, con
Traiano, oltre al restauro dei fori di Cesare e di Augusto, della casa delle
Vestali e del Circo Massimo, si ebbe la creazione del più grandioso dei fori
imperiali (foro di Traiano) per il quale il poco spazio disponibile in una zona
ormai tutta edificata fu ampliato con lo sbancamento della sella tra il
Quirinale e il Campidoglio, che portò pure all’eliminazione del diaframma che
separava la città vecchia da quella nuova del Campo Marzio.
La costruzione del “centro
commerciale” dei mercati di Traiano – il maggiore e più razionale dei complessi
di pubblica utilità, dalle geniali e ardite soluzioni struttive e dalla
spazialità di grande respiro – fatto di edifici a più piani, di esedre e di
aule voltate e includente un paio di strade, sulle pendici tagliate a terrazze
del Quirinale, si accompagnò a quella del foro che, oltre alla solita piazza,
porticata e dotata di due grandi esedre, comprendeva la monumentale “basilica
Ulpia” a due absidi contrapposte, con le annesse biblioteche e la colonna
coclide istoriata.
Altri notevoli interventi
traianei furono la ristrutturazione delle installazioni del porto fluviale, la
costruzione di un nuovo acquedotto (“Aqua Traiana”) e, sul colle Oppio, sopra
il palazzo della Domus Aurea definitivamente smantellato e interrato, quella di
un altro edificio termale che, ampliato l’organismo balneare con un sistema di
spazi aperti circondati da un recinto, fissava la tipologia della grande terma
imperiale.
Con l’impero di Adriano e degli
Antonini, mentre nell’edilizia privata si diffondono, anche a formare nuovi
“quartieri razionali” (come quello tra la “via Lata” e il Quirinale), i
caseggiati a più piani, dotati di portici e di botteghe e separati tra loro da
brevi strade ortogonali, l’edilizia monumentale raggiunge il vertice con il
Pantheon rifatto da Adriano (118-125), capolavoro assoluto, di idea
architettonica e d’ingegneria, con la sua dimensione spaziale interna
perfettamente sferica e avvolgente (e il “compromesso” classicistico del pronao
colonnato di tipo tradizionale). Si aggiungano i nuovi templi di Matidia, di
Adriano (con la novità della cella voltata) e di Marco Aurelio nel Campo
Marzio, di Antonino e Faustina nel Foro Romano, di Traiano a conclusione del
foro omonimo e quello colossale, a due celle addossate per le absidi, di Venere
e Roma sulla Velia (privo del podio della tradizione romana e con chiara
propensione per le forme elleniche, secondo l’atteggiamento classicistico e
intellettualistico di Adriano); e ancora i restauri dei palazzi del Palatino,
la seconda colonna coclide in onore di Marco Aurelio nel Campo Marzio (dai
rilievi che, con la novità del disfacimento delle forme organiche del
precedente stile classicistico, denunciano precisi intenti pittorici di tipo
“espressionistico”) e il nuovo grandioso mausoleo dinastico fatto costruire da
Adriano nei giardini di Domizia, sulla riva destra del Tevere, con un ponte
(“pons Aelius”) per collegarlo alla città.
Durante il regno di Commodo un
ennesimo incendio dà luogo a un’altra serie di restauri e ricostruzioni nella
zona fra il tempio della Pace e il portico di Ottavia, insieme ai quali
Settimio Severo provvede a far costruire una nuova ala del Palazzo imperiale su
gigantesche sostruzioni ad arcate, il colossale ninfeo del “Septizodium” tra il
Palatino e il Celio, la caserma “nuova” degli “equites singulares” (la guardia
imperiale) nella zona del Laterano, la villa del “Sessorium”, col piccolo
Anfiteatro Castrense, all’estremità orientale del Celio, mentre un arco
trionfale a tre fornici, interamente rivestito di rilievi affollati e pieni di
movimento per il continuo e accentuato alternarsi delle luci e delle ombre,
viene eretto in suo onore nel Foro Romano.
Il III secolo inizia con la
costruzione delle grandiose Terme Antoniniane (inaugurate da Caracalla nel 217
con l’antistante “via Nova”) e il rifacimento del colossale tempio di Serapide
sul fianco del Quirinale. Ma subito dopo – a causa della crisi economica e
sociale che investe l’Impero e con gli imperatori quasi sempre occupati a
salvare il trono dai concorrenti e a difendere i confini dalla pressione dei
Barbari – l’attività edilizia subisce un generale rallentamento, interrotto da
singoli episodi: il tempio di Elagabalo, costruito sul Palatino dall’imperatore
omonimo; l’undicesimo e ultimo acquedotto (“Aqua Alexandrina”) voluto da
Alessandro Severo che provvide pure al rifacimento delle Terme Neroniane; le
terme dell’imperatore Decio sull’Aventino e il tempio del Sole inaugurato in
Campo Marzio, nel 274, da Aureliano. Ma l’unica vera novità che
emblematicamente caratterizza il periodo è quella della cinta muraria con la
quale, tra il 271 e il 275, lo stesso Aureliano cinge Roma lungo un percorso di
quasi 19 km: 650 anni dopo quelle repubblicane, le mura Aureliane racchiudono, su
una superficie di circa 1400 ettari, una città quale non s’era mai vista sulla
faccia della terra, segnandone in maniera tangibile la misura dei vasti
confini, ma decretandone al tempo stesso l’arresto e il ripiegamento su se
stessa.
L’ultima sostanziosa ripresa
d’iniziative edilizie si ha tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, con
l’avvento della tetrarchia dioclezianea e poi con l’impero di Costantino. Dopo
la ricostruzione degli edifici colpiti dall’incendio del 283 (tempio di Saturno
e Curia del Senato, foro di Cesare, teatro di Pompeo ecc.), si susseguono:
l’edificazione delle terme di Diocleziano (il più grande di tutti i complessi
termali romani) nella zona “periferica” nordorientale della città; il
rifacimento, a opera di Massenzio, del tempio di Venere e Roma, e la
costruzione, per iniziativa dello stesso imperatore, della grandiosa “basilica
Nova” (detta poi anche di Costantino) sulla Velia, nuova splendida espressione
di straordinaria genialità spaziale e vistoso esempio di quelle caratteristiche
di compattezza e unitarietà che contraddistinguono tutti gli edifici della
tarda età imperiale; le terme sul Quirinale e la via porticata ai piedi dello
stesso colle, a opera di Costantino, e, infine, l’arco onorario dedicato a
quell’imperatore dal Senato nel 315, accanto al Colosseo, col quale inizia
l’uso di riutilizzare vecchi monumenti per crearne di nuovi.
La fine della storia urbanistica
ed edilizia dell’Urbe per l’evo antico si ha quando, nel maggio del 330,
proprio Costantino inaugura la nuova capitale sulle rive del Bosforo. Nei due
secoli (IV e V) che segnano il passaggio all’evo medio, pur restando
sostanzialmente intatto l’antico impianto urbano, la città cambia volto per
adeguarsi alle sopraggiunte esigenze del Cristianesimo trionfante; anche se i
nuovi interventi, a cominciare da quelli costantiniani (come la costruzione
della cattedrale di San Giovanni nel sito delle case dei Laterani e della
caserma degli “equites singulares”) sono realizzati in zone marginali per
evitare ogni competizione coi monumenti del passato. Così, mentre comincia a
delinearsi quella che sarà la Roma dei papi, alla Roma dei cesari le autorità
civili si limitano a dedicare ancora per qualche tempo solo saltuari lavori di
manutenzione e di restauro, il più importante e impegnativo dei quali sarà,
all’inizio del V secolo, il radicale rinforzo delle mura promosso da Onorio.
Cosa che tuttavia non basterà a impedire alla città il sacco dei Goti nel 410 e
quelli, anche più pesanti, dei Vandali nel 455 e nel 472. Gli ultimi restauri,
eseguiti per lo più con materiali tratti da monumenti abbandonati, furono
promossi dal re ostrogoto Teodorico quando ormai da un quarto di secolo era
tramontato, anche ufficialmente (476), l’Impero d’Occidente e iniziato il
Medioevo.
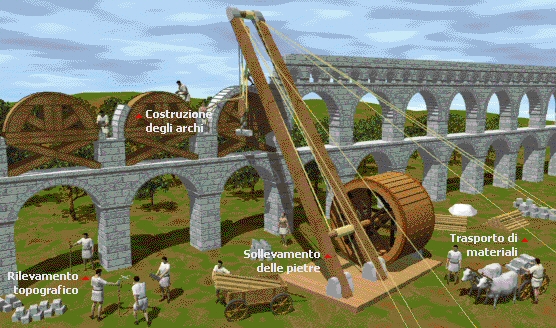
Acquedotto romano
I
romani furono abili ingegneri e architetti: per le loro grandiose opere
pubbliche, conservatesi nei secoli, svilupparono tecniche di costruzione
efficaci e innovative. Tra le imprese maggiori figurano gli acquedotti, che
erano in grado di trasportare acqua dalle fonti di montagna fino alle aree
abitate più lontane, rifornendo grandi città come Roma. I canali
dell'acquedotto correvano alla sommità di enormi archi di pietra. Esperti
geometri e topografi, detti gromatici, dirigevano la costruzione di queste
massicce opere murarie utilizzando strumenti molto precisi, come la groma, che
consentiva di tracciare linee dritte e determinare angoli retti. Gli operai
erano in grado di sollevare pesanti pietre grazie a imponenti gru mosse da
ingranaggi rotanti azionati da schiavi. Una volta raggiunta la città, l'acqua
veniva raccolta in bacini e vasche e quindi distribuita attraverso un elaborato
sistema di tubi sotterranei, che alimentavano fontane, bagni pubblici e
lavatoi. Roma era servita da ben 24 acquedotti, che portavano 984 milioni di
litri d'acqua al giorno.
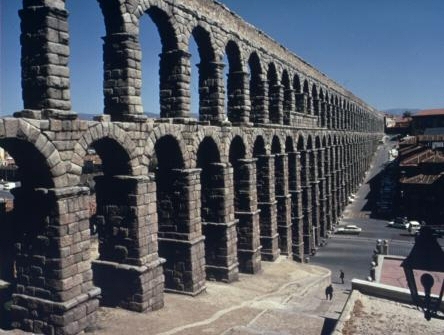
Acquedotto romano, Segovia
Con
la vittoria riportata nella seconda guerra punica, i romani sconfissero i
cartaginesi e fecero della penisola iberica una provincia. Il dominio di Roma,
protrattosi fino all'inizio del V secolo, è testimoniato da numerosi resti
archeologici. Nella foto, il grandioso acquedotto di Segovia, tuttora
funzionante, che costituisce il maggiore monumento romano della penisola
iberica.
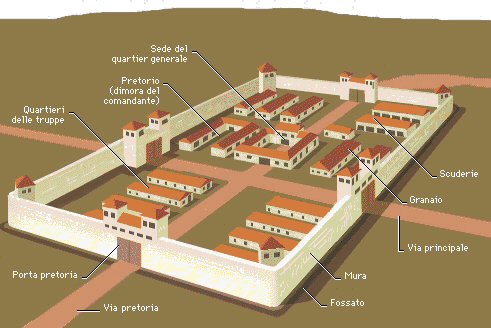
Castrum romano
Lo
schema tipico di un castrum romano prevedeva due vie principali: la via
pretoria, che attraversava l'accampamento in senso longitudinale, e,
perpendicolare a questa, la via principale. In prossimità del punto di
intersezione fra le due vie si trovava la sede del comandante della legione.

Accampamento romano,
Northumberland
Il castrum
romano di Housesteads, nel Northumberland, era uno degli accampamenti stabili
in cui erano acquartierate le legioni che difendevano il vallo di Adriano.
Nella foto si distingue il praetorium, sede del comandante della
legione.
Insula romana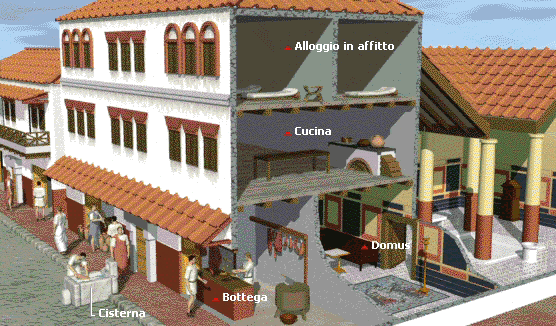
Nelle
città dell'impero romano, solo i ricchi nobili potevano permettersi case di
proprietà (domus), spesso decorate e arredate lussuosamente. I cittadini
meno abbienti abitavano invece in appartamenti in affitto, ricavati da edifici
a più piani, detti insulae, simili ai moderni condomini. In alcuni casi,
il piano terra dell'insula era una domus privata, che poteva
svilupparsi anche su più piani e con un'ala indipendente. Gli ambienti della domus
erano disposti solitamente attorno a un cortile interno. L'ingresso introduceva
nell'atrium (atrio), una stanza con un'apertura nel soffitto, sotto la
quale una vasca, detta impluvium, raccoglieva l'acqua piovana; lungo una
parete si trovava un piccolo sacrario dedicato ai Lari (divinità
familiari). Tra le altre stanze, spiccava per eleganza la sala da pranzo, detta
triclinium, dove si riunivano i componenti della famiglia insieme ai
loro ospiti, accomodati su letti e cuscini; nella cucina, molto funzionale, il
cibo veniva cotto nel carbone o su piani in pietra riscaldati da fuoco vivo. Le
abitazioni più modeste erano invece ai piani superiori dell'insula,
spesso arredate in modo molto essenziale, con semplici pagliericci e qualche
sedia (ad esempio del tipo pieghevole a quattro gambe incurvate, noto come sella),
senza ambienti riservati al pranzo o alla cucina. I locali del piano terra
affacciati sulla strada erano sovente botteghe, nelle quali macellai, fornai e
artigiani lavoravano e vendevano la loro merce. Nelle immediate vicinanze, una
cisterna conteneva l'acqua necessaria a tutti gli abitanti dell'insula.
Villa romana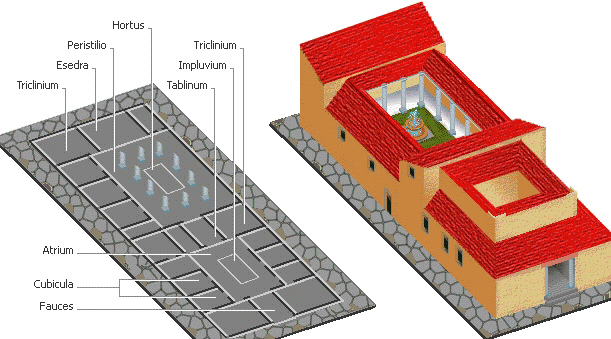
A
Pompei sono state riportate alla luce molte ville romane dotate di peristilio,
come quella che si vede in questa ricostruzione. Alla casa si accedeva
attraverso le fauces, il corridoio d'ingresso; subito dopo si apriva l'atrium,
un cortile al cui centro sorgeva una vasca, detta impluvium, che
raccoglieva l'acqua piovana. Intorno all'atrium si aprivano le camere da
letto, dette cubiculae, le alae, stanze in cui si onoravano gli
avi e gli dei domestici protettori della casa, e una o più sale da pranzo (triclinium).
Dall'atrium si accedeva al peristilio, portico colonnato che circondava
il cortile interno, attraverso il tablinum, la sala dei ricevimenti del
padrone di casa. Intorno al peristilio, che in genere racchiudeva un giardino (hortus)
o una piscina, si aprivano altri locali adibiti ad abitazione o ad esercizio
commerciale; all'estremità dell'edificio, infine, si trovava l'exedra,
sala di soggiorno e di ritrovo che da un lato dava sul peristilio.
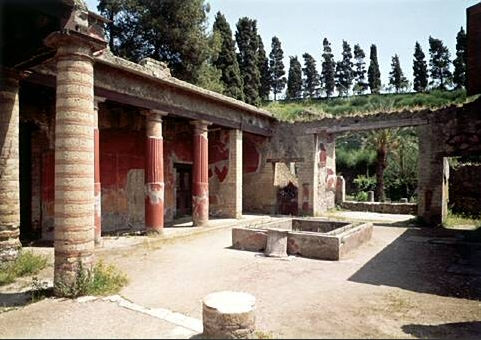
Resti di villa romana,
Ercolano
In
molte case romane come questa di Ercolano, che risale al periodo tra 200 e 80
a.C., si entrava attraverso un atrium, una specie di cortile interno
circondato da un portico e con una fontana al centro. In genere le pareti erano
intonacate e successivamente decorate con affreschi.
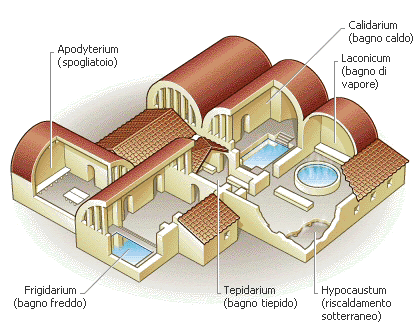
Terme romane
Le
terme rivestirono un ruolo centrale nella vita quotidiana di Roma fin dall'età
repubblicana; con l'espansione dell'impero, la consuetudine di recarsi
regolarmente ai bagni pubblici si diffuse in tutti i territori conquistati,
portando alla costruzione di grandi e spesso sontuosi complessi termali, anche
nelle province più lontane dall'Urbe. Nonostante l'estensione e l'articolazione
delle terme potesse variare notevolmente, la loro struttura architettonica
prevedeva sempre alcuni ambienti adibiti a precise funzioni, come l'apodyterium
(spogliatoio), il calidarium (sala per il bagno caldo), il frigidarium
(sala con vasca di acqua fredda), il tepidarium (sala per il bagno
tiepido), il laconicum (stanza per il bagno di vapore). Il riscaldamento
delle sale e dell'acqua delle piscine era ottenuto attraverso l'aria calda che
correva in condutture sotto il pavimento, proveniente dall'hypocaustum
(ipocausto), una camera sotterranea in cui si accendeva il fuoco. Le terme
potevano inoltre includere palestre per esercizi ginnici, gallerie coperte per
brevi passeggiate, varie sale per incontri e ritrovi.
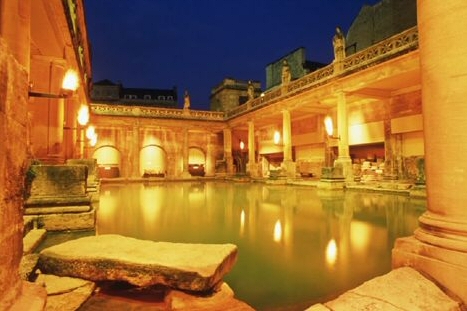
Terme Romane, Bath
Le
Terme Romane sono le più spettacolari tra quelle che si trovano nella città
termale di Bath, nell'Inghilterra occidentale. Cadute in disuso in seguito al
ritiro dei romani, rimasero sepolte per secoli finché furono portate alla luce
e riattivate, nel 1755: fu allora che venne aggiunta la cosiddetta Pump Room,
nella quale le persone si ritrovavano per fare conversazione e bere le acque
terapeutiche pompate appunto dalla sorgente sottostante. Oggi nelle antiche
terme della città scorrono oltre 22 milioni di litri d'acqua alla temperatura
di 49°C.