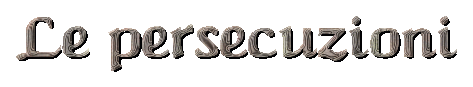
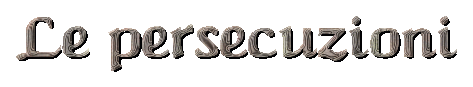
Augusto era riuscito a coinvolgere nel suo programma di bonifica morale alcuni fra i nomi più prestigiosi del mondo culturale romano come Virgilio e Orazio, letterati che appartenevano a quella generazione che visse con drammatica intensità gli anni sanguinosi delle guerre civili e che vide, quindi, in Augusto il deus praesens, capace di portare finalmente la pace. Subentrò poi la generazione di coloro che alla morte di Cesare non erano ancora nati, che vissero nella pace augustea, e furono animati solo dal desiderio di abbandonarsi al presente. Ovidio fu il poeta-cantore di questa generazione caratterizzata dalla sfrenata dissacrazione di valori e di dilagante permissività, in cui Augusto fu costretto a constatare il fallimento del suo programma. Allora è facile comprendere perché nell’8 d.C. relegò a Tomi Ovidio, che, come dice Boissier "pagò per sé e per la società intera", fu allontanato da Roma perché si opponeva all’ideologia ufficiale rifiutandone i modelli etici. Il caso Ovidio è, allora, sintomatico del rapporto che venne delineandosi sempre più evidente tra potere politico e letteratura, tanto più che non rimane isolato, poiché Augusto intervenne anche nel 12 d.C., condannando al rogo le opere di Tito Labieno, che per protesta si lasciò morire nella sua tomba di famiglia, e Cassio Severo, esiliato a vita. Dopo la morte di Augusto il rapporto potere-intellettuale rimase il medesimo: gli intellettuali devono scegliere tra il conformismo e la rischiosa ricerca della propria autonomia.
Tiberio, successore di Augusto, bandì dall’Italia gli attori che si erano permessi allusioni satiriche nei suoi confronti; fece imprigionare e strangolare un poeta che lo aveva denigrato, e ne suppliziò un altro, per lo stesso motivo, facendolo gettare giù dalla rupe Tarpea. Condannò al rogo le opere di Aulo Cremuzio Cordo e Mamerco Emilio Scauro, incriminati per lesa maestà, anche se in realtà il primo non aveva fatto altro che esaltare i cesaricidi in un’opera filo-repubblicana, e il secondo aveva fatto alcune affermazioni antitiranniche nella tragedia Atreus; entrambi prevennero la condanna dandosi volontariamente la morte. Anche durante il breve regno di Caligola si verificarono episodi simili. L’imperatore condannò all’esilio un retore che si era scagliato contro i tiranni e fece bruciare vivo, al centro dell’anfiteatro, un poeta ob ambigui ioci versiculum "per un verso che conteneva una battuta a doppio senso" (Svetonio). Inoltre costrinse i concorrenti risultati i peggiori in una gara di eloquenza greca e latina a cancellare i loro scritti con la spugna o con la lingua per non essere torturati o uccisi.