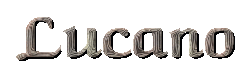
Marco Anneo Lucano nacque a Cordova il 3 dicembre del 39 d.C. dalla
famiglia degli Annei, una delle più illustri della città. Nonno paterno gli era Anneo
Seneca retore, cavaliere romano; zio paterno Anneo
Seneca il filosofo. Già nel primo anno d’età fu condotto a Roma. Nel 49
d.C., al ritorno dall’esilio dello zio Seneca, riprese la stretta comunanza di vita
fra i due.
Fu allievo del filosofo storico Anneo Cornuto e frequentò le lezioni del grammatico
Remmio Palemone. Seneca lo fece entrare nella cohors amicorum di Nerone, cui era
unito dalla inclinazione alla poesia (cfr. Tac. Ann, XIV, 16). L’anno
60 rappresenta il momento determinante dell’ascesa di Lucano: è l’anno della
celebrazione dei Neronia, ludi quinquennali istituiti da Nerone secondo la moda greca, in
cui Lucano viene premiato per le sue Laudes Neronis, prima prova ufficiale del suo
ingegno poetico. Probabilmente nel 61-62, Nerone gli conferì l'onore della questura. Nel
62 divenne augure, ma già in quell’anno, in seguito al secessus di Seneca,
cominciò il distacco di Lucano da Nerone.
I biografi antichi danno della rottura motivazioni personali, in particolare la gelosia
dell’imperatore per i successi letterari di Lucano, mentre alcuni studiosi moderni
preferiscono interpretare la rottura in chiave politica, indicandone la probabile causa
nelle posizioni filorepubblicane assunte dal poeta nel Bellum Civile.
Nel 65, in seguito alla scoperta della congiura dei Pisoni, Lucano (che secondo Svetonio
fu uno dei promotori), fu costretto come Seneca a darsi la morte.
Svetonio e Tacito riferiscono che il poeta, ingannato dalla falsa promessa
dell’impunità, giunse a denunciare falsamente come complice la madre. Di fronte alla
morte, tuttavia, dimostrò fierezza e coraggio: inviò al padre disposizioni relative alla
correzione di alcuni versi della sua opera; dunque, dopo aver banchettato lautamente, si
fece tagliare le vene dal medico recitando un passo in cui aveva descritto la morte per
dissanguamento di un soldato; quelle furono, secondo Tacito, le sue ultime parole (Tac.
Ann, XV, 70).
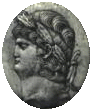
Il poema di Lucano, così come ci è pervenuto, in 10 libri, comprende gli avvenimenti della guerra civile dall’anno 49 al 48, ed è tramandato dai codici con il titolo Bellum Civile, ma è noto anche come Pharsalia, titolo forse derivato dall’espressione
Pharsalia nostra vivet, et a nullo tenebris damnabimur aevo
"La nostra Farsaglia vivrà e nessuno ci condannerà alle tenebre"
(IX, vv. 985 sg.),
con cui Lucano definisce il suo poema. Da un’attenta analisi della
struttura del Bellum Civile sembra probabile che il poema sia
composto da tetradi. Noi possediamo due tetradi intere (libri 1-4 e 5-8) e una incompiuta
(libri 9-10). Ponendo a base del poema questo tipo di struttura, si sono elaborate diverse
ipotesi. La prima ipotesi è che il piano originario del poema comprendesse 4 tetradi,
ossia 16 libri: la prima (1-4), si conclude con la morte di Curione (che aveva spinto
Cesare alla guerra civile), la seconda (5-8), con la morte di Pompeo a Farsalo. La fonte
storica principale di Lucano, Livio, aveva trattato nei libri 109-116 della sua opera
(libri che sono per noi, com'è noto, perduti) la guerra civile tra Cesare e Pompeo fino
alla morte di Cesare. Questi 8 libri circolavano probabilmente come opera a sè, con il
titolo di Bellum Civile, e dall'epitome di Floro, relativa a
questa sezione della storia di Livio, si deduce che ogni tetrade di Lucano corrisponde a
circa un quarto della trattazione liviana: di qui l’ipotesi che l’opera di
Lucano si estendesse fino al sedicesimo libro ed esaurisse pienamente la materia liviana.
La terza tetrade (9-12) si sarebbe dovuta concludere con la morte di Catone ad Utica, la
quarta (13-16), con la morte di Cesare. La struttura del poema sarebbe, pertanto, divisa
in quattro grandi blocchi, scanditi dalla morte dei protagonisti della guerra civile, con
alcuni finali tragici che corrisponderebbero sia al tema retorico dell’età imperiale
dell’exitus illustrium virorum, sia al concetto stoico e soprattutto senecano
secondo cui la morte è il banco di prova della virtus di un uomo.
A questa ipotesi si può accostare quella che indica il termine del poema nel libro
dodicesimo, concluso con la morte di Catone, mentre meno fondate ci sembrano altre
soluzioni prospettate, ossia che il poema si estendesse fino alla battaglia di Filippi (42
a.C.) o addirittura a quella di Azio (31 a.C.).
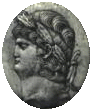
I LIBRO: Proemio ed elogio di Nerone, ritratti dei due antagonisti Cesare e Pompeo. Ha poi inizio il racconto vero e proprio con l’invasione dell’Italia da parte di Cesare.
II LIBRO: Inizialmente viene sviluppato il tema degli orrori delle guerre civili. Segue un incontro tra Bruto, incerto se partecipare alla guerra, e Catone che sostiene il dovere di impegnarsi al fianco di Pompeo e del Senato. Termina con la fuga dall’Italia da parte di Pompeo.
III LIBRO: Appare a Pompeo il fantasma della moglie Giulia, che gli rinfaccia di aver sposato un’altra donna e gli dice che lo perseguiterà inesorabilmente. Il libro termina col catalogo dei popoli orientali che aderiscono alla causa di Pompeo.
IV LIBRO: Vengono narrate le operazioni militari prima in Spagna e poi in Africa, dove il cesariano Curione trova la sconfitta e la morte.
V LIBRO: Viene descritta la consultazione dell’oracolo delfico da parte del pompeiano Appio. Il libro si conclude con l’episodio di Cesare sorpreso nell'Adriatico da una terribile tempesta da cui si salva prodigiosamente.
VI LIBRO: I due protagonisti si affrontano direttamente a Durazzo; quindi la guerra si sposta in Tessaglia (excursus geografico sulla regione). La seconda metà del libro è occupata dalla consultazione da parte di Sesto, figlio di Pompeo, della maga tessala Eritto, esperta di magia nera.
VII LIBRO: Il centro di questo libro è la battaglia di Farsalo, a cui Lucano, discostandosi vistosamente dalla verità storica, fa partecipare anche Cicerone. Varie fasi della lotta e sconfitta di Pompeo. Saccheggio dell’accampamento pompeiano.
VIII LIBRO: Pompeo, con la moglie Cornelia, si rifugia in Egitto dove viene ucciso a tradimento da un sicario del re Tolomeo. Morte di Pompeo.
IX LIBRO: Il poeta afferma che l'anima di Pompeo si involò per posarsi nei petti di Bruto e di Catone, che da questo momento diventa l’antagonista di Cesare e l’eroe del poema. Egli giunge in Africa per rendere gli estremi onori a Pompeo. Cesare arriva in Egitto e gli viene mostrato il capo mozzato di Pompeo.
X LIBRO: Cesare visita la tomba di Alessandro Magno. Cleopatra si presenta a Cesare e lo seduce; il poeta descrive il lusso sfrenato e scandaloso in mezzo al quale si svolgono gli amori tra il romano e la regina egiziana. Segue una lunga digressione sulle sorgenti del Nilo. Viene poi narrata la congiura ordita dai cortigiani egiziani contro Cesare e la guerra che ne consegue, all’inizio della quale il poema s’interrompe.
Così si chiude il poema lucaneo, ma esso è un opus crescens, un'opera che mostra chiari segni di evoluzione e mutamento nel corso del lavoro, sia nell’interpretazione dei personaggi sia nell’impostazione ideologica, sotto la spinta, probabilmente, della vicenda umana di Lucano e del suo dissenso crescente e sempre più esplicito nei confronti di Nerone. Il poema non fa perno su un eroe, come ad esempio nell'Eneide, intorno al quale l’azione si svolge nella sua unità. Qui il personaggio unico è il popolo romano: le altre figure sono di sfondo. Pompeo inizialmente incarna i valori positivi in opposizione a Cesare, immagine di eroe negativo. Ma nel corso della vicenda, la causa di Pompeo tende a identificarsi sempre più chiaramente con la causa della res publica, inesorabilmente destinata alla disfatta, e la sua figura acquista pertanto tratti sempre più patetici. Positiva è la figura di Catone, che per Lucano rappresenta allo stesso tempo il campione della legalità repubblicana e l’incarnazione del sapiente stoico:
...Hi mores, haec duri inmota Catonis
secta fuit, servare modum finesque tenere
naturamque sequi patriaeque inpendere vitam
nec sibi, sed toti genitum se credere mundo.
"Questi sono i costumi, questi gl'irremovibili principi
del severo Catone: serbare la giusta misura, rispettare i limiti, seguire la natura, sacrificare la vita per la patria
e non ritenersi generati per sé, ma per il mondo intero" (II, 380-383).
Anche la figura di Catone partecipa di quella dimensione grandiosa e titanica che caratterizza il Bellum civile e che in lui si traduce nella dismisura di un’immensa statura morale capace di condannare i giudizi del fato:
Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni.
"La causa dei vincitori piacque agli dei, ma quella dei vinti a Catone" (I, 128).