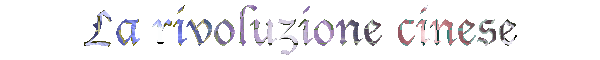
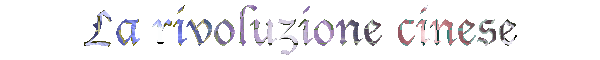

La Rivoluzione culturale Cinese
La Cina, che oggi è una grande potenza capitalistica mondiale, quasi da
competere con le vecchie potenze arrivate ad esserlo secoli prima, all'inizio di
questo secolo si presentava in condizioni miserevoli a causa delle costrizioni
che le erano state imposte fin dalla Guerra dell'Oppio dagli Stati imperialisti;
la bancarotta e il crescente sfruttamento del contadiname sembravano incurabili.
L'immensa maggioranza della popolazione era composta di contadini, dei quali la
metà non avevano terra e dovevano pagare, oltre alle imposte, una percentuale
del raccolto al proprietario come canone di affitto del campo. Il primo episodio
della rivoluzione borghese risale al 1911 con la proclamazione della Repubblica
cinese da parte di Sun Zhong Shan, successivamente fondatore del Guo Min Dang o
partito nazionalista. Dietro a Sun stava la spinta della grande borghesia
cinese, però estremamente debole. Questa borghesia che si era arricchita al
tempo dell'Impero con il commercio con gli occidentali dove si trovava una
produzione capitalista e un moderno proletariato, fu però capace di imprimere un
carattere unitario nazionale necessario per seppellire l'Impero, anche grazie
all’ estrema debolezza del corrotto e decrepito suo apparato. Se i rivoluzionari
Tai Ping e il movimento dei Boxer del secolo XIX ebbero l’appoggio popolare
mancò loro una struttura organizzata, invece alla repubblica di Sun, che metteva
fine al millenario impero, mancò la mobilitazione delle masse. I tre princìpi
che Sun propugnava: nazionalismo, democrazia e pane al popolo, erano quelli di
qualunque rivoluzione borghese in un paese lacerato dall'imperialismo e
arretratissimo in confronto alle forme di produzione rispetto al capitalismo
occidentale. Nella Cina di allora incombevano due compiti intrascurabili: 1)
assicurarsi l'indipendenza nazionale, 2) attuare la riforma agraria, premessa
per lo sviluppo industriale. L'estrema debolezza della classe borghese, come in
Russia, la rendeva impotente a mobilitare la immensa massa dei contadini per
espropriare la terra ai fondiari e ripartirla, mettendo cosi fine all'indicibile
oppressione del contadino. La situazione in Cina rispetto alle relazioni con le
potenze coloniali e le sue relazioni sociali interne non cambiarono. Alla
popolazione non bastava il TOT di cibo che il partito aveva imposto e per questo
morirono migliaia di persone.
Appena dopo un anno Sun si vide obbligato a rinunciare alla presidenza della
repubblica a favore del grande capo militare del vecchio regime Yuan Shikai, il
quale col controllo degli eserciti disponeva del potere reale. Alla morte di
questo, nel 1916, i vari capi militari si ripartirono la Cina in sfere di
influenza, ciascuna controllata da un diverso paese straniero tramite accordi di
appoggio al capo militare. Si apriva cosi il periodo dei Signori della Guerra,
che finirà con l'arrivo al potere del Guo Min Dang e di Jiang Jie Shi alla metÃ
degli anni '20. Questi dette una certa omogeneità e stabilità alla Cina, alla
quale erano interessate le potenze straniere. Infatti la grande borghesia cinese
non era disposta ad impedire lo sfruttamento del paese perché per imporlo
avrebbe dovuto ricorrere alla mobilitazione armata dei contadini.

Nel 1 luglio del 1921, a Shang Hai in non più di dodici si ritrovarono nella
direzione di una scuola femminile per fondare il Partito Comunista Cinese, che
avrebbe condotto in porto una rivoluzione vittoriosa. Nell’autunno del 1923 i
russi spedirono a Canton un gruppo di consiglieri con alla testa Borodin e
Blucher, che consideravano i processi in atto in Cina la sola chiave della
rivoluzione nazionale e spinsero per un accordo con il Guo Ming Dang, almeno
fino a quando Mao si mise alla guida del partito e per questo cambiò anche la
concezione che fino allora aveva supportato il gruppo dirigente del PCC e
dell’Internazionale, una direzione operaia e degli intellettuali avanzati con
grave sottovalutazione del popolo contadino e delle sue capacità di
emancipazione in un territorio prevalentemente rurale all’80%.
Mao nel 1924 lasciò Shanghai, dove lavorava a tenere i collegamenti tra partito
e Guo Ming Dang, e ritornò nella sua regione natale Hunan. Nel 1926 riuscì a
farsi attribuire la direzione dell’Ufficio rurale del partito comunista, poi
nuovamente a Shanghai e nell’agosto di quell’anno intraprese ad organizzare le
leghe dei contadini, che sotto la sua guida mutarono gradualmente carattere e
cominciarono a divenire veri e propri organi di un nuovo potere, costituito nei
villaggi come radicale alternativa al potere dei proprietari fondiari e dei
notabili legati ai ‘signori della guerra’. Fu una vera e propria svolta per il
proseguimento futuro del processo rivoluzionario e riuscì a far conseguire al
PCC un successo, militare e politico. Ma intanto il consolidarsi di Jiang Jie
Shi darà inizio ad un decennio di relativa stabilizzazione finanziaria, mentre
il Giappone invadeva la Manciuria. Fra il 1937 e il 1939 dalla Russia arrivano
al governo cinese 250 milioni di dollari, benché non fosse il paese che dette il
massimo apporto alla lotta contro i giapponesi. Il temporaneo ravvicinamento tra
nazionalisti del Guo Ming Dang e comunisti, imposto dall’invasione giapponese,
segnò una battuta d’arresto nella guerra civile, ma scomparso il pericolo
esterno, la lotta riarse implacabile nel 1946. Al momento del crollo del
Giappone avevano in effetti compiuto grandi progressi: più di novanta milioni di
contadini vivevano sotto l’amministrazione comunista. L’Armata Rossa era ora
forte di 600-900 000 soldati regolari, nonché di un numero ancora maggiore di
truppe non regolari, contadini allenati a combattere nelle regioni che
abitavano. Le forze comuniste erano sostenute da una gran parte della
popolazione contadina, oltreché dal proletariato industriale delle città ; dietro
il Guo Ming Dang, che era venuto trasformandosi in senso sempre più decisamente
conservatore, erano i proprietari fondiari e la borghesia burocratica: un regime
inefficiente e corrotto che riusciva a sostenersi grazie all’aiuto finanziario e
alle armi fornite dagli Stati Uniti, interessati a fare della Cina, con l’avallo
del Guo Ming Dang, un’area di penetrazione e di sfruttamento. La corruzione era
anche in alto (Jiang Jie Shi e gli altri capi nazionalisti prosperavano sugli
aiuti americani) e contrastavano Mao e i dirigenti comunisti, vestiti di una
semplice casacca. Tuttavia dal punto di vista militare vi era una forte
sproporzione tra i due campi avversi. I nazionalisti avevano a loro favore la
superiorità del numero (tre milioni di uomini, contro poco meno di un milione),
le risorse di un retroterra molto più esteso e più ricco. Ma il basso morale dei
soldati (contadini reclutati di prepotenza e sensibili alla propaganda dei
contadini della parte opposta, che avevano avuto il vantaggio della
distribuzione delle terre) moltiplicò le diserzioni. La lotta si protrasse dal
1946 al 1949 e si vide la ritirata delle truppe comuniste di Mao Tse-tung dal
Jiang Xi(Cina meridionale) a Shensi a confini con la Mongolia per sfuggire alle
forze nazionaliste di Jiang Jie Shi. La marcia costò 100000 perdite umane, ma si
concluse con l’avanzata dell’Armata Rossa da nord a sud e a sud-ovest
dell’immenso paese. Jiang si salvò ritirandosi con i rimanenti del Guo Ming Dang
nell’isola di Formosa sotto la protezione della flotta americana. Il 1° ottobre
1949 fu proclamata, sulla piazza Tien An Men, la Repubblica Popolare Cinese (RPC).
Si iniziò così l’opera di edificazione del socialismo, che ha mutato
profondamente l’aspetto del paese sia nei rapporti sociali, sia nelle strutture
economiche, sia nelle idee e negli orientamenti umani. La nuova società si
caratterizzò come "dittatura democratica popolare", secondo la definizione data
da Mao in un articolo scritto il 30 giugno 1949 per commemorare il 28°
anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese (luglio 1921)
Il governo popolare centrale si dedicò alla creazione delle strutture
amministrative (governi popolari locali) e alla ripresa delle attivitÃ
economiche in tutto il paese, nell’ambito della politica di fronte unito e di
nuova democrazia.

Quando il 1° ottobre 1949, nel palazzo che era stato degli imperatori Ming e Ch'ing,
Mao Tse-tung, circondato da molti suoi compagni e da altri uomini (disposti ad
accettare, seppure non senza riserve sociali, il nuovo regime), proclamava la
fondazione della Repubblica popolare cinese, cominciava un'altra difficile
strada, quella della lotta contro l'arretratezza e contro la minaccia di
aggressione imperialista.
Decisero di creare un’industria simile a quella della Russia, che assicurerà un
forte accrescimento industriale e garantirà la sicurezza nazionale. Ma lo
sviluppo dell'insieme dell'economia non poteva tenere lo stesso passo.
L'agricoltura avrebbe dovuto produrre un eccedente che permettesse sia di
rifornire di sufficienti materie prime l'industria e viveri le città , sia
investire nella meccanizzazione dell'agricoltura, gli strumenti tecnici della
quale erano arretratissimi; però, a sua volta, un'industria capace di fornire
macchinari non poteva svilupparsi mentre l'economia nazionale non avesse
prodotto quell'eccedente necessario: questo il circolo vizioso nel quale la Cina
era condannata. Ricorrere all'aiuto esterno significava compromettere
l'indipendenza nazionale poiché nessuno fra i paesi che potevano procurare tali
mezzi era disposto ad aiutare per niente. Nel 1949 la presenza del capitale
straniero nei diversi settori economici era già praticamente nulla. La borghesia
al seguito del Guo Min Dang era fuggita a Taiwan portandosi con sé tutti i
capitali che poteva, cosi come la maggior parte della flotta mercantile.
Dopo la morte di Mao, nel 1976, e
l'arresto dei dirigenti della sinistra, la cosiddetta "banda dei quattro", pose
definitivamente termine alla lotta tra i due schieramenti. L'espressione
"rivoluzione culturale" fu in seguito utilizzata, nel dibattito politico, per
indicare il decennio (1966-1976) in cui la sinistra aveva cercato di prendere la
direzione dello Stato. Lentamente la stessa figura del presidente Mao è stata
accomunata, nella condanna, a quella di Lin Piao e alla banda dei quattro.
L'unico paese con il quale si ebbe un interscambio di strumenti tecnici contro
prodotti agricoli fu la Russia, che evidentemente nemmeno regalava nulla. Alla
Russia conveniva che la Cina dipendesse da lei, per tenerla dalla sua parte
nella guerra fredda. Però la determinazione dei dirigenti di Pechino di
difendere il ruolo di nazione indipendente fece sì che la Russia ritirasse tutti
i suoi tecnici alla fine degli anni '50, con il che la Cina si trovò
completamente isolata nel mondo davanti al suo arduo compito di sviluppare i
propri mezzi di produzione, al quale si accinse facendo uso del solo capitale di
cui disponeva, cioè l’uomo stesso.
Ora anche se la situazione è migliorata molto, in quanto esistono grandi colossi
industriali, dall’altra parte esistono ancora persone molto povere che credono
che l’unica loro soluzione sia quello di migrare nei paesi europei.
 |