

![]()
Roma verso il 300 prima di Cristo
Nel
precedente capitolo "la Roma monarchica", abbiamo visto Roma com'era
verso il 550 prima di Cristo, al tempo in cui regnavano gli ultimi re. Facciamo
ancora un salto nel tempo e giungiamo verso il 300 o poco dopo. Per la città è un periodo di relativa calma. Roma ha
scacciato i re etruschi ed è divenuta una Repubblica, si è imposta sulle città
latine e sui popoli poco distanti (Volsci ed Equi); ha inferto un nuovo colpo
alla potenza etrusca distruggendone la roccaforte settentrionale(la città di
Veio); ha superato la terribile invasione dei Galli ed infine si è volta al
mezzogiorno scacciando il fiero popolo dei Sanniti, che mirava proprio al
dominio dell'Italia meridionale. Il piccolo villaggio di pastori e di mercanti
di sale è divenuto una città più grande dei centri etruschi e italici. Il
destino ha già scritto di chi sarebbe stato il dominio d'Europa: del popolo
Romano!

La dominazione romana fu simboleggiata
dalla frase Senatus Populus Que Romanus, il
Senato e il Popolo Romano, S.P.Q.R.
Queste furono le parole che
sovrastarono l'Europa nel primo secolo dopo Cristo.
I Plebei alla pari con i patrizi
Tuttavia,
in questi anni, nel popolo romano è avvenuto un cambiamento sostanziale, ed era
inevitabile che avvenisse. Sotto i re si trattava di un popolo patrizio, un
popolo nobile, ma tutti coloro che non discendevano dagli antichi padri, che
non potevano vantare i tre nomi, che erano arrivati più tardi e da altre terre,
non erano nobili ma erano in tanti e
formavano una grande massa, costretta a vivere a margine della città: erano i
plebei. La città non concedeva loro nessun diritto, neppure quello di far
riconoscere legalmente i propri matrimoni. Ma col tempo le cose cambiarono.
Roma aveva dovuto sostenere delle grandi guerre, per questo aveva avuto bisogno
di molti soldati. L'esercito patrizio, l'unico esercito di cui disponevano i re
includeva appena 3000 uomini, ma questi
non furono sufficienti per la vittoria. I patrizi allora, furono costretti ad
arruolare la plebe. E la plebe dopo aver dato il proprio sangue per la
grandezza della città, aveva chiesto un compenso: volle entrare a far parte di
quel popolo romano che aveva chiesto il suo aiuto. Non fu una cosa semplice né
svelta, i patrizi erano gelosi dei propri privilegi e della purezza della loro
casata e non accoglievano volentieri degli estranei nella famiglia. Ma a poco a
poco, col passare degli anni, dovettero cedere. E adesso, verso il 300 prima di Cristo, si può dire che, tra patrizi e
plebei, non vi è più alcuna differenza politica. I plebei partecipano
alla vita pubblica, possono imparentarsi per mezzo di matrimoni con famiglie
patrizie e possono raggiungere le più alte cariche. Tra loro rimane solo una
differenza sociale di casta.
Il nuovo Ordinamento
Dopo
questo l'organizzazione della città è
mutata. Sotto i re, il popolo romano si divideva in famiglie, genti, curie e
tribù : era una divisione "gentilizia", ossia fondata sul parentado,
sulla gente. Adesso si è dovuta adottare una divisione più conforme ai nuovi
tempi, fondata sulla ricchezza.
In
sostanza la popolazione di Roma è stata divisa in 193 curie delle quali:
- 18 costituite dai più ricchi, coloro che
possono procurarsi un cavallo e formare così la cavalleria durante il servizio
militare,
-
120 dai ricchi e dai benestanti, capaci di procurarsi armi pesanti, difensive e
offensive formando in guerra la fanteria pesante,
-
50 dai poveri che possono disporre di sole armi offensive, lance, giavellotti e
fionde e formando la fanteria leggera; e
-
5 di nullatenenti che in guerra non combattono, non hanno armi e costituiscono
un corpo di operai militari.
I Comizi
Quando
si devono prendere decisioni importanti il popolo è chiamato a dire la propria
opinione votando per centurie; ed è chiaro che le 138 centurie di ricchi hanno
regolarmente il sopravvento sulle 55 di poveri. Così all'antico antagonismo fra
patrizi e plebei se n'è sostituito un altro, fra ricchi e poveri. Da pochi anni
è stato preso un provvedimento che mira
a superare anche questo contrasto.
La
città è stata divisa in rioni o tribù senza badare se gli abitanti siano ricchi
o poveri, patrizi o plebei e, in alcune
riunioni popolari invece che per centurie si vota per rioni. In questo caso i poveri
hanno una certa prevalenza sui ricchi, una maggioranza di tribù. Poiché però le
antiche assemblee nobiliari, nelle quali si votava per curie, non sono
scomparse, nell'epoca in cui ci
troviamo, fra il 300 e il 280 prima di Cristo, il popolo romano può esprimere il proprio parere sulle varie
questioni che riguardano la città mediante tre tipi di assemblee o comizi:
1
- le assemblee in cui si vota per curie (comizi curiati riservate ai patrizi);
2
- quelle in cui si vota per centurie (comizi centuriati in cui prevalgono i
ricchi); e
3
- quelle in cui si vota per tribù (comizi tributi in cui prevalgono i poveri).
I comizi curiati sono indetti per
prendere decisioni sulle istituzioni più tradizionali e più sacre della città; nei comizi
centuriati vengono eletti i supremi magistrati che guidano il popolo in
guerra e in pace; infine nei comizi tributi si decide in genere su
questioni di vita cittadina.
Il cittadino romano
Prima
di vedere come si svolge, giorno per giorno, la vita di Roma in questo periodo,
dobbiamo considerare quali sono le principali magistrature della Repubblica.
La
carriera delle magistrature, infatti, è per eccellenza la carriera del
cittadino romano. Chi non ha ricoperto
una carica più o meno alta nella vita pubblica viene considerato uomo da poco e
senza alcuna importanza anche se ha fatto fortuna in altre attività come il
commercio o gli appalti per i lavori pubblici.
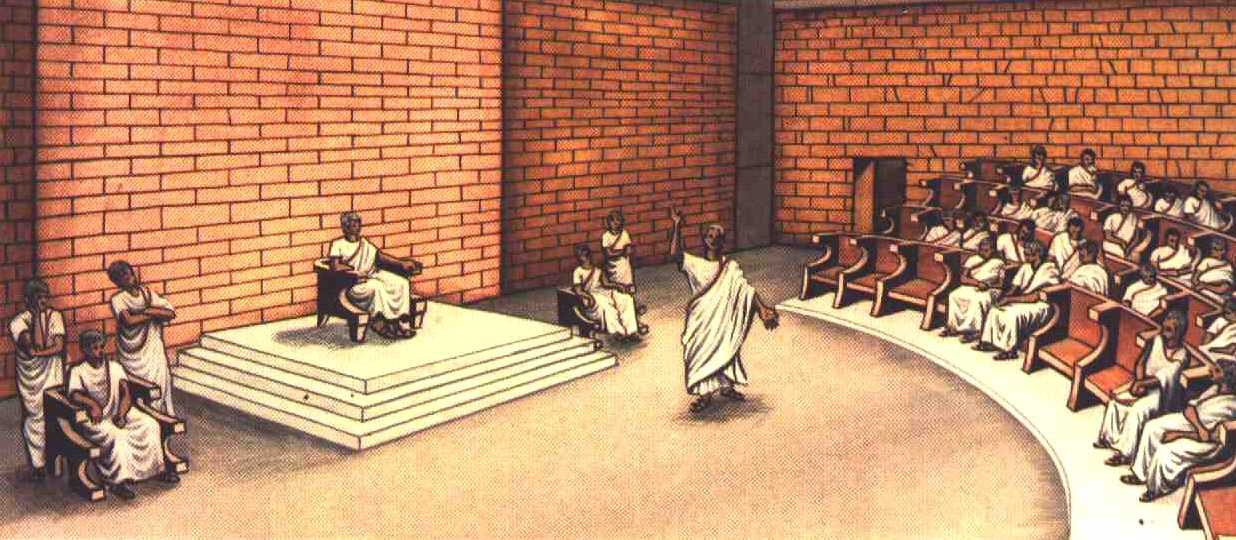
Le
ambizioni di ogni cittadino romano sono sostanzialmente due: raggiungere una
magistratura importante e possedere terreni; solo allora egli potrà
considerarsi un uomo arrivato e potente.
Le magistrature:
I
consoli
Diamo
dunque uno sguardo alle magistrature.
Quando
i re furono scacciati, il loro potere
passò ai capi dell'esercito, i "pretori";
questi capi erano tre, uno per ogni gruppo di mille uomini. Ma dopo breve tempo
solo due di loro rimasero effettivamente al comando dell'esercito e presero il
nome di "consoli"; il terzo mantenne
il nome di pretore e si occupò dell'amministrazione civile e della direzione
dei tribunali.
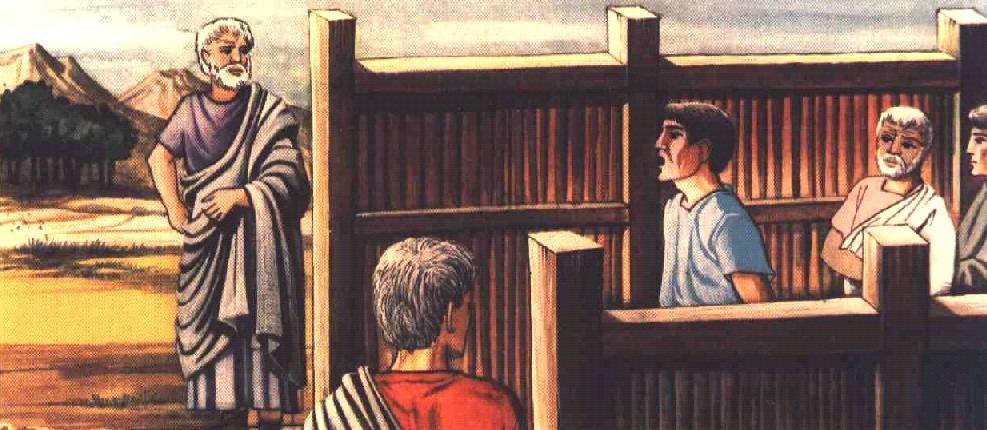
I
consoli rimasero sempre in numero di due; venivano eletti dal popolo nei comizi
centuriati e restavano in carica un anno. Nei primi secoli dovevano essere
entrambi patrizi; in questo periodo sono l'uno patrizio e l'altro plebeo.
Potevano essere rieletti, ma non immediatamente dopo lo scadere della loro
carica, tra un consolato e l'altro doveva trascorrere un periodo più o meno
lungo. Quando Roma estese il suo dominio fuori d'Italia creando delle province,
furono nominati dei preconsoli per governare,
per un anno, in qualche provincia. Fuori di Roma, l'autorità dei consoli era
assoluta; per questo le dodici guardie, o "littori"
che facevano scorta a ognuno di loro, portavano, appoggiato alla spalla
sinistra, un fascio di verghe, simbolo di unione delle forze, raccolte attorno
a una scure, simbolo di potere di vita e di morte.
Ma
entro i confini della città, cioè entro il pomerio (la cinta sacra), le loro
decisioni dovevano essere approvate dal popolo nei comizi: per questo i
littori, quando i consoli erano entro il pomerio, toglievano la scure dal loro
fascio di verghe.
Le
magistrature patrizie
Anche
il pretore era eletto dai comizi curiati e restava in carica un anno. Con
l'ingrandirsi del dominio romano, un solo pretore non fu più sufficiente,
furono allora nominati quattro pretori e la loro attività si limitò soprattutto
alla sovrintendenza dei tribunali. Finito il mandato erano inviati nelle
province con lo stesso incarico e con il titolo di propretori.
L'amministrazione
cittadina passo così dal pretore ai "questori",
dapprima due, poi quattro e infine molti di più. In origine, si occupavano delle
indagini giudiziarie; questore significa infatti indagatore. Nei momenti di
estremo pericolo però, quando appariva opportuno riunire i poteri nelle mani di
un solo comandante, veniva nominato un "dittatore",
il quale prendeva il posto dei due consoli ed aveva potere assoluto fuori e
dentro il pomerio, era inoltre scortato da ventiquattro littori col fascio e la
scure. La sua carica durava però solo sei mesi.
Il
governo effettivo della città rimaneva tuttavia nelle mani del Senato, l'antico consiglio degli anziani, che già conosciamo
come magistratura permanente che dichiarava le guerre, trattava le paci e
prendeva tutte le decisioni di importanza vitale per la città. Geloso del
proprio potere, il senato era sempre pronto a impedire che qualche magistratura
potesse prendere il sopravvento: per questo i consoli non potevano restare in
carica più anni e, terminato il loro compito, tornavano normali cittadini; per
questo l'autorità del dittatore non poteva durare più di sei mesi.
Le
magistrature plebee
Tutte
queste magistrature erano di origine patrizia e
nei primi tempi della Repubblica solo i patrizi potevano ricoprirle. Vi
erano anche magistrature di origine plebea, sorte cioè nel periodo in cui i
plebei erano ancora divisi politicamente dai patrizi e non godevano di alcun
diritto.
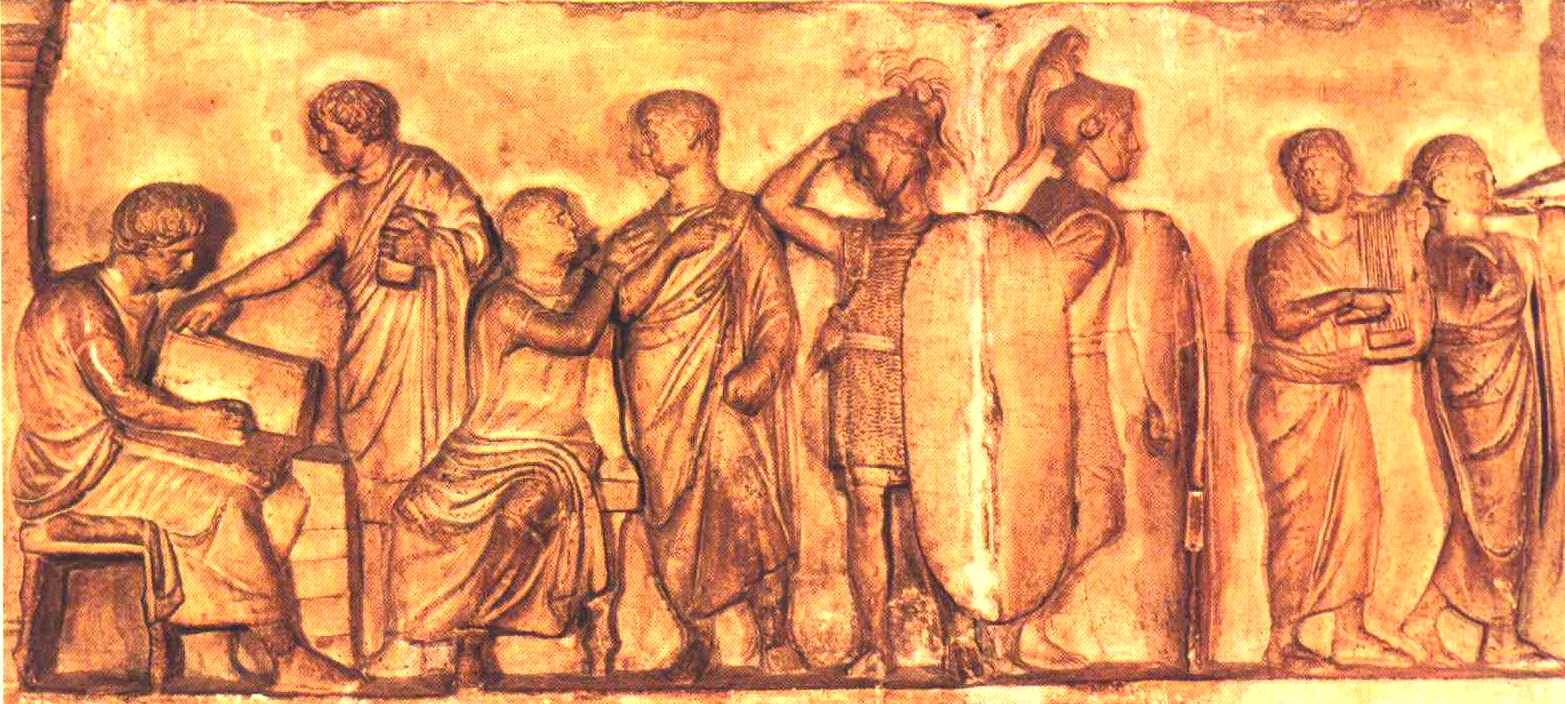
Per opporsi in qualche modo alla classe dominante il popolo minuto aveva
allora nominato dei capi detti "tribuni della plebe" i quali, in un primo
tempo, non furono legalmente riconosciuti ma infine divennero una magistratura
vera e propria, la più potente dopo i consoli. I tribuni della plebe potevano
infatti sospendere i decreti dei magistrati che apparissero contrari agli
interessi plebei, potevano opporsi alle deliberazioni del senato, incriminare e
condannare quei cittadini considerati colpevoli di atti ostili alla plebe.
Anche loro duravano in carica un anno e per tutto questo periodo erano
inviolabili: nessuno poteva sottoporli a processo o agire contro di loro
siccome la loro persona era considerata sacra. Questo carattere sacro dei
tribuni ha molta importanza perché significa che anche la plebe voleva
considerarsi parte viva del popolo romano, di quella famiglia sacra discendente
dagli antichi padri, che, fin allora, i patrizi avevano considerato come loro
esclusiva.
Collaboratori
dei tribuni erano poi gli "edili" che in origine erano probabilmente i
custodi di un grande santuario plebeo dedicato a Cerere, dea delle biade. Agli
edili fu affidata dapprima l'amministrazione delle finanze plebee: i plebei,
esclusi dalla vita cittadina, dovevano provvedere ad amministrarsi per conto
proprio e provvedere ai loro servizi pubblici come le strade, le fogne e via di
seguito. Quando, poi i plebei ebbero ottenuto la parità politica, anche gli
edili divennero una magistratura riconosciuta, provvidero alla manutenzione
delle strade e dei monumenti pubblici ed ebbero la sovrintendenza sui pubblici
spettacoli e sulle distribuzioni di grano che si facevano al popolo ogni
tanto.
Un'ultima
magistratura infine, venne creata probabilmente quando all'antica divisione
gentilizia del popolo romano, per curie, fu sostituita quella fondata sulla
ricchezza, per centurie: la "censura", la cui origine non fu dunque né
propriamente patrizia né propriamente plebea. Compito dei censori, in un primo
tempo, fu quello di redigere le liste dei contribuenti, cioè di tutti coloro
che dovevano pagare le tasse; più tardi però ebbero incarichi di maggiore
importanza: spettò loro la scelta dei nuovi senatori e un controllo sulla vita
privata in genere e su quella dei personaggi più in vista..
La Città ricostruita
Quanto
alla città non si può dire che
nell'aspetto generale sia molto mutata.
Dopo
essere stata quasi interamente distrutta dalle orde galliche ha dovuto essere
riedificata in tutta fretta e con economia; invano cercheremmo quegli splendidi
edifici di marmo di cui restano ancora le rovine e che vediamo con la fantasia
ogni volta che sentiamo parlare dell'antica Roma. Il lusso è ancora ignoto, i
ricchi impiegano il loro denaro nell'acquistare terre o nel finanziare affari,
ma non sanno ancora apprezzare le cose belle e preziose. Così che, se
tralasciamo qualche tempio, già imponente sul Palatino, sul Capitolino,
sull'Aventino o presso il Foro, la città ha un aspetto più che modesto. In
questo momento Roma non ha nemmeno un artigianato provetto: i mastri muratori,
gli scalpellini, gli scultori, sono quasi tutti etruschi che hanno fissato il
loro quartiere generale nel Vicus Tuscus, la Via Toscana, diremmo noi, dove si
allineano i loro laboratori e le loro casette. E solo le vie principali
cominciano a essere lastricate. Anche il Foro, cuore della città, rimane un
gran piazzale disadorno, dominato verso mezzogiorno dal tempio dei Dioscuri,
Castore e Polluce, i due giovani semidei che secondo la tradizione hanno
combattuto in favore dei Romani nella battaglia del lago Regillo contro le
città latine. Di fianco a questo tempio sorge il convento delle Vestali, le
sacerdotesse di Vesta, dea del fuoco familiare. Sull'estremità opposta, a nord,
ecco la nuda mole della Curia, dove si riunisce il Senato.
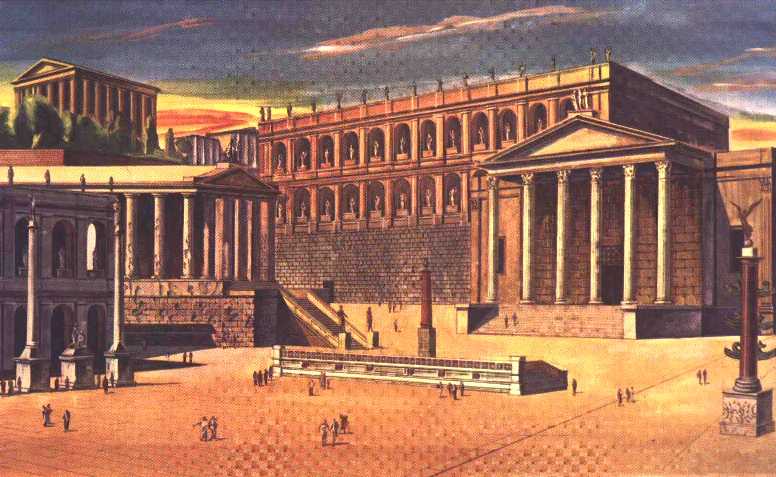
Gli spettacoli
In
questa buia, grigia e monotona città, non ci si
meraviglia se un popolo pieno di vitalità e già spinto all'avventura
come quello di Roma, (in particolare la massa dei meno abbienti), cerca un
diversivo e uno svago negli spettacoli. Abbiamo visto che in Roma vi erano, dei
magistrati gli edili che fra i loro
incarichi, avevano anche la direzione degli spettacoli: si trattava dunque di
celebrazioni importanti, di carattere pubblico. Ma lo spettacolo a Roma, non
aveva il carattere né il valore dello spettacolo greco. In Grecia, spettacolo
per eccellenza erano i giochi olimpici e le rappresentazioni tragiche: i giochi
miravano a mettere in luce le qualità più nobili dell'uomo completo, l'agilità,
la forza, l'intelligenza, mentre le tragedie portavano sulla scena le grandi
passioni dell'uomo. Lo spettacolo romano non aveva alcun valore ideale.
Nell'epoca in cui siamo, la tragedia, come del resto la commedia, era ancora
ignota e uniche forme di spettacolo erano gare atletiche di corsa, di lotta, o
veri e propri combattimenti sanguinosi che eccitavano il popolo come semplici
dimostrazioni di forza. Si trattava di tradizioni etrusche nelle quali, col
tempo, suscitò sempre maggior interesse il combattimento tra squadre armate,
che si concludeva con morti e feriti. I combattenti, dapprima armati della sola
corta spada romana, il gladio, e per
questo chiamati gladiatori, erano quasi sempre
schiavi addestrati in speciali scuole, ma potevano anche essere professionisti
di libera condizione. L'origine di queste gare va ricercata nei combattimenti
funebri con i quali gli Etruschi onoravano i loro morti. I Romani si
appassionarono presto a questo feroce sport, che sarebbe divenuto loro
caratteristico ed era destinato a durare per molti secoli; data la natura dello
spettacolo, che poteva essere contemplato da ogni punto di vista, i Romani
costruirono teatri circolari, con un'area centrale circondata da cerchi di
gradinate, che furono detti anfiteatri, ossia
teatri doppi, perché risultavano composti da due teatri greci semicircolari
riuniti.
Roma nell'ultimo secolo prima di Cristo
Il
panorama di Roma è assai diverso se, facendo un nuovo salto nel tempo, ci
portiamo nel periodo più importante dell'epoca repubblicana, nell'ultimo secolo
prima di Cristo, l'epoca che vede le grandi figure di ambiziosi, sempre in
lotta fra loro: Mario, Silla, Pompeo, Cesare, Antonio, Ottaviano. Molte cose
sono cambiate. Roma ha conquistato l'Italia meridionale conoscendo la splendida
civiltà della Magna Grecia, ha conquistato Cartagine divenendo padrona dei mari
e dei commerci mediterranei, ha conquistato la Grecia facendo propria la sua
antica civiltà, si è spinta in Oriente, nella ricca Siria, fino al lontano
regno del Ponto, è venuta in contatto con il favoloso Egitto e finirà col
conquistare anche quello. In queste con condizioni, l'antica semplicità, a cui
tenevano tanto, i padri di famiglia di un tempo, non poteva resistere, e i modi
di vita sono profondamente mutati.
Le abitazioni
Adesso
le case dei ricchi sono decisamente sontuose e divise sempre in due parti,
quella anteriore attorno all'atrio, che si conclude nel fondo con la grande
sala dei banchetti, il triclinio; e quella posteriore intorno a un giardino
circondato da portici a colonne, il peristilio, riservata alle stanze private.
Nel giardino vi sono statue e spesso, nel centro, zampilla una fontana; le sale
sono arredate con bei mobili e tendaggi, e hanno le pareti affrescate da
pittori greci o di scuola greca. Particolarmente fastoso è poi il triclinio, la
sala più importante per un uomo pubblico che deve continuamente convitare
personaggi influenti, con una grande mensa di marmo scolpito generalmente
circolare posizionata al centro, e attorno, su tre lati, file di letti: perché
i Romani, come i Greci e gli Etruschi mangiano sdraiati, appoggiandosi sul
gomito sinistro.
Banchetti
I
conviti avvengono di sera, subito dopo il tramonto del sole, quando i tribunali
sono chiusi, gli appuntamenti d'affari sono terminati e il Foro è deserto.
Durante
il giorno si è in genere molto frugali: al mattino si fa una leggera colazione
a base di formaggio e frutta; a mezzogiorno un modesto "prandium", con pesce, uova, formaggio e frutta,
mentre la sera, la cena è decisamente abbondante e comprende tre portate,
ognuna delle quali è composta da vari cibi.
Si
comincia con l'antipasto, o "gustatio",
composto di uova sode, insalate e olive, fichi secchi o freschi, tutto ciò
insomma che stuzzica l'appetito in un palato romano. Vengono poi le "prime mense", i cibi più sostanziosi, le carni
arrostite o bollite, i pesci, la cacciagione. Infine le "seconde mense", i dolci di pasta e miele, la
frutta e d'estate le bibite ghiacciate nella neve portata dalle cime dei monti
vicini.
I
costumi si sono raffinati, esistono regole che un buon padrone di casa deve
sempre rispettare. Per questo il numero dei convitati non deve mai superare i
nove: la conversazione deve mantenersi su argomenti generici, di vita privata
senza affrontare i temi importanti o discorsi di affari di cui si parla nel
Foro. Tuttavia proprio in queste conversazioni senza importanza, apparentemente
frivole, si stringono amicizie decisive, si preparano affari di gran peso.
La cultura
Spesso
durante la cena, si legge ad alta voce. Perché adesso la cultura è considerata
essenziale. Bisogna conoscere le ultime opere che vengono dalla Grecia: opere
di filosofia, di economia, romanzi e poesie. Il greco è divenuto la seconda
lingua dell'impero romano, ognuno lo parla correttamente. Sono passati i tempi
in cui l'educazione letteraria si limitava a saper leggere e scrivere. Adesso
in ogni famiglia ricca vi è almeno un pedagogo,
ossia uno schiavo, generalmente greco, che ha l'incarico di far da maestro ai
ragazzi. Uno schiavo certo, come vi è uno schiavo medico, uno schiavo
computista. Il Romano non trova nulla di strano in questo fatto, perché per lui
anche un uomo libero che viva occupandosi esclusivamente di letteratura, di
medicina, di matematica o di filosofia rimane sempre in una condizione inferiore:
ovviamente è un uomo tagliato fuori dalla vita pubblica, che è la vita più
importante per un romano.
Questi
schiavi eruditi verranno poi liberati, quando i loro discepoli saranno divenuti
adulti, e resteranno clienti o protetti delle famiglie presso cui hanno
insegnato, ma la loro condizione sarà sempre più o meno servile.
Le scuole
Oltre
ai pedagoghi privati, quasi tutti schiavi, vi sono anche vere e proprie scuole
tenute spesso da liberti ossia schiavi liberati
e frequentate da quelli che noi chiameremmo i ragazzi della borghesia,
appartenenti cioè a famiglie agiate ma che non si possono permettere un
pedagogo. Vi sono scuole per bambini che imparano a leggere e scrivere sotto la
guida di un litterator, ossia un
maestro di lettere (si deve però intendere lettere dell'alfabeto, non
letteratura). Di ordine superiore sono le scuole dove un grammaticus,
o maestro di grammatica, insegna a formare bei periodi a scrivere con eleganza e fa conoscere i
principali poeti e scrittori. Infine, verso i quindici o sedici anni, si studia
retorica presso il rhetor, ossia si
impara a parlare in pubblico, cosa importantissima per chi voglia seguire
la carriera politica. Coloro che
intendono perfezionarsi in quest'arte vanno spesso in viaggio in Grecia, ad
Atene, che rimane la patria del bel parlare.
Il costume
Anche
gli abiti si sono fatti più ricchi. I Romani dei tempi antichi si limitavano a
indossare un panno attorno alle reni e una modesta toga: adesso, dopo essersi
avvolto i fianchi, un Romano della buona società indossa una tunica di lana o di lino stretta alla vita da una
cintura e su di essa avvolge in complicati giri un'ampia toga lunga quasi sei
metri e larga due, di forma semicircolare. La
toga è sempre di lana bianca, senza alcuna decorazione.
Solo
i fanciulli tra i dodici e i diciassette anni, gli alti magistrati e i
sacerdoti portano una toga orlata di una striscia di porpora sul lato
anteriore, ossia il bordo diritto del semicerchio, la quale, appunto per
questo, è detta praetexta
(che significa, ricamata sul davanti). Giunto a 17 anni, con solenne cerimonia,
il giovane romano indossa la toga virile ed è considerato uomo. Quanto ai
bambini al di sotto dei dodici anni, indossano una tunichetta e su di
essa, la "clamide",
che è una tunica più ampia, con maniche piuttosto lunghe Al collo poi, portano
sempre una "bulla d'oro",
ossia un amuleto appeso a una catenella che deve servire da portafortuna e
proteggere dal malocchio. Lo abbandoneranno solo al momento di indossare la
toga virile.
Vi
domanderete come faceva un Romano a restare avvolto per tutta la giornata in un
drappo di sei metri per due. In realtà, per portare la toga con eleganza era
necessaria molta pratica e molta attenzione, specialmente quando si doveva
parlare in pubblico, muovendo solo il braccio destro che rimaneva libero e trattenendo con il sinistro le pieghe
dell'abito. L'oratore infatti, veniva giudicato non solo da quello che diceva e
dal modo in cui lo diceva, ma anche dall'eleganza con cui sapeva drappeggiarsi
nella toga parlando.
Il
costume femminile è ancora relativamente semplice: le giovinette portano la
praetexta fino al momento delle nozze, quando indossano anche loro la toga. In
genere però meno ampia di quella maschile. Sulla toga possono poi gettare una
specie di mantello, il pallio, con il quale, se
sono vedove, si copriranno anche la testa.
Il
popolo minuto non porta toga, indumenti proprio di coloro che non fanno lavori
manuali. Si accontenta della tunica e se ha freddo, vi aggiunge un mantelletto
fornito a volte di un cappuccio. In testa porta un cappello di feltro a forma
di cono. Un Romano togato andrà invece sempre a testa scoperta.
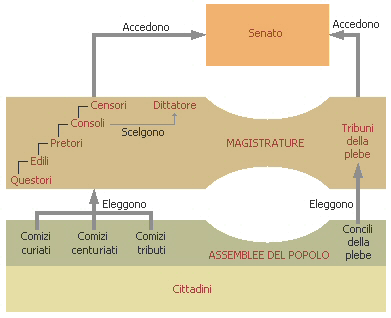 La civitas, termine che designava la
comunità sociale e politica dei cittadini (cives), fu il fondamento delle
istituzioni di Roma repubblicana. Solo coloro che potevano rivendicare la condizione di cittadini
e che godevano degli attributi legati a tale status potevano infatti
partecipare alle assemblee
La civitas, termine che designava la
comunità sociale e politica dei cittadini (cives), fu il fondamento delle
istituzioni di Roma repubblicana. Solo coloro che potevano rivendicare la condizione di cittadini
e che godevano degli attributi legati a tale status potevano infatti
partecipare alle assemblee
La giornata di un Romano
Il
mattino
Il
mattino è il periodo più intenso della giornata dedicato al lavoro.
Comincia
molto presto: al levar del sole. Verso le cinque e mezzo d'estate e le otto
d'inverno, il Foro è già affollato, i tribunali sono aperti e nei laboratori
artigiani si lavora.
In
queste prime ore mattiniere Roma è splendida; si vedono i verdi giardini sopra
le mura con le grandi case in pietra; i templi, nei quali il marmo già comincia
ad abbondare, si colorano di un pallido rosa; le statue alte sui loro
piedistalli si ergono nel cielo. Il Foro adesso è tutto lastricato con larghe
pietre quadrate, sui due lati più lunghi
si vedono file di negozi che fanno mostra delle merci più varie animando la
grande piazza; nuovi templi sono sorti.
Gli
uomini politici, gli uomini d'affari, parlano riuniti in gruppi,
drappeggiandosi nelle ampie toghe, o camminando lentamente a due o tre. Ogni
tanto un magistrato passa grave e taciturno, ascoltando appena, con lo sguardo
fisso davanti a sé, qualche supplicante che, dopo essersi inchinato davanti a
lui portando la mano alla bocca, gli parla in fretta, sottovoce.
Il meriggio
A
mezzogiorno, per molti, la giornata finiva. Il Romano, dopo il prandium,
desiderava starsene tranquillo a meditare, poteva darsi che in definitiva,
tutto si concludesse in un sonnellino, ma spesso la meridiatio, come la chiamavano,
ossia il meriggiare, era una vera forma di lavoro: si facevano progetti per il
giorno dopo, si risolvevano problemi comparsi durante il mattino, si prendevano
appunti sulle tavolette spalmate di cera, o addirittura si scriveva.
Molti
Romani colti si compiacevano infatti di scrivere le proprie memorie o almeno di
tenere estesi diari.
Più
tardi le terme, ossia i bagni pubblici, si
affollano e così pure i teatri. Ve ne sono adesso, di piccoli e di
grandi, ad anfiteatro per gli spettacoli dei gladiatori e a semicerchio,
secondo il modello greco, per gli spettacoli tragici e soprattutto comici.
Gli spettacoli comici
I
Romani non amano molto la tragedia che tuttavia comincia ad essere
rappresentata, ma assistono volentieri alla commedia, derivata dalla commedia
greca cosiddetta "nuova" in cui appaiono, comicamente contraffatti,
personaggi ed episodi della vita quotidiana.
Circa
duecento anni prima dell'epoca in cui ci troviamo, un popolano geniale, Plauto, ha fatto rappresentare le prime commedie,
tratte da commedie greche, ma ricche di un colorito che poteva dar loro solo un
arguto romano.
Poco
meno di un secolo dopo, un giovane liberto cartaginese, o addirittura libico, Terenzio divenuto amico dei giovani della miglior
società dell'epoca, ha creato un tipo di commedia più raffinata, specchio di
vita borghese molto ammirata dalle
classi colte. In questo periodo, non vi sono grandi scrittori comici e la
commedia è diventata uno spettacolo farsesco, con musiche e balletti o una
specie di rivista in cui si portano sulla scena, senza un preciso legame, gli
aspetti più vari della vita romana. Ma sotto queste nuove forme, la commedia è
divenuta uno spettacolo molto popolare, ci sono attori famosi, beniamini delle
classi più umili i quali, più che recitare, improvvisano ogni giorno la loro
parte, parlando direttamente con il pubblico, lanciando numerose battute.
I Gladiatori
Lo
spettacolo che più entusiasma il popolo romano di tutte le classi è il
combattimento di gladiatori. Non si
tratta più, come un tempo, di una sorta di battaglia tra gruppi avversi. Ora
queste lotte si presentano in una quantità di forme diverse: lo scontro tra
squadre, il duello fra gladiatori armati con le stesse armi, il terribile
combattimento tra gladiatori e animali feroci e via di seguito.
I
gladiatori, poi, si distinguono a seconda della loro specialità e della loro
armatura
tra
questi ricordiamo:
-
il mirmillone, con un grande elmo ornato di un
pesce, scudo rotondo, bracciale di scaglie che proteggeva tutto il braccio
destro, mentre la gamba sinistra che nel combattimento era portata in avanti, (
protetta da un'alta gambiera).
-
Il reziario, consueto avversario del mirmillone,
armato di un tridente e di una rete con la quale cercava di prendere
l'antagonista;
-
il sannita, armato come il mirmillone ma con il
lungo scudo sannita;
-
il trace, con scudo lungo, alte gambiere, spada
ricurva e lancia.
Addestrati
in scuole speciali questi uomini, scelti tra i più forti prigionieri di guerra,
potevano divenire campioni imbattibili e godere di un grande favore popolare.
Poiché sui combattimenti si facevano scommesse, questi divi della spada avevano
sempre molti sostenitori e molti nemici: tra i primi erano coloro che avevano
vinto scommettendo su di loro, tra i secondi quelli che avevano perso puntando
sui combattenti da loro sconfitti. E guai a coloro che avevano più nemici che
sostenitori, perché un gladiatore importante che cadesse ferito veniva
risparmiato o ucciso a seconda che la maggioranza del pubblico gli facesse
grazia levando in aria il pollice o lo condannasse volgendo il pollice verso
terra.
Molto
interessante il film "Il Gladiatore" uscito ultimamente al
Cinema, che racconta, arricchito con gli
effetti speciali dell'ultima generazione, questi antichi massacri spettacolari.
La vita religiosa
Abbiamo
visto che a Roma la vita politica era considerata come fondamentale per
ogni cittadino. Nessuna meraviglia se la
vita religiosa venne a fondersi con quella politica. Non vi era, presso i Romani, alcun atto
pubblico, alcuna pubblica cerimonia che non fosse accompagnata da riti
religiosi. E tuttavia i Romani erano spiriti molto pratici e per nulla inclini
alle meditazioni sull'aldilà. Questo avveniva perché la religione romana venne
spontaneamente confondendosi con lo stato e gli dei finirono con l'essere delle
semplici figure al servizio dell'unica divinità in cui i Romani credessero
realmente. Roma stessa!
I
sacerdoti dunque, non erano in realtà che magistrati, non costituivano una classe a parte ma erano
scelti tra i cittadini più insigni o tra gli alti e medi magistrati, che
continuavano a condurre la loro vita civile salvo a intervenire in alcune
cerimonie e ad adempiere ad alcuni compiti.
I principali sacerdoti
Al
tempo dei re, i sovrani erano allo stesso tempo sommi sacerdoti (come del resto
era avvenuto presso tutti i popoli più antichi. gli Egiziani, i Babilonesi, i
Cretesi). Scacciati i re, rimase a lungo un "re dei pontefici" che
continuò la tradizione regia e che divenne poi il pontefice massimo. Ma questo,
fu un titolo semplicemente onorifico, che non comportava alcuna attività
particolare. Sotto di lui, al tempo in cui siamo, c'erano parecchi pontefici,
circa una ventina, fra maggiori e minori i quali, insieme formavano il collegio
dei pontefici, sacerdoti cioè di tutti gli dei e non di una divinità particolare.
Portavano, al pari degli altri magistrati, la toga praetexta e avevano il
compito particolare di regolare il calendario indicando i giorni fasti (dal
latino fas), in cui era lecito
trattare affari civili e giudiziari, e i giorni nefasti, nei quali era illecito
farlo.Tra i sacerdoti di divinità singolari, i più importanti erano i Flamini e gli Auguri.
Tutti costoro però, dovevano badare solo che ogni rito, ogni funzione, ogni
sacrificio venissero eseguiti secondo le regole, non avevano alcun compito
morale o di guida spirituale, non eseguivano una missione, come il sacerdote
cristiano, ma semplicemente un ufficio.
I sacrifici
I
riti principali erano sacrifici, processioni e feste in onore di qualche
divinità.
I
sacrifici potevano essere privati e semplici, o pubblici ed imponenti. Nei
tempi antichi il sacrificio più comune era quello in onore divinità agresti,
con l'offerta di ortaggi, frutti e, talora, agnelli. Anche in epoca più tarda
rimase caro ai Romani.
Un
altro sacrificio privato tipicamente romano è quello che il capo famiglia
faceva agli dèi familiari, (i Lari e i Penati), offrendo loro ogni
giorno corone di fiori, grano e sale.
I
sacrifici pubblici erano compiuti sotto la guida di sacerdoti che per
l'occasione avevano la testa cinta di corone, ma non tutti i sacrifici pubblici
esigevano vittime. Nelle semplici libagioni (bevute),
ad esempio, si offrivano agli dei, cibi, frutti, fiori e vino. Il lectisternio
era un vero banchetto offerto agli dei, le cui immagini venivano poste attorno
a una mensa. Nei sacrifici cruenti, gli
animali venivano condotti all'altare adorni di fiori o di bende sacre, poi il
sacerdote spargeva sulla testa della vittima della crusca mista con sale, dopo
di che avanzava il sacrificatore, o vittimario,
col torso nudo e coperto dalla vita in giù da una specie di gonnellina a
frange, l'animale veniva poi abbattuto
con una mazzata e infine sgozzato. Di particolare importanza erano i sacrifici
di un maiale (sus), di una pecora (ovis), e di un toro (taurus), detti "suovetaurilia", che si facevano ogni cinque anni
come purificazione dell'esercito.
Le processioni e le feste
Numerose
erano le processioni, la più importante era quella di "supplica", che
si faceva con l'intervento di tutte le autorità per placare la collera divina e
supplicarne il suo aiuto in circostanze particolarmente gravi.
Le
feste più popolari erano i Saturnali, i Terminali e i Lupercali. Vi era un
singolare costume: i giovani che vi prendevano parte si vestivano con una pelle
di montone, sacrificavano alla divinità una capra, si tingevano la fronte col
sangue della vittima asciugandolo poi con la lana intrisa di latte e infine correvano per la città,
colpendo con una cinghia fatta con la pelle della vittima tutte le donne che
incontravano. E queste ne erano contente perché si diceva che quelle innocue
sferzate le preservassero dalla sterilità.
I funerali
Prima
di lasciare la Roma repubblicana, vediamo come i romani onoravano i defunti.
Quando un Romano stava per lasciare la vita, la famiglia si riuniva intorno a
lui e il suo più prossimo parente lo baciava sulla bocca per accogliere il suo
ultimo respiro. Avvenuto il trapasso, tutti lo chiamavano ad alta voce e si
facevano squilli di tromba al suo orecchio per assicurarsi che fosse realmente
morto, era questa la "conclamazione". Poi il corpo era rivestito
degli abiti più sontuosi, gli si metteva una moneta in bocca e lo si esponeva
nell'atrio.
Nei
tempi più antichi il trasporto funebre avveniva di notte per non incontrare
nessun sacerdote o magistrato, i quali avrebbero dovuto poi purificarsi. Ma nel
tempo in cui siamo i funerali avvenivano di giorno, tuttavia al lume delle
fiaccole, in ricordo dell'antico costume.
La
salma era portata su di un carro a due ruote, a forma di piccolo tempio seguito
dai musicisti con flauti e trombe;
dalle lamentatrici, o prèfiche,
ossia donne che per professione levavano pianti e lamenti ai funerali; dai
parenti e dagli amici, spesso a piedi nudi e col capo coperto di cenere; e per
finire, da un attore, vestito con gli
abiti del morto, ne contraffaceva i gesti e la voce. Spesso erano portate anche
le immagini di cera o di gesso colorato dei suoi antenati, i quali venivano
così a rendere onore al defunto. Non sempre i Romani ardevano sul rogo i loro
morti, come facevano i greci. Nei tempi più antichi, anzi, i morti venivano
regolarmente sepolti. Soltanto negli ultimi anni della repubblica divenne quasi
generale l'uso di bruciare i cadaveri fuori della città, nelle vicinanze del
luogo prescelto per la sepoltura, coricati su di un letto funebre. Così anche i
funerali venivano a essere un atto di vita pubblica che aveva il suo momento
culminante nel Foro, là dove il defunto veniva a volte esposto, se aveva un
passato di uomo politico.
Le strade romane
Una
delle imprese maggiori affrontate dall'antica Roma è stata indubbiamente quella
di creare una rete stradale sufficientemente estesa e funzionale per collegare
le più lontane regioni del vasto Impero con la capitale, sede di commerci e del
governo centrale. Queste strade messe in esercizio dai Romani, furono inoltre
per lungo tempo nella storia le sole vie di comunicazione fra le varie parti
sia d'Italia, sia d'Europa, sia fra questa e i territori dell'Africa e del
vicino Oriente, fin dove si erano spinte le legioni di Roma.
Nella
penisola costituivano l'ossatura militare e commerciale " le viae publicae",
convenzionalmente dette vie consolari, di cui le principali furono la Cassia, la Salaria, la Latina, l'Appia, la Flaminia, l'Aurelia, l'Emilia e la Postumia.
In
genere più che dai consoli furono fatte costruire dai censori e più tardi dagli
imperatori.
Le
vie consolari che si irradiavano da Roma, iniziavano da un simbolico segnacolo
il miliarium
aureum, in età imperiale posto nel Foro, rispetto al quale si
misurava la distanza in miglia, inoltre ricalcavano in gran parte il tracciato
degli antichi trattori, ovviamente
sistemati con imponenti opere artificiali. Fra le vie consolari che si
spingevano oltre la penisola italica vanno ricordate la via Egnatia, che collegava Costantinopoli,
la via Augusta, che arrivava a Nizza,
la Claudia Augusta, da Venezia ad
Augsburg e le due vie Alpis Graie e Alpis Poenina, da Aosta a Lione,
rispettivamente la prima tramite il passo del piccolo San Bernardo e la seconda
tramite quello del Gran San Bernardo; entrambe costruite in età imperiale.
Le
caratteristiche tecniche di queste vie e in generale delle strade romane erano
queste: misuravano generalmente lO-12
metri di larghezza ed erano costituite da una carreggiata centrale con sezione
da 2,50 a 4 metri e da due banchine in terra battuta che correvano
parallelamente ed erano separate dalla prima mediante due arginelli di terra.
Il tracciato era il più rettilineo possibile così da raggiungere il punto
d'arrivo con il percorso più breve, generalmente le curve erano a grande raggio
e nel relativo tratto la carreggiata centrale era più larga per agevolare
l'incrocio dei veicoli e le pendenze erano per lo più lievi. Il razionale
tracciato delle strade romane richiedeva durante la realizzazione frequenti e
importanti movimenti di terra per creare terrapieni e trincee e necessitava inoltre di numerose opere
d'ingegneria civile quali muri di sostegno, ponti, e viadotti. Per la maggior
parte i ponti erano in un primo tempo costruiti in legname, ma numerosi furono
anche quelli costituiti da uno o più archi in muratura.
Uno
degli intenti principali dei costruttori di strade al tempo romano era quello
di creare degli impianti particolarmente duraturi e senza necessità di
manutenzione.
La
rete romana, pur non avendo la complessità di quelle attuali, né la loro
ricchezza di sviluppo, rapportata nel tempo e ai mezzi di trasporto di allora,
è rimasta esemplare nel mondo.
Basti
pensare alla mobilità raggiunta dagli eserciti romani grazie alla sua
efficienza e al buon funzionamento del servizio postale durante il periodo
imperiale, che vide sorgere lungo le principali strade frequenti stazioni di
posta che ospitavano corrieri e cavalli incaricati di trasportare rapidamente i
messaggi da un luogo all'altro del vasto Stato. Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la rete delle grandi
strade imperiali misurava circa 140.000 chilometri.
Al
principio del Medioevo con il succedersi delle invasioni cosiddette barbariche,
ebbe inizio la decadenza di quella efficiente rete stradale che collegava in
ogni senso le diverse regioni del vasto territorio dell'Impero sia tra loro sia
con la Roma capitale, da cui il famoso detto "tutte
le strade portano a Roma".
 La cartina mostra
le più importanti strade e rotte marine dell'impero romano. Le strade erano concepite
prima di tutto come vie di transito per l'esercito, e collegavano Roma con i
territori conquistati. In seguito, con l'espandersi dell'impero, anche la rete
stradale si estese fino ad abbracciare tutti i possedimenti romani, diventando
uno dei principali strumenti per controllare e amministrare i territori
assoggettati.
La cartina mostra
le più importanti strade e rotte marine dell'impero romano. Le strade erano concepite
prima di tutto come vie di transito per l'esercito, e collegavano Roma con i
territori conquistati. In seguito, con l'espandersi dell'impero, anche la rete
stradale si estese fino ad abbracciare tutti i possedimenti romani, diventando
uno dei principali strumenti per controllare e amministrare i territori
assoggettati.