
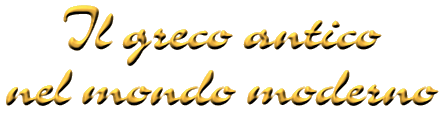
Chi l'ha detto che studiare il greco antico sia una noia indescrivibile e una inesauribile fonte di frustrazioni? non è sempre così, l'importante è capire tutte le potenzialità di crescita e formazione che questa materia porta con sé; e noi cerchiamo di darti una mano, o di convincerti ulteriormente di ciò che sapevi già da solo, nell'esplorare questo campo e scoprire quanto può essere fertile e fruttifero. Ovviamente puoi non essere d'accordo (bontà nostra!) e replicare, controbattere; mandaci il tuo commento, se possibile ben motivato, e noi saremo ben lieti di dare spazio alle tue idee: in fondo lo dice anche Eraclito che è dal conflitto che nasce l'armonia.
Buona lettura.
(se vuoi, puoi scaricare direttamente da qui i file .rtf -richiesto Microsoft Word-)
scarica il tema di Federico scarica il tema di Jacopo
---
"Lingua morta", "inutile nel campo del lavoro e nella vita pratica", "riservata a pochi eletti", "tempo sottratto allo studio delle nuove tecnologie", "faticosa e poco interessante" …
Questo è lo studio del greco antico secondo una larga fetta della popolazione, di ogni età e di ogni zona geografica. Anche la classe politica, dopo l’approvazione della riforma dei cicli, in clima di campagna elettorale, sull’onda degli stravolgimenti nella scuola pubblica ha spesso espresso pareri analoghi.
Il greco antico sarebbe una "lingua morta" perché nessuno la usa più come mezzo di comunicazione, non rappresenta un veicolo di scambio con altre persone; in questo senso sarebbe molto più utile lo studio dell’inglese, che, complice la superpotenza americana, diventa sempre di più la lingua internazionale. L’inglese serve nella vita quotidiana per comunicare, per chattare, per mandare e-mail a qualsiasi persona sulla faccia della terra; e ancora di più serve nella vita lavorativa per avere contatti con clienti di tutto mondo (non a caso è ormai uno dei requisiti di base per l’assunzione). Nessuno invece, in un colloquio di lavoro, chiederà mai di citare una massima di Platone, una battuta di Aristofane, la data della battaglia di Salamina, le forme alternative della seconda forma di comparazione degli aggettivi. In fondo, ci si chiede, queste nozioni che cosa aggiungono alla figura professionale del candidato? Secondo me molto, anzi moltissimo; ma su questo mio parere tornerò dopo.
Anche al di fuori della vita professionale, nel campo quotidiano della vita sociale, per molti il greco antico si rivela ancora una volta inutile: per divertirsi, per conoscere una ragazza, per distrarsi dai numerosi problemi di una vita troppo piena di impegni, per chiacchierare con gli amici, servono altre qualità, quali il fascino, il senso dello humour, la passione per il calcio o per i vestiti firmati, di certo non la conoscenza di una lingua e di una cultura così distanti, almeno nel tempo, dalla nostra.
E già, perché, come accennavo prima, studiare il greco e la sua cultura sarebbe un modo di guardare solo indietro, di osservare incantati una fantomatica civiltà che, però, in fondo, con la nostra era supertecnologica avrebbe ben poco a che fare. I Greci non avevano l’elettricità, il frigorifero, la macchina, il lettore DVD, Internet e vivevano in una realtà molto più limitata della nostra. Come potrebbero avere qualcosa da insegnare a noi, che abbiamo raggiunto un grado di sviluppo (sarà poi vero?) tanto alto?
Si aggiunga poi il fatto che il suo studio richiede impegno, fatica, costanza, passione, capacità di astrazione, ed ecco che per molti, abituati ad un mondo in cui tutto deve essere facile, divertente, in cui tutto si può comprare, il greco diventa un peso enorme che non sono in grado, e quindi non hanno la volontà di accollarsi.
E così tutti quelli che rinunciano ad apprezzarlo e quindi a studiarlo talvolta arrivano a definirlo uno studio elitario, riservato ai pochi figli di papà che si possono permettere di andare all’università per specializzarsi e quindi di rimandare l’ingresso nel mondo del lavoro. Così anche i licei classici, da sempre unica roccaforte della lingua greca, diventano covi di figli della borghesia, nella cui vita sempre troppo facile si può anche trovare del tempo da dedicare alla pura speculazione filosofica su temi astratti.
Lo studio del greco e della sua civiltà si inserisce però nello studio più ampio della storia e delle radici della nostra cultura e del nostro mondo. È alle scuole elementari che si comincia a guardare anche al proprio passato: i bambini ricercano informazioni su ciò che c’era prima della propria nascita, rimanendo sempre però nella sfera familiare, che un piccolo sente senza dubbio più vicina a lui. Gradualmente si passa ad osservare anche il mondo circostante, le abitudini di vita dei propri nonni, in un lungo processo che dovrebbe portare ogni bambino ad essere curioso di guardare sempre più indietro, conscio che ogni evento del passato ha una qualche ripercussione anche sul presente. Ed è proprio da questa necessità fisiologica di capire chi siamo, da dove veniamo, perché siamo così che dovrebbe nascere, a mio parere, lo stimolo a dedicarsi allo studio delle grandi civiltà del passato e, nello specifico, di quella greca. La civiltà occidentale affonda infatti le sue radici più profonde nel mondo classico e da queste trae il nutrimento necessario al proprio progresso. Non sembri però contraddittorio accostare le radici, simbolo di staticità, all’idea di progresso e avanzamento: come infatti un albero si sviluppa e cresce ramificandosi, continuando a dare sempre più frutti, e fornisce riparo anche ad altri esseri viventi, o come da una pianta madre si sviluppano stoloni in grado di dare vita a nuove piante, capaci di mettere radici proprie, così la lingua e la cultura greche continuano a essere per noi un punto fermo, saldo, da cui gradualmente ci allontaniamo, nel tempo, rimanendo però legati ad esse.
Prima di analizzare più a fondo le principali sfere in cui si può ancora percepire l’influsso della civiltà greca è importante fare una precisazione, sottile ma non scontata: spesso si crede che lo studio del greco sia lo studio solo di una lingua, con le sue strutture grammaticali e le sue regole; in realtà si tratta dello studio ben più vasto di tutto quello che riguarda il mondo greco-ellenistico, partendo sì dalla sua lingua, ma non limitandosi certo a quella.
Alla base di tutto porrei la conoscenza della lingua italiana: per comunicare ciò che si pensa in modo corretto e chiaro, bisogna avere una perfetta conoscenza delle possibilità di espressione offerte dalla propria lingua. Per fare questo è necessario capire come si sia arrivati a particolari espressioni, da dove provengano i termini che si usano, perché le frasi e quindi i pensieri debbano essere disposti in un preciso ordine e secondo precise regole. Bisogna saper attribuire valori diversi ad ogni aspetto del ragionamento, valutare con cura i rapporti fra le sue diverse componenti. In tutto questo, ma anche in qualsiasi altro campo che richieda una certa capacità di analisi, lo studio del greco può rappresentare un utile strumento.
Prima di tutto, infatti, migliaia di parole della nostra lingua, ma anche di molti altri idiomi moderni, derivano in modo più o meno evidente dalla lingua greca; non si deve però pensare solo agli oscuri termini medici, ma anche a nuovissime espressioni quali "new technology" o "new economy". Sapere perché, per esprimere un certo concetto, è stato scelto proprio quel vocabolo non può che aiutare a scegliere meglio e a capire meglio quello di cui si sta parlando. Pensando sempre alla necessità di una scelta più appropriata possibile, una approfondita ricerca fra le pagine del dizionario di greco – necessaria per tradurre nel modo più calzante una parola - dà sicuramente l’opportunità di abituarsi a valutare con cura le diverse espressioni, a cogliere le sfumature di ogni lemma. Questa abitudine si riverbera non solo nella migliore espressione orale, ma anche nella vita di tutti i giorni, nella quale ogni scelta verrà sicuramente effettuata in modo più oculato, solo dopo aver valutato tutte le possibilità che si presentano.
Avere ben chiara la struttura della frase greca è d’aiuto anche per gestire in modo eccellente quella di ogni frase italiana; sapersi muovere agilmente fra subordinate concatenate e legate da rapporti temporali complessi, come spesso accade in greco, aumenta l’agilità anche dell’espressione in italiano. Anche qui le abilità nella traduzione si concretizzano in una maggiore consapevolezza di come, nella realtà che ci circonda, ogni evento e ogni aspetto sia legato ad un altro, in un rapporto di predominio o di subordinazione. In più, essere abituati a gestire le difficoltà della lingua greca permette di superare agevolmente gli ostacoli che lo studio di una qualsiasi lingua moderna presenta inevitabilmente e di avere idee originali e compiute da esprimere.
Nella comprensione di un testo in greco, però, molto spazio spetta anche alla capacità di interpretazione, all’intuito, persino alla fantasia, assodato naturalmente che la base rimangono la conoscenza della grammatica e delle strutture sintattiche. Per tradurre bene bisogna sì valutare l’aspetto formale, ma si deve poi procedere a capire quali fossero le intenzioni espressive dell’autore, il perché delle sue scelte, cercando, perché no, di immedesimarsi in lui. Ecco che così, anche per capire meglio un proprio interlocutore in una qualsiasi discussione, il greco può dimostrarsi di grande importanza.
Quanto ho esposto finora dimostra già che l’astrazione cui fanno spesso riferimento i "nemici" del greco è una pura invenzione: anche lo studio sistematico di regole e strutture, se ben assimilato e reso parte integrante della propria personalità, diventa uno strumento spendibile nella vita quotidiana, nelle situazioni più disparate.
Il lungo tempo necessario per acquisire le numerose nozioni morfosintattiche che porteranno solo in un secondo tempo a padroneggiare la lingua greca insegna, per esempio, che certi risultati richiedono impegno, costanza e lungimiranza; si assimila anche la consapevolezza che obiettivi ambiziosi sono raggiungibili solo con un lungo lavoro preliminare e non tutto quindi si può comprare e ottenere con facilità e senza sforzi.
Se grande importanza, all’interno della conoscenza delle proprie radici, riveste l’aspetto linguistico e glottologico, è evidente che lo studio ben più ampio della cultura greca nel suo complesso abbraccia orizzonti quasi infiniti. È sì vero che per studiare la cultura greca non è indispensabile conoscerne la lingua, ma questo aiuta, e per almeno due ragioni: la prima è che spesso in una lingua, ed in particolare in quella greca, si specchiano aspetti importanti della cultura in cui essa viene utilizzata; non poter accedere al testo originale toglie molto alle sfaccettature della intera cultura greca. La seconda, poi, è che la possibilità di comprendere autonomamente le fonti non obbliga a dover sottostare all’opera del traduttore; in un certo senso ci si abitua a capire da soli ciò cui si è interessati, senza essere obbligati ad affidarsi ad un intermediario. L’impegno profuso per capire un fenomeno, la ricerca delle fonti, la responsabilità personale di chi vuole comprendere e analizzare porta in qualche modo a diventare cittadini più consapevoli, ma anche più liberi e più autonomi; non si rischia di fare la fine del povero Renzo Tramaglino che, di fronte alle dotte argomentazioni dei potenti, quali Don Abbondio e l’avvocato Azzecca-garbugli, non può far altro che protestare per il latinorum, che lui certo non mastica, convinto che dietro esso si nasconda un inganno. Ma non solo questo: la capacità di analizzare le fonti ha un peso non indifferente in un’epoca come la nostra, in cui Internet fornisce una congerie di informazioni e dati, incontrollabile e ingovernabile senza i necessari strumenti di selezione e di lettura approfondita.
In più, la traduzione è sempre necessariamente approssimativa, in quanto non riesce a rendere appieno sfumature di significato, etimologie interne, rime, assonanze, metrica e altro ancora. La lettura e la comprensione dell’originale forniscono una idea più precisa e veritiera delle intenzioni dell'autore e del suo stile.
Gli orizzonti della cultura greca spaziano dall’arte alle scienze, dalla letteratura tragica a quella della commedia e raggiungono il loro massimo nella filosofia, che abbraccia quasi ogni aspetto della vita dell’uomo. È evidente che un patrimonio di tali dimensioni ha un valore formativo immenso e l’avere una visione globale di tutto questo panorama culturale arricchisce chiunque.
Gli splendidi panorami offerti da ciò che resta degli edifici della colonizzazione greca in Italia sono un patrimonio prezioso che, conosciuto, valorizzato e sfruttato in modo adeguato, cioè puntando più sulla qualità che sulla quantità, potrebbe diventare una nuova consistente fonte di guadagno. Il nostro paese è, più di ogni altro, ricco di monumenti di ogni epoca; queste testimonianze del passato devono però essere studiate in modo che tutti le sappiano apprezzare e rispettare. In caso contrario si rischia di cadere nel turismo di massa incontrollato e, spesso, incosciente.
Non si può dimenticare, però, che sempre nel mondo greco-ellenistico vissero anche alcuni dei padri della matematica, della geometria e della fisica moderne, come ad esempio Euclide, Pitagora e Archimede. Sono loro ad aver espresso le prime nozioni in campo scientifico e ad averle messe in pratica, con la costruzione di macchine funzionanti, frutto però di un lavoro di progettazione e non del caso. È Euclide che, con il suo quinto postulato, ancora oggi fa discutere gli studiosi di geometria; se dopo più di due millenni la comunità scientifica nutre ancora un qualche interesse per la materia ci sarà pure un perché.
Il mondo greco classico, però, è ricordato, ancora oggi e sopra ogni cosa, per la sua ricchissima mitologia, i cui personaggi ormai fanno parte anche di fortunati spot pubblicitari come figure note al grande pubblico. In questo caso si fa un uso superficiale della mitologia, ma la scelta dei pubblicitari fa capire quanto essa sia radicata nell’immaginario di tutti noi; Zeus, Afrodite, Eolo e le altre divinità, conosciuti sui banchi di scuola e amati proprio per i loro difetti umani, sono figure sempre attuali. Dietro vicende spesso contorte, ripetitive, irreali, inquietanti nonché incestuose, ma apparentemente semplici e banali, si nascondono personaggi dal carattere multiforme, ma emblematico di quelli che sono i tratti caratteristici di molti di noi. Conoscere meglio queste figure significa anche capire meglio i nostri comportamenti, le nostre mancanze.
In questo senso anche le numerose opere teatrali in lingua greca offrono numerosi spunti di crescita. I drammi vissuti dai personaggi delle tragedie, pur se spesso esasperati, incarnano le paure più profonde di ognuno di noi, le esperienze-limite che nessuno vorrebbe mai vivere: è proprio da questa empatia dello spettatore con la vicenda narrata che nasce il fascino del teatro greco. In un certo senso esso era il progenitore dell’intrattenimento moderno, il cui scopo principale rimane sempre quello di suscitare emozioni, di terrore o di gioia, ma sempre emozioni forti e coinvolgenti. Il teatro greco, infatti, era anche la commedia, basata su un divertimento spesso sottile, ma talvolta anche greve come sempre più accade nei nostri spettacoli televisivi; alcune arguzie, risposte piccanti e provocatorie di molte commedie restano ugualmente fonte, nell’immediato, di grande divertimento per un lettore accorto, e sul lungo termine, di sviluppo di una profonda e pungente sagacia. Importante è anche il fatto che, al contrario di quanto molti pensano, la Grecia classica era sì un luogo di grande fermento culturale e filosofico e quindi di profonde riflessioni, ma era anche la culla di una civiltà gaudente, con la passione per le provocazioni.
Certo è che l’immagine della Grecia classica è, e non a torto, indissolubilmente legata alla filosofia. È proprio in Grecia che, in periodi di grande evoluzione, uomini di particolare intelligenza cercano di dare risposte, il più possibile razionali, ai grandi quesiti dell’uomo, che restano gli stessi ormai da millenni. Su molti aspetti la profonda evoluzione tecnologica e scientifica non ha saputo ugualmente dare risposte convincenti per tutti; ecco che l’opera dei vecchi filosofi si presenta come attuale, in quanto cerca di dare risposte attendibili, da raggiungere però sempre con l’uso del ragionamento e non affidandosi a dogmi.
Ed è proprio in questo processo di autonomia del ragionamento che la filosofia riveste il suo ruolo più importante: chi conosce le idee dei filosofi del passato ne viene arricchito, poiché le assimila in modo individuale, arrivando così, gradualmente, a diventare lui stesso un filosofo. In fondo un filosofo, secondo il suo etimo, non è nient’altro che un uomo che ama la saggezza; una persona curiosa è un filosofo, uno studioso è un filosofo, un cittadino responsabile è un filosofo. Anche un cittadino, infatti, deve poter ragionare sul mondo che lo circonda, farsene un’idea precisa e concreta, per poter agire di conseguenza in modo coerente con i propri principi, che pure deve sviluppare attraverso una analisi critica delle idee degli altri. In tutto questo processo la figura centrale diventa quella del singolo che, in quanto essere dotato di una mente propria, può godere di una delle poche libertà che nessun uomo potrà mai sottrarre ad un suo simile: la ragione.
Pensare di eliminare lo studio del greco e di tutto quello che esso porta con sé sarebbe un attentato al passato e quindi alla libertà del presente; sarebbe la definitiva recisione di quelle radici senza le quali il rigoglioso albero della civiltà si avvierebbe verso un lento ma inesorabile e rovinoso crollo.
(Federico Longobardi - I G)
---------------------------
Credo che nell’affrontare gli studi di un liceo classico da sempre ci si ponga l’interrogativo: ma sarà poi vantaggioso incaponirsi sullo studio di una grammatica complicata, noiosa e macchinosa di una lingua ormai morta da secoli che, ad un’analisi superficiale, presenta ben poche analogie con la lingua da noi parlata?
Il discorso è duplice: lo studente delle medie, poco più che bambino, si trova davanti ad una scelta più grande di lui; se esclude tutte quelle scuole (ragioneria, periti, licei linguistici, licei artistici) che richiedono un’abilità particolare, propria di ogni individuo, deve scegliere fra classico e scientifico. Quale studente non ha mai collegato il liceo classico con il greco? Nessuno, direi. Si può ben immaginare l’ipotetico alunno chiedere pareri ad amici che già frequentano il liceo classico e che, fatta eccezione di pochi, sporadici casi, gli elencano gli aspetti negativi della lingua. Lo studente che, nonostante gli illuminanti pareri degli amici, decide di frequentare tale scuola e di intraprendere dunque lo studio del greco, altro non può fare che vedere confermati i suoi sospetti: se l’analisi logica gli era sembrata un ostacolo insormontabile, ora deve cimentarsi con barbosissime e infinite regole dell’accentazione, quando nella materia parallela, il latino, è ormai un traduttore provetto. E, oltre al danno, la beffa: gli amici di altre scuole con cui accenna ad un dialogo, sono infastiditi da questa sua pseudo-cultura, e rifiutano ogni scambio di opinioni in merito, deridendo la sua fatica, bollandola come inutile perdita di tempo.
Col passare degli anni si acquisisce una certa pratica con la grammatica greca, ma ci si trova sempre davanti a nuove regole, la cui memorizzazione richiede un impegno costante ed uno studio approfondito.
Un altro aspetto è quello che riguarda il proseguimento degli studi: un “maturo” fresco di liceo classico, che volesse approfondire ciò che ha appreso con fatica nei cinque anni di scuola, si vedrebbe costretto ad orientarsi verso una facoltà classica, che sia storia, filosofia o lettere.
Al termine dell’università comincia il vaglio delle offerte di lavoro: quale occupazione si addice ad un giovane di tale cultura? La maggior parte dei laureandi in lettere diventa insegnante, mestiere che può essere considerato gratificante da un lato, specie se si ama il rapporto con gli alunni e si desidera esternare ad altri le proprie conoscenze, ma anche molto sconfortante, perché non sempre si sfruttano appieno le capacità di cui si dispone, costretti a seguire un programma coercitivo che tende a ripetersi all’infinito, e la cui variabilità dipende dalla disponibilità dell’insegnante stesso.
Un tredicenne poco maturo a cui venisse fatto un discorso di questo tipo indugerebbe non poco nella scelta del classico, perché si renderebbe conto che il greco, nella vita, serve a poco; fortunatamente parecchi altri suoi coetanei considerano il greco sotto un altro aspetto, che non è solamente quello che prende in considerazione i vantaggi più immediati, aspetto che, infatti, è molto, ma molto riduttivo.
Mi tocca ora elencare i vantaggi del greco, che, a differenza degli inconvenienti già citati, sono molto meno superficiali, e vanno compresi tenendo conto anche della mentalità di chi affronta questo tipo di studio.
Per mentalità intendo la forma mentis, vale a dire la capacità di ragionare e di considerare l’apprendimento secondo un criterio più complesso, se vogliamo, ma senza il quale il greco parrebbe a ragione la lingua morta, noiosa e complicata di cui si parlava prima.
È profondamente sbagliato che giovani a cui interessa ben poco, o quasi niente, lo studio del greco, intraprendano lo studio di una lingua che loro stessi ritengono essere incompatibile con la vita moderna, addirittura anacronistica.
Si trae una soddisfazione personale dallo studio dell’approfondimento del greco. Esso forma una mentalità che si basa su due punti fondamentali: gli strumenti e i contenuti.
Per quanto riguarda gli strumenti, il greco aiuta l’individuo ad acquisire una capacità di sintesi, che si ripercuote nella vita di tutti i giorni, e, non meno importante, ad una capacità di elaborazione ed analisi, che ha sia ripercussioni pratiche, sia (e questo è un aspetto fondamentale) ricadute sul potenziamento della capacità di apprendimento. Questo significa che studiando il greco la propria mente si esercita a comprendere e immagazzinare informazioni, e si predispone ad arricchirsi di sempre più elementi, senza vincoli, per così dire, di ristrettezza mentale.
Invece per quanto riguarda i vantaggi culturali, gli aspetti cioè che permettono di considerare la storia, la lingua, la società, ci interessano i contenuti. La considerazione più immediata e banale è che, studiando il greco, si analizza più a fondo la civiltà greca; per essere più precisi, si arriva ad affermare che lo studio del greco è il mezzo che permette di approfondire tutta la storia antica dell’uomo, in particolare per noi europei, che ritroviamo parecchie analogie della vita di allora con la vita di oggi, perché il nostro modo di pensare, di comportarci, ma soprattutto di parlare è un retaggio della cultura greca e di quella romana. Esiste, accanto ad un’agevolazione sullo studio della storia, una considerazione fondamentale che riguarda l’analisi letteraria, dato che, ricollegandosi al discorso che si faceva in precedenza, la nostra cultura è stata influenzata in particolar modo dall’immenso patrimonio letterario greco. Come faremmo a considerare la nostra stessa società senza conoscere il greco?
Molte, troppe persone ritengono che, al giorno d’oggi, lo studio del greco sia superfluo, dimenticando che si vive in un certo modo, proprio perché la storia, prima di noi, ha formato una mentalità particolare, che è scaturita da secoli e secoli di disquisizioni filosofiche, religiose, linguistiche e sociali a cui il greco ha dato tanto.
Il greco è quindi utile in una società costituita da troppi ingegneri, informatici, matematici: solo tecnici, insomma; esso rimane un privilegio, una lingua elitaria, riservata a pochi.
Chi lo ama veramente deve sempre più di frequente farsi carico delle critiche inconsistenti di chi crede di essere proiettato nel futuro, senza conoscere il proprio passato.
(Jacopo Busnach Ravenna - I G)