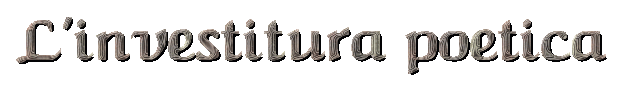
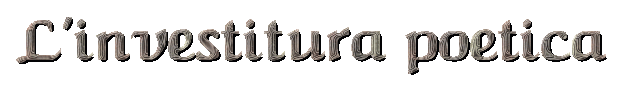
Nei poemi omerici si incontra più volte la figura dell’aedo: dal greco ἀοιδός (da ἀείδω), soprattutto nell’Odissea: Femio a Itaca, Demodoco alla corte dei Feaci (I, 337; VIII, 44, 479 e XXII, 345 ove l’aedo Femio canta per gli dèi e per gli uomini perché un dio gli ha ispirato tutti i canti; e XVII, 518 ss. ove si dice che i versi degli aedi provengono dagli dei; nell’Iliade cfr.IX, 186 e II, 486). Gli aedi sono cantori che recitano di corte in corte, senza un testo fisso, episodi liberamente ripresi da una materia mitica orale precedente, o addirittura inventati.
Il termine rapsodo si incontra in età posteriore (Pl. Ion. 530, 538 ss.; Pl. Rsp. 600; Ar. Eccl. 678): ῥαψῳδὸς potrebbe avere origine nel verbo ῥάπτειν "cucire" (Strabo, 18), oppure in ῥάβδος, il bastone cinto d’alloro, da cui il personaggio andrebbe inteso come mediatore fra dei e uomini.
Superando la non rigida distinzione evidenziata dalla critica riguardo alle due definizioni, possiamo intendere generalmente nell’aedo la figura depositaria, nei secoli, della memoria culturale mitica e storica delle età più antiche, e osservare come l’evolversi e l’affrancarsi di tale personaggio nella letteratura sia corrisposto a un progressivo mutamento della visione che i diversi autori avevano di se stessi e del loro mondo.
In una sorta di rapporto empatico, inizialmente l’aedo trasmette al pubblico il messaggio che ha ricevuto dalla Musa o da Apollo, dei quali la sua arte è il dono: l’"eletto" aedo è degno di onore e di rispetto perché amato e istruito dalla divinità, e si pone davanti agli uomini come il solo in grado di eternare i κλέα ἀνδρῶν. Il progressivo aumentare del numero degli aedi, nonché la "sfida" alla Musa di iniziare il racconto "da un punto qualsiasi" (Od., I, 10: ἁμόθεν) rivela, già nell’Odissea rispetto all’Iliade, quasi l’anticipo di una rivendicazione di individualità operata dal poeta, uomo che nel divino inizia a identificare un’ispirazione e non più il completo annullamento della propria persona (Od., I, 1: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα).
L’aedo Omero apre dunque, nel VII secolo a.C., la sua Iliade con un verso (Μῆνιν ἀείδε, θεά) che allude a uno stretto rapporto poeta-divinità; Dante, venti secoli più tardi, esordisce in ogni cantica della Commedia riproponendo il τόπος dell’investitura. L’immaginazione di Dante - secondo la critica - è visiva, e la sua precisione, sia nella Vita Nova che nella Commedia, proviene appunto dalla volontà di riprodurre esattamente ciò che egli ha chiaramente veduto. Così in Esiodo l’apparizione delle Muse è sentita come reale: quando, nel proemio della Teogonia, ricorda che le Muse gli parlarono sull’Elicona, non intende significare allegoricamente la sua ispirazione poetica, ma narrare un’esperienza realmente vissuta. In questa direzione sono da intendere i riferimenti, diretti e indiretti, a quelle stesse esperienze che compaiono nella cultura arcaica e classica.
Nel proemio della Teogonia le Muse non apostrofano benevolmente i pastori: li chiamano tristi creature, nient’altro che ventre. Le Muse dicono di se stesse che la loro parola è spesso inganno, ma che, quando vogliono, sanno dire il vero. Esistono quindi diversi tipi di poesia, e laddove Esiodo si sente chiamato a esporre la verità nei suoi versi, egli si contrappone a quanti affermano la stessa esigenza senza soddisfarla. In questo proemio troviamo così il primo spunto di una polemica letteraria, e le parole di Esiodo indicano la distanza che egli sente intercorrere fra sé e il mondo dell’epos omerico.
εἰμί δ`ἐγὼ θεράπων Ἐνυάλοιο ἄνακτος
καὶ Μουσῶν ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος
"Servo son io d'Enialio, signore delle battaglie;
e mi son cari i doni leggiadri delle Muse" (fr.1 D).
L’episodio di Archiloco che aiuta presso Lissides alcune donne a vendere una mucca e, dopo avere assistito al loro dissolversi nel nulla, scopre una lira innanzi ai suoi piedi, trova immediato riscontro nella simile esperienza narrata da Esiodo e, accanto a notevoli differenze d’intenti (non più solennità del prodigio divino, ma poesia giocosa, dello scherno e della critica mordace), mantiene lo schema della teofania, considerata, nella cultura arcaica, l’evento atto a risolvere i momenti decisivi dell’azione umana.
Dopo il prologo dei Telchini, Callimaco inizia la serie degli Aitia raccontando come da giovane si trovò in sogno sull’Elicona, dove gli apparvero le Muse. Con il poeta di Cirene le Muse si mostrarono più cordiali che con Esiodo, e soprattutto scompare l’intento morale, sostituito da quello didascalico-eziologico (le Muse narreranno le vere origini di miti e racconti) conforme alla nuova poetica callimachea; la citazione del prologo esiodeo vale tuttavia a rivelare l’avvenuto radicamento del τόπος dell’investitura nella letteratura greca.
Properzio, il "Callimaco romano", ricorre al primo proemio degli Aitia (l’invettiva contro i Telchini) in III, 1, e al secondo (il sogno delle Muse sull’Elicona) in III, 3. Properzio non è tuttavia il primo poeta latino che adotti lo schema della iniziazione poetica: Ennio volle essere l’Omero dei Latini (sebbene il procedimento annalistico da lui seguito fosse agli antipodi rispetto a Omero), e, introducendo nel proemio del poema una sorta di sogno, racconta che l’anima del cantore di Achille si era incarnata in lui, dopo avergli parlato sul monte delle Muse, non si sa se l’Elicona o il Parnaso. Alle Muse, in questo caso, è riservato uno spazio piuttosto esiguo, e la trasmigrazione dell’eccellenza poetica avviene tra due uomini; analogamente Eroda, nell’ottavo mimiambo, immagina di aver ricevuto l’investitura da Ipponatte, la cui influenza sul poeta di Coo si manifesta nell’uso del coliambo e nel colorito ionico del linguaggio.
Concludiamo l’excursus con l’analisi del τόπος dell’investitura in Persio (34-62 d.C.), che nel proemio in coliambi delle sue Satire respinge con durezza lo schema dell’ispirazione poetica (nec fonte labra prolui caballino... "non ho mai bagnato le mie labbra alla fonte del cavallo", con allusione alla fonte Ippocrene sul monte Elicona, sgorgata, secondo il mito, in seguito a un calcio del cavallo alato Pegaso) presente in Ennio e Properzio; la polemica, però, gravita nettamente contro i poeti contemporanei, non è rivolta a Ennio, Properzio, Orazio, Virgilio: la pretesa di essere ispirati da fonte divina, propria dei coevi verseggiatori, servili nell’imitazione e del tutto privi di originalità, è stroncata dal sarcasmo feroce di Persio, che, si è osservato, anche ammesso volga la sua aggressività al passato, mira a colpire il τόπος piuttosto che i poeti.
Con leggere varianti, dunque, il τόπος dell’investitura poetica si ripropone di frequente nei diversi autori delle varie letterature, e giunge a costituire una sorta di filo conduttore, simbolo, da Omero a Virgilio, da Ennio a Persio, da Esiodo al nostro Dante, di quell’estro divino che vive in ogni grande poeta.