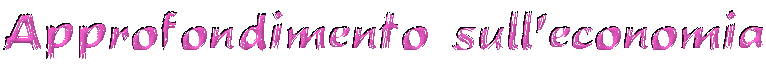
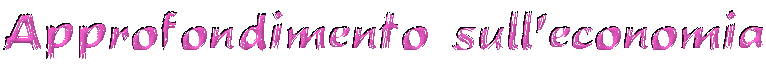
![]()
L'Argentina ha smesso di essere una colonia spagnola nel 1810. Nel corso del primo mezzo secolo d'indipendenza che ha permesso alla classe dominante di instaurare la sua dominazione, l'Argentina ha avuto dei punti in comune con l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. Essa è apparsa come un paese nuovo, un paese pionieristico. Ma a differenza di questi tre paesi, non è mai riuscita a sbarazzarsi completamente dei suoi tratti di antica colonia spagnola, cioè dipendente e arretrata. Come dichiarava, nel 1837, un portavoce della borghesia argentina, "le grandi idee della rivoluzione non sono state applicate. Noi siamo indipendenti ma non liberi. Le broccia della Spagna non ci opprimono più, ma le sue tradizioni hanno un grosso peso. Da tutto questo disordine anarchico nasce la controrivoluzione".
Come già notava più di 80 anni fa Lenin nel suo libro L'imperialismo, fase suprema del capitalismo, l'epoca imperialista non è solo segnata dall'esistenza di metropoli imperialiste e di paesi colonizzati ma anche dall'esistenza di "varie forme di paesi dipendenti che, di nome, beneficiano dell'indipendenza politica, ma che in realtà sono intrappolate nelle reti di una dipendenza finanziaria economica". Lenin citava l'Argentina come l'esempio di un paese intermedio tra le potenze imperialiste e i paesi interamente sottomessi a queste potenze.
E' resistendo ai tentativi militari d'invasione inglese del 1806 e 1807 che la borghesia dei criollos (creoli) che gli spagnoli nati in America, uno strato sociale dirigente d'origine europea, composta da commercianti, avvocati, clero e ufficiali dell'esercito, si formò una coscienza nazionale. Ma una volta affermata l'indipendenza politica la borghesia argentina si ritrovò, ancora per più di un secolo, nuovamente sotto la dominazione economica della Gran Bretagna, e del tutto naturalmente visto che una parte dei proprietari terrieri era di origine inglese.
 |
|
Ganaderos |
Nel 18° secolo si sviluppò una prima attività di allevamento dei bovini nella "pampa", la zona che copre un diametro di 600 km il cui centro è il porto di Buenos Aires. All'inizio della dominazione spagnola, il porto era servito soprattutto all'esportazione dell'oro e dell'argento preso nelle mine di Potosi (Perù). Tra il 1785 e il 1795, si assiste ad una vera esplosione delle esportazioni di pezze di pelli che da 1.4 milioni passarono a 13 milioni. Di conseguenza l'allevamento fece seguito all'esaurimento del bestiame che fino a quel momento viveva allo stato selvaggio, riproducendosi in tutta libertà nella pampa. La figura romantica del gaucho, guardiano di vacche nomade, era legata a questa realtà economica primitiva. Ma a partire del 19° secolo, l'addomesticamento del bestiame selvaggio e l'allevamento si organizzarono intorno alla grande proprietà terriera, il grande dominio (latifondo) dipendente da una grande fattoria (estancia). Questa trasformò il gaucho in operaio agricolo. Il moltiplicarsi dei reticolati che circondarono le grandi proprietà a partire dal 1850 e le leggi sulla proprietà della terra, entrate in vigore nel 1876, accentuarono ancora di più la tendenza alla concentrazione terriera e rinforzarono l'oligarchia dei ganaderos (proprietari di bestiame).
Questo sistema di sfruttamento peserà sulle sorti del paese. La sua caratteristica principale era di esigere poca mano d'opera, poca tecnica e quindi poca organizzazione. Un amministratore e una decina di operai agricoli bastavano per occuparsi di una fattoria di 15.000 a 20.000 ettari di terra con 10.000 capi di bestiame. Questo fattore costituì un freno alla crescita demografica (oggi l'Argentina, la cui superfìcie è tre volte inferiore a quella del Brasile, è cinque volte meno popolata). Parallelamente lo sviluppo di Buenos Aires portò la rovina dell'artigianato nelle provincie del paese, impedendo, ad esempio, il proseguimento dell'industrializzazione che aveva interessato il nord-ovest del paese, che confina con il Perù.
![]()
Fu la crisi del 1929 che cambiò la situazione, portando una notevole riduzione alle esportazioni. L'entrata di capitali stranieri fu bloccata. In pratica la capacità d'importazione del paese fu ridotta alla metà da un giorno all'altro. Questo avvenimento permetterà un inizio di industrializzazione. Ma le industrie che si misero in attività tra il 1930 ed il 1950 avevano l'intenzione di produrre solo quei beni che dovevano rimpiazzare le importazioni, che a loro volta erano destinate a soddisfare i bisogni della stretta cerchia dei possidenti. L'industrializzazione si restrinse dunque, principalmente, a quei settori che non richiedevano grandi investimenti: tessile, alimentazione, bibite, tabacco, pelli, metallurgia leggera, petrolio. La ripartizione delle rendite restava invariata.
Fino al 1945, data alla quale questa industrializzazione di sostituzione alle importazioni cominciò a rallentare, l'Argentina disponeva, in gran parte grazie al fatto che la guerra bloccava gli scambi, di un saldo commerciale positivo. Con la difficile situazione in Europa alla fine della guerra, si assistette ad un aumento incredibile dei prezzi mondiali dei prodotti alimentari. Questo insieme di avvenimenti favorevoli permise al regime peronista, instauratesi nel 1945, di comprare la pace sociale aumentando leggermente i consumi delle classi povere. Tra il 1946 ed il 1949 la parte degli stipendi sull'insieme del reddito nazionale passò dal 37,3% al 45,7%.
![]()
Fu a quest'epoca che nacque la CGT argentina, che resta ancora oggi la carta migliore del partito peronista. Al potere dal 1945 al 1955 Peron diresse un regime bonapartista che si basava su di una coalizione di forze che riunivano una parte dell'esercito (Peron era un ufficiale superiore che era stato simpatizzante del regime mussoliniano), del grande padronato e dei sindacati. Era un potere forte che voleva intervenire in modo autoritario nella vita economica, liberarsi dalle grinfie britanniche, e che si assicurò la pace sociale con una politica d'integrazione dei sindacati nello Stato, istituzionalizzando la collaborazione di classe. Prendeva in prestito alcuni degli aspetti dallo Stato delle corporazioni di Mussolini, ma prendeva spunto anche dalla politica adottata da Cardenas in Messico alla fine degli anni trenta.
 |
|
Descamisados |
Lo Stato nato dalla rivoluzione messicana aveva scelto una politica di integrazione dei sindacati allo Stato, di maniera di installare il suo potere sull'esercito e sulla classe operaia, a vantaggio della borghesia messicana. Lev Trotskji aveva descritto così le caratteristiche di questo tipo di regime bonapartista : "Nei paesi arretrati industrialmente, il capitale straniero gioca un ruolo decisivo. Di conseguenza la borghesia nazionale è relativamente debole nei confronti del proletariato nazionale. Questo crea delle condizioni particolari per il potere di Stato. Il governo cerca di barcamenarsi tra il capitale straniero e il capitale nazionale, tra la debole borghesia nazionale e un proletariato relativamente potente. Questo conferisce al governo un carattere bonapartista sui generis particolare. Si pone, in qualche modo, al di sopra delle classi. In realtà, può governare, sia diventando lo strumento del capitale straniero pur mantenendo il proletariato nelle catene della dittatura militare, sia con delle manovre rispetto al proletariato e addirittura facendogli delle concessioni così da conquistarsi la possibilità di godere di una certa libertà nei confronti dei capitalisti stranieri. "
Peron portò dietro di sé il proletariato che si era sviluppato sulla base dell'industrializzazione cominciata nel 1930, allo stesso tempo che i ceti della borghesia industriale contenta di sbarazzarsi della tutela dell'Inghilterra. Al proletariato dei "descamisados" ("i senza camicia") il demagogo Peron teneva un discorso radicale, parlando di "rivoluzione sociale" : "intendo migliorare il tenore di vita e proteggere i lavoratori più modesti dallo sfruttamento capitalista". Questo si mischiava con un discorso nazionalista :"stiamo gettando il seme per fare fiorire una patria libera che non accetta mercanteggiamenti di sovranità. "
Ma quando Peron si rivolgeva al padronato, spiegava così le sue intenzioni : "è un grave errore credere che il sindacalismo operaio sia dannoso per il padrone... Al contrario, è la forma che permette di evitare che il padrone abbia da lottare contro gli operai". E aggiungeva '."Vi è stato detto che io sia un nemico dei capitalisti, ma (...) non troverete nessun difensore più deciso di me : perché io so che la difesa degli interessi degli uomini d'affari, degli industriali, dei commercianti, è la difesa dello Stato stesso. "
La situazione eccezionale dell'Argentina all'indomani della guerra gli permise di ottenere il sostegno delle masse lavoratrici con una politica dei salari relativamente alti, il cui simbolo fu la concessione di una tredicesima rimasta nelle memorie operaie. La CGT diventò un vero organo dell'apparato statale. L'attivo delle casse dello Stato col quale le condizioni di vita dei lavoratori furono migliorate, permise anche di mettere in piedi una vera burocrazia sindacale. Ai lavoratori avversari del nuovo regime, quelli rimasti fedeli al Partito comunista per esempio, si rifiutava l'accesso alle assemblee generali o alle riunioni delle sezioni sindacali (le commissioni interne). Dal 1946 al 1949, centinaia di scioperi furono dichiarati illegali o repressi. Intere sezioni sindacali combattive furono sciolte. La CGT non esitava a reclutare dei teppisti per lanciarli contro gli scioperanti. Dei sindacalisti rimasti indipendenti furono torturati o assassinati. Le carceri si riempirono di lavoratori combattivi, denunciati dalla CGT.
![]()
Nel 1955 un altro militare, il generale Lonardi, rovesciò Perno con il beneplacito dell'imperialismo americano che non vedeva di buon occhio questo governo che pretendeva di essere indipendente. La CGT si trasformò allora in un apparato più federale, con varie correnti, raggnippando una maggioranza di organizzazioni dell'area peronista (le "62 organizzazioni"), nonché antiperoniste (32 organizzazioni) o addirittura dell'area del partito staliniano (10 organizzazioni). Fin dalla caduta di Peron il suo partito, il partito giustizialista, fu vietato dai militari. Durante venti anni, l'opposizione peronista si espresse innanzitutto tramite la CGT.
I dirigenti della CGT gareggiavano per avere l'avallo di Peron rimasto in esilio. Non si trattava di un attaccamento disinteressato. Ai burocrati sindacali serviva il "mito Peron", ben vivo tra i lavoratori argentini, per mantenere la loro autorità sulla classe operaia.
Così il movimento peronista continuava a rappresentare una forza politica considerevole, con cui i presidenti eletti e i generali golpisti che si alternarono al potere dal 1955 al 1973 dovettero fare i conti.
Fino agli anni sessanta l'industrializzazione si estese a nuovi settori : chimica, metallurgia di base, macchine e veicoli, al ritmo dell'8,6% per questi soli settori. Ma gli investimenti provenivano in maggior parte dall'estero : 97% nell'industria automobilistica, 70% nell'elettronica. Soprattutto l'agricoltura rappresentava sempre la maggiore fonte di redditi, nonostante i suoi metodi arcaici : nel 1960 il consumo di concimi era solo di 0,5 kg ad ettaro (invece di 39 kg negli StatiUniti e di 21 kg in Australia). Nel 1949 il 29% della popolazione attiva lavorava in campagna. Questa proporzione era ancora del 20% negli anni settanta.
Ma la parte più importante della ricchezza andava sempre agli stessi ceti dominanti. I più ricchi, il 5% della popolazione, godevano di un tenore di vita identico a quello dei più ricchi paesi capitalisti sviluppati. Invece la massa salariata, che era cresciuta durante il decennio peronista, tornò a ridursi. La produttività aumentava con ritmi più rapidi di quelli dei salari reali. Inoltre la centralità dell'impiego industriale nella provincia di Buenos Aires portava a forti differenze tra la capitale e le provincie. Nel 1963 le provincie, col 75% della superfìcie totale e il 33% della popolazione, producevano solo il 20% della ricchezza. I salari potevano essere inferiori del 60% a quelli della capitale.
La bilancia commerciale rimaneva segnata dal suo deficit. La partecipazione argentina alle esportazioni agricole mondiali diminuì fortemente, dal 3,1% del totale nel 1928 allo 0,4% nel 1980. Eppure nei venti anni successivi la produttività agricola stava per raddoppiare, tra l'altro grazie a nuove tecnologie. Grazie a questo l'agricoltura argentina ritrovò lo stesso volume di attività, al costo però di uno sfruttamento furibondo. Invece non cambiò la ripartizione delle terre. Secondo una valutazione degli anni novanta, 1' 1,31 % delle tenute di più di 5000 ettari accaparra il 46,7% delle superfìci mentre le tenute da 1 a 25 ettari (41,4% delle tenute) rappresentano meno dell'l% delle superfìci coltivate !
Tra il 1950 e il 1963, le esportazioni non riuscivano a pareggiare i bisogni d'importazioni in aumento grazie alla crescita del settore industriale. A causa del ritardo dell'industrializzazione e di innumerevoli difficoltà tecniche ed economiche, le imprese potevano soddisfare la domanda di macchinari solo a costi altissimi. Quando i prezzi raggiungevano un certo livello, le imprese straniere diventavano più competitive. Entravano allora sul mercato argentino, assorbivano le imprese locali ed imponevano prezzi da monopolio che impedivano ogni ribasso dei prezzi.
 |
|
Videla |
Così dal 1959 al 1969 le imprese collegate a grandi multinazionali si radicarono . La loro partecipazione al capitale industriale era quasi dell'80% nel 1969.1 governi successivi tra il 1955 (caduta di Peron) e il 1976 (colpo di Stato militare di Videla) che pretendevano di difendere gli interessi dell'economia nazionale, non avevano più la volontà politica né di opporsi alle grandi imprese straniere né di ridurre la parte di ricchezza prelevata dalla borghesia locale.
![]()
Nel 1969 il sollevamento operaio di Cordoba segnò l'inizio di un periodo di radicalizzazione del movimento di massa che portò la borghesia argentina a fare di nuovo appello a Peron nel 1973.
Non si trattava più però di concedere alcune briciole alla classe operaia per ottenere il suo sostegno. Si trattava di addormentarla e demoralizzarla, con aiuto dell'apparato CGT. Durante i tre anni dal 1973 al 1976 in cui la contestazione rimase forte, i dirigenti sindacali furono all'unisono con l'ala più reazionaria del movimento peronista, la destra e l'estrema destra. Questo secondo peronismo portò alla peggiore dittatura militare mai vista in Argentina, dal 1976 al 1983. Questo periodo segnò profondamente la società argentina. A dimostrarlo c'è il cosiddetto movimento delle "madri della Piazza di Maggio", queste madri di militanti che ebbero il coraggio di protestare pubblicamente, in piena dittatura, e ancora oggi continuano a chiedere la verità sulla sorte dei figli, e qualche volta nipoti. Malgrado gli sforzi dei dirigenti politici, radicali e peronisti, per proteggere i quadri dell'esercito dalla maggior parte delle azioni giudiziarie, alcune imperfezioni del sistema hanno permesso almeno che decine di alti quadri della giunta militare siano oggi in residenza vigilata, se non in carcere. Il bilancio politico della dittatura fu particolarmente duro, con 30000 dispersi (di cui molti militanti operai peronisti di base), ma il bilancio economico lo è almeno altrettanto.
Infatti la giunta del generale Videla diede il via allo smantellamento dell'apparato di controllo governativo per imporre un cosiddetto "mercato libero", eliminare i monopoli di Stato della carne e delle cereali, assegnare le esportazioni alle ditte private ed aumentare le sovvenzioni all'agricoltura, cioè all'oligarchia. La soppressione delle barriere doganali aumentò ancora le difficoltà dell'industria locale. D'altra parte il ribasso dei salari portò anche al calo della domanda di manufatti. La vendita delle automobili, per esempio, diminuì di pressoché un terzo. Gli investimenti produttivi subirono una battuta d'arresto a vantaggio della speculazione.
Questo processo fu in parte bilanciato dallo sviluppo, con l'aiuto della dittatura, della finanza e del sistema bancario. Ma il blocco dei salari non arrestò l'inflazione. La riduzione del disavanzo del bilancio portò ad una riduzione dell'attività economica. La giunta impose alla popolazione un forte calo del tenore di vita. Nel 1977 il potere d'acquisto era diminuito del 60% rispetto al 1974. Il plusvalore si concentrò di nuovo verso i proprietari fondiari, la cui quota nel reddito nazionale aumentò un po' mentre grazie al ribasso dei salari i profìtti degli industriali non furono intaccati.
Il radicale Raul Alfonsin, quando fu eletto presidente della Repubblica nel 1983, all'uscita della dittatura, si trovò di fronte ad una situazione che già si riassumeva così :enorme inflazione, recessione drammatica, debiti esteri mostruosi.
Le misure economiche, conosciute sotto il nome di "piano austral", varate da Alfonsin in pieno accordo con i banchieri dell'FMI, non portarono nessun miglioramento. Fin dal 1984, il fatto che tutte le eccedenze servivano a pagare i debiti esteri non impediva che questi crescessero da 43 a 60 miliardi di dollari. Nello stesso periodo la svalutazione della moneta argentina rispetto al dollaro fu quasi del 5000%. I tassi d'interesse furono tali che i possessori di capitali preferivano di gran lunga gli investimenti speculativi. Di conseguenza gli investimenti produttivi diminuirono regolarmente. La produzione nel 1989 era inferiorea quella del 1974 e la parte dei salariati nel reddito nazionale, che fin dal 1945 era stata del 35% in media con un pico al 45%, era caduta al 28%. La disoccupazione era già del 15%.
![]()
Quando il peronista Carlos Menem fu eletto presidente nel luglio 1989, il paese contava 30 milioni d'abitanti, di cui 9 milioni di poveri. Ogni mese i prezzi raddoppiavano. Menem decise immediatamente di accelerare la privatizzazione di tutte le imprese pubbliche, che passarono tra le mani di operatori privati, argentini e stranieri.
Menem iniziò anche una deregolamentazione in tutte le direzioni, fino alla liquidazione delle Enti nazionali del grano, della carne, del vino, che applicavano i regolamenti aboliti. Favorì le esportazioni e abbassò le imposte doganali. Dal punto di vista sociale lo Stato si disimpegnò dalle trattative salariali e impose la flessibilità del lavoro, mettendo in forse molti diritti acquisiti durante il primo governo peronista.
Difatti lo Stato argentino aveva da molto tempo abbandonato le sue imprese e la loro privatizzazione veniva a conclusione di anni senza investimenti, di rovina delle infrastrutture (le ferrovie in particolare, la cui lunghezza totale era passata da 46000 km a meno di 35000), di disprezzo dell'utenza e di corruzione.
Le privatizzazioni arricchirono ancora i più ricchi, mentre si moltiplicavano le vittime : impiegati del settore pubblico licenziati, abbandono dei settori tessili e delle macchine utensili. Categorie intere si impoverirono: pensionati, maestri delle scuole medie, statali. Questi nuovi poveri si aggiungevano a quelli precedenti, quelli che non avevano mai potuto accedere ai servizi elementari : alloggio, acqua potabile, istruzione.
Col ristabilimento nell'aprile 1991 della libera convertibilità della moneta nazionale, l'austral (che fu di nuovo chiamato peso fin dal 1° gennaio del 1992), il ministro dell'Economia Domingo Cavallo (ex presidente della banca centrale durante la dittatura militare) riuscì però ad arginare l'iperinflazione (4933 % nel 1989 e "soltanto" 1355 % nel 1990), questa situazione in cui ognuno assisteva impotente al volatilizzarsi del proprio potere d'acquisto. Questo successo rese possibile la rielezione di Menem. Ma al termine del suo secondo mandato, gli argentini si ritrovarono con una recessione e debiti esteri ancora più mostruosi.
Fonte: http://www.giovanetalpa.net/argentina.htm