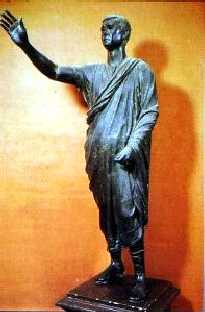
Atene, V secolo a.C. : l’epoca della prima Sofistica,
quando per la prima volta si mise in crisi la concezione di Verità come entità
assoluta, oggettiva e universalmente riconoscibile, si sviluppò una teoria
cosciente del linguaggio e l’oratoria si definì come techne regolata da una
serie di principi fissi trasmissibili attraverso l’insegnamento
La nascita della retorica e l’abbattimento delle verità uniche e precostituite
Novità dell’approccio sofista
• viene elaborata una teoria del linguaggio, che
fa dell’eloquenza non più un talento meramente innato, bensì una techne, cioè
una forma di sapere che può essere insegnata e appresa, perché regolata da un
insieme di leggi e di artifici ben precisi > uso scientifico dell’eloquenza,
nascita della retorica;
• si associa al problema del linguaggio una
consapevolezza filosofica, ovvero la nozione dialettica del reale, cui
spesso segue il relativismo culturale (vedi gli anonimi Ragionamenti doppi,
le Antilogie protagoree);
•
si fa riferimento
a una dimensione politica entro cui il linguaggio è uno strumento
imprescindibile di comunicazione e di persuasione (Atene, V secolo a.C.:
nascita della democrazia: necessità di una nuova forma di paideia adeguata alle
esigenze della nuova classe dirigente). D’ora in avanti la retorica sarà
indissolubilmente legata all’attività giudiziaria e politica. Tant’è
vero che, venendo a mancare il retroterra politico (come fu ad esempio a Roma
nell’età dell’impero), si assiste a uno svuotamento di significato della
retorica (esiti della Seconda Sofistica, riflessioni di Tacito nel Dialogus
de oratoribus).
Linguaggio e verità
Scrive Fornero: “L’importanza della
parola è una delle grandi scoperte dei Sofisti. Ma essi non si limitarono a
celebrarne la potenza, poiché la tematizzarono sul piano filosofico,
studiandone i problematici rapporti con la realtà e la verità. Per gli
antichi filosofi il linguaggio non costituiva un interrogativo, in quanto essi
erano spontaneamente indotti a collegare, e quasi a non distinguere, fra la
cosa reale, il pensiero che la conosce e la parola che l’esprime. Essi
ritenevano che ciò che vale sul piano logico del pensiero debba valere anche
sul piano della realtà e viceversa. Per cui essere = pensiero = verità. I
Sofisti, in virtù della loro nuova impostazione, scuotono queste primitive
certezze e la realtà dall’altro.”
Per la prima volta si prospetta dunque la
possibilità che invece di una Verità inossidabile e accessibile ai “sapienti”
esista una pluralità di opinioni, nessuna più “vera” e incontestabile
delle altre, e ognuna potenzialmente vincente se si sanno impugnare le armi
della persuasione.
Vivere in democrazia
Scrive Geymonat: “Vivere attivamente
in democrazia significa partecipare ad assemblee, prendervi la parola,
far valere con efficace discorso la propria opinione frammezzo alle altre
opinioni; e perciò saper pesare la varie accezioni e sfumature dei vocaboli,
avere nell’orecchio le più felici espressioni dei poeti, riuscire a disporre i
periodi in un ordine che incateni l’attenzione, accenda le fantasie e susciti i
consensi: significa insomma possedere quel complesso di cognizioni
grammaticali, lessicali, sintattiche, stilistiche, letterarie che costituisce
l’arte dell’eloquenza.”
I Sofisti e la morale
Scrive Untersteiner: “Per il Sofista non esiste
effettivamente un’assoluta ορθότης : ορθόν è ciò che talora, mediante ragioni,
può essere reso più verosimile di altro, ciò che soprattutto opera in
modo persuasivo, finché si presenti qualche cosa d’altro più verosimile.
[…] Il principio di τόν ήττω λόγον κρείττω ποιειÞν doveva trovare un
particolare sviluppo nel mondo della retorica, che in quei tempi si imponeva
come un problema pratico e politico, giacché sia nei discorsi giudiziari sia in
quelli deliberativi era necessario, per vincere, saper imporre il proprio
punto di vista, la propria verità, la quale poteva anche non coincidere con la
verità in senso universale: non era dunque la retorica necessariamente
immorale, ma perseguiva fini pratici, cosicché doveva rinunciare a un
atteggiamento teoretico, su cui l’eloquenza non poteva fondarsi. Protagora non
ammette che in ogni dominio sia da attuare, con l’abilità oratoria, in luogo
del bene il male ammantato dal luccichio delle apparenze.”
Schopenhauer e
la dialettica
v “La dialettica è l’arte di disputare, e
precisamente l’arte di disputare in modo da ottenere ragione, dunque per
fas et nefas.”
v “La verità oggettiva di una proposizione e la validità
della medesima nell’approvazione dei contendenti e degli uditori sono due
cose diverse. A quest’ultima è rivolta la dialettica.”
v “Bisogna separare nettamente il reperimento della
verità oggettiva dall’arte di imporre come vere le proprie tesi. Per formulare
la dialettica in modo limpido bisogna considerarla, senza badare alla verità
oggettiva, semplicemente come l’arte di ottenere ragione, la qual cosa sarà
certo tanto più facile se si ha oggettivamente ragione.”
v
“Se ci poniamo
come fine la pura verità oggettiva ritorniamo alla mera logica;
se invece poniamo come fine l’affermazione di tesi false abbiamo la mera
sofistica. E in entrambi i casi il presupposto sarebbe che noi sapessimo
già che cosa è oggettivamente vero e falso: ma solo di rado questo è
certo in anticipo.”
(Da L’arte di ottenere ragione)
Aristotele e la dialettica
Nelle Confutazioni sofistiche Aristotele
distingue la dialettica sia dalla sofistica
(“una sorta di sapienza apparente senza esserlo”) sia dall’eristica (“un
combattimento ingiusto nell’opposizione verbale), per recuperarla come strumento
e procedimento ideale per la speculazione filosofica: durante una
discussione, “essendo in grado di sviluppare le difficoltà in entrambe le
direzioni, in ciascuna vedremo più facilmente il vero e il falso”; “rispetto
alla conoscenza e alla saggezza che è conforme alla filosofia, non è compito di
poco conto l’essere in grado di abbracciare e d’aver abbracciato con lo sguardo
le conseguenze nel caso di ciascuna ipotesi: resta infatti soltanto da
scegliere correttamente l’una o l’altra di queste”. Per Aristotele dialettica e
filosofia hanno lo stesso scopo, cioè la conoscenza; la dialettica senza
filosofia è vuota, la filosofia senza dialettica cieca.
Gorgia e il crollo delle Verità
Le tesi contenute nel Περί του μή όντος:
1.
niente esiste
2.
se anche qualcosa
esiste, è inconoscibile per l’uomo
3.
se anche è
conoscibile non si può comunicare e spiegare
v Conseguenze:
v Gorgia scardina l’idea di una verità ultima,
unica, oggettiva e universale;
v se una verità ultima delle cose non esiste, pensiero
e parola non sono più in rapporto univoco, ed ogni volta che usiamo il
linguaggio possiamo al massimo perseguire l’obiettivo di una verità
contingente, che vale solo per l’istante in cui la pronunciamo;
v la parola diventa uno strumento di persuasione
onnipotente
Gorgia e la parola
“La parola è un gran dominatore che, con un corpo piccolissimo
e invisibilissimo, divinissime cose sa compiere; riesce infatti a calmare la
paura, a eliminare il dolore e a suscitar la gioia e a ispirare la pietà… E che
la persuasione, congiunta con la parola, riesca a dare all’anima l’impronta che
vuole, ce lo insegnano soprattutto i discorsi degli astronomi, i quali,
sostituendo ipotesi a ipotesi, distruggendone una, costruendone un’altra, fanno
apparire agli occhi della fantasia l’incredibile e l’incomprensibile; in
secondo luogo le gare oratorie, nelle quali un discorso scritto con arte, ma
non ispirato a verità, suole dilettare e persuadere la folla; in terzo luogo le
schermaglie filosofiche, nelle quali si rivela anche con che rapidità
l’intelligenza facilita il mutare convinzioni della fantasia. C’è tra la
potenza della parola e l’ufficio dell’anima lo stesso rapporto che tra
l’ufficio dei farmaci e la natura del corpo.”
(Dall’Encomio di Elena di Gorgia)
Il giudizio di Platone nel Gorgia
Socrate – Da un pezzo mi vado domandando quale mai sarà la
potenza di codesta retorica. Dico la verità, quando ci penso, mi appare per la
sua potenza quasi divina.
Gorgia – E più stupiresti, se ne conoscessi tutta la
potenza. Perché si può proprio dire che la retorica concentri in sé tutte le
altre potenze e tutte le domini. Te ne voglio dare una prova evidente.
Spesso io stesso mi sono trovato, insieme con mio fratello e con altri medici,
presso qualche ammalato, che si rifiutava di prendere una medicina, o che non
voleva lasciarsi dal medico tagliare o bruciare; e mentre il medico non
riusciva a persuaderlo, io ci riuscivo -
e con nessun altro mezzo se non con la retorica. Perciò io dico che in
qualunque città si rechino un oratore e un medico, se è innanzi all’assemblea
popolare o a qualunque altro consesso, attraverso una discussione, che si deve
scegliere fra i due uno come medico, il medico non avrebbe in nessun modo il
mezzo di affermarsi e anche come medico sarebbe preferito l’oratore, dato che
egli lo volesse. E con chiunque si trovasse a competere, io dico che il retore
riuscirebbe a farsi eleggere nel confronto con qualsiasi altro tecnico, perché non
vi è cosa in cui un uomo esperto della retorica non possa riuscire più
persuasivo di qualsiasi competente, parlando innanzi a un’assemblea. Tale e
così grande è la potenza di quest’arte.
I Ragionamenti doppi
In quest’opera anonima viene parzialmente confutato il
giudizio negativo di Platone sui Sofisti:
“Io credo che spetti alla medesima persona
e alla medesima arte avere la capacità di discutere con rapide risposte,
conoscere la verità delle esperienze, saper rettamente giudicare, possedere
l’attitudine a fare discorsi politici, sapere l’arte della parola e insegnare
intorno alla natura di tutto in relazione alle sue proprietà e alla sua
origine. Anzitutto, colui che possiede una conoscenza intorno alla natura di
tutto, come non sarà in grado anche di operare rettamente di fronte a ogni
situazione? Inoltre anche chi conosce l’arte della parola saprà parlare
rettamente intorno a tutto. Infatti è necessario che chi si propone di parlare
rettamente parli intorno a ciò che sa. Di conseguenza egli s’intenderà di
tutto. Egli infatti conosce l’arte di ogni discorso e tutti i discorsi
riguardano la realtà.”
L’eredità dei Sofisti
1. Crollo di ogni certezza precostituita > dalla
Verità universale a un mondo di verità personali e circoscritte > idea
pluralistica
2. nascita della retorica e dell’oratoria: uno strumento
di persuasione volto esclusivamente a riscuotere il consenso di un uditorio e a
far prevalere la propria opinione
3. “democraticizzazione” dell’eloquenza che diventa un
sapere acquisibile da chiunque
4. almeno in nuce, la possibilità di manipolare a proprio
piacimento il consenso dell’uditorio grazie alle tecniche della retorica