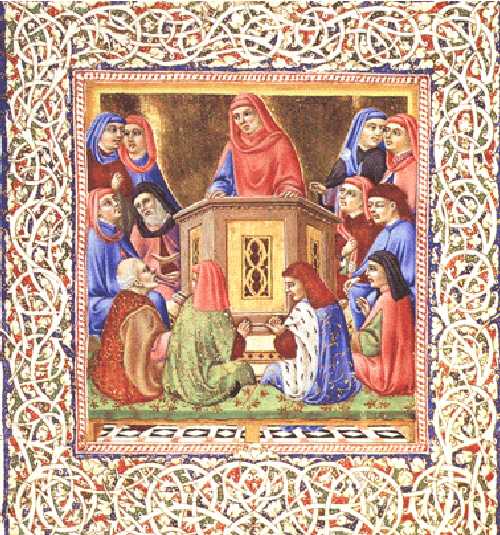
Roma, I secolo a.C. – I secolo d.C. : l’età
repubblicana e i primi passi dell’impero, quando si ebbe prima uno sviluppo
effimero ma eccezionale dell’oratoria politico-giudiziaria (Cicerone,
analizzato in particolare nei suoi rapporti di debito e di originalità rispetto
ai Sofisti); uno studio approfondito dei meccanismi della retorica nonché degli
obiettivi e della formazione dell’oratore (Quintiliano); e un approccio critico
al problema dei rapporti tra oratoria e democrazia (Tacito) che ci introduce al
problema del pluralismo
La
breve stagione dell’ oratoria di Cicerone
La
lenta decadenza dell’eloquenza nelle opere di Quintiliano e di Tacito
Tra il
IV e il I secolo a.C.
si assiste in Grecia al crollo
della polis e all’assoggettamento ai Macedoni: pur restando in vita le
istituzioni tradizionali, la libertà politica delle città stato viene di fatto
svuotata di consistenza, perché le decisioni sostanziali non dipendono più
dalle direttive concordate al loro interno. Di conseguenza, l’oratoria
sviluppatasi ad Atene nel V secolo a.C. va incontro a un processo di
impoverimento che la induce a farsi raffinato gioco intellettuale senza alcun
significato politico;
si assiste in ambito mediterraneo
all’ascesa di Roma, che va conquistandosi un ruolo egemone sia come potenza
politica sia come centro culturale. Lentamente va sviluppandosi una
“consapevolezza teorica” nel campo della retorica, che si concretizza nei primi
manuali (La Rhetorica ad Herennium e il De Inventione di
Cicerone) che trova appunto in Cicerone la sua massima espressione.
La
retorica a Roma al tempo di Cicerone
Scrive Flocchini: “Da una
parte i Retori, come ad esempio Menedemo citato nel De oratore,
proponevano un metodo educativo basato esclusivamente sull’apprendimento delle
tecniche dell’eloquenza, senza preoccuparsi dei contenuti, dall’altra i
Filosofi ne contestavano la validità, sostenendo che esso non garantiva la
conoscenza della verità e non insegnava a reggere e amministrare lo Stato.
Cicerone cercò di ricomporre l’antica unità, elaborando un sistema retorico in
relazione alla filosofia e sottolineando che, se spetta al filosofo indagare e
analizzare la verità, è poi compito del retore divulgarla, ma tutti e due non
possono non incontrarsi in zone determinate del sapere dove una vivisezione
netta di principi e un’assoluta discriminazione di competenze sono nocive e
alla retorica e alla filosofia. Le ipotesi (quaestiones finitae) che
rappresentano l’ambito particolare dell’oratoria, non possono infatti non
rimandare a tesi (quaestiones infinitae) cioè a quei temi generali la
cui indagine spetta alla filosofia: così, ad esempio, in una causa del genus
iudiciale, rientrano le tesi de aequo et iniquo e de iusto et
iniusto.”
L’oratore
per Cicerone
Cicerone parte da una concezione etica dello Stato: esso deve essere governato da uomini politici caratterizzati da
1)
onestà;
2)
acume politico;
3)
sapientia;
4)
capacità di farsi portavoce degli interessi della comunità
e
di essere validi leader dei concittadini.
L’uomo politico viene a
coincidere con l’oratore (vir bonus dicendi peritus) perché non potendo imporre
le proprie scelte sulla città con la forza (stato di natura), è essenziale che
sia in grado di padroneggiare la parola per persuadere i cittadini a prendere
decisioni conformi ai suoi assunti (stato di diritto).
La
forza della parola (I)
“In verità, non c’è niente per me di più bello
del potere con la parola dominare gli animi degli uomini, guadagnarsi le loro
volontà, spingerli dove uno voglia, e da dove voglia distoglierli. Presso tutti
i popoli liberi, e soprattutto negli Stati tranquilli e ordinati, quest’arte è
sempre stata tenuta nel massimo onore e ha sempre dominato. Infatti, che cosa
c’è di più meraviglioso del veder sorgere dall’infinita moltitudine degli
uomini uno che da solo o con pochi possa fare quello che la natura ha concesso
a tutti? O di più piacevole a conoscere e sentire di un discorso abbellito e
adorno di saggi pensieri ed elevate espressioni? Che cosa è così imponente e
sublime quanto il fatto che le passioni del popolo, i sentimenti dei giudici,
l’austerità del Senato siano modificati dal discorso di un solo uomo? Che cosa
inoltre è così splendido, così nobile, così liberale quanto il portare aiuto ai
supplici, sollevare gli afflitti, dare salvezza agli uomini, liberarli dai
pericoli, salvarli dall’esilio? Che cosa è così necessario quanto l’avere
sempre pronta un’arma con cui tu possa e difendere te stesso e attaccare gli
altri senza tuo danno e vendicarti se provocato? Orbene per non parlare sempre
di foro, tribunali, rostri e Senato, che cosa ci può essere, per chi è libero
da impegni, di più piacevole e di più degno di una persona colta, di un
discorso arguto e bene informato su qualsiasi argomento?”
La
forza della parola (II)
“Noi ci distinguiamo dalle fiere
soprattutto per questo, perché sappiamo conversare ed esprimere con la parola i
nostri pensieri. Perciò chi non ammirerebbe e, a ragione, quest’arte, e non
riterrebbe suo dovere studiarla con tutte le sue forze, onde superare gli
stessi uomini in ciò in cui gli uomini si distinguono massimamente dalle
bestie? Ed ora passiamo al punto più importante della questione: quale altra
forza poté raccogliere in un unico luogo gli uomini dispersi, o portarli da una
vita rozza e selvatica a questo grado di civiltà, o, dopo che furono fondati
gli Stati, stabilire le leggi, i tribunali, il diritto? Non voglio passare in
rassegna tutti gli altri vantaggi che sono quasi infiniti. Per questo
condenserò in poche parole il mio pensiero: io affermo che dalla saggia
direzione di un perfetto oratore dipendono non solo il buon nome dell’oratore
stesso, ma anche la salvezza di moltissimi cittadini e dell’intera Nazione.
Perciò continuate, o giovani, la strada intrapresa e attendete con impegno ai
vostri studi, affinché possiate essere di onore a voi stessi, di utilità agli
amici e di giovamento allo Stato.”
(Cicerone, De
oratore, I, 30-34)
Probitas
e prudentia
Scrive Conte: “Il talento,
la tecnica della parola e del gesto e la conoscenza delle regole retoriche non
possono ritenersi bastevoli per la formazione dell’oratore: si richiede invece
una vasta formazione culturale. E’ la tesi di Crasso il quale lega strettamente
la formazione culturale (soprattutto filosofica, con privilegiamento della
filosofia morale) dell’oratore alla sua affidabilità etico/politica. La
versatilità dell’oratore, la sua capacità di sostenere il pro e il contra su
qualsiasi argomento, riuscendo sempre a convincere e a trascinare il proprio
uditorio, possono costituire un pericolo grave, qualora non vengano
controbilanciate dal correttivo di virtù che le mantengano ancorate al sistema
di valori tradizionali, in cui la “gente perbene” si riconosce. Crasso insiste
perché probitas e prudentia siano saldamente radicate nell’animo
di chi dovrà apprendere l’arte della parola: consegnarla a chi mancasse di tale
virtù equivarrebbe a mettere delle armi nelle mani di forsennati (III, 55).”
Forma
e contenuto
“L’arte del dire non ha modo di rifulgere se l’oratore non ha studiato profondamente i problemi che dovrà trattare. Una caratteristica di coloro che parlano bene è certamente questa: uno stile armonioso e forbito, che si distingue per la sua elegante fattura. Ma un tale stile, se non poggia sopra un argomento perfettamente conosciuto dall’oratore, inevitabilmente o non ha alcuna consistenza o è deriso da tutti. Quale stoltezza può eguagliare un vuoto fragore di parole, perfino le più scelte ed eleganti, che non siano sostenute da un pensiero e dalla perfetta conoscenza dell’argomento? Pertanto qualunque sia l’argomento, a qualunque arte o disciplina appartenga, purché l’abbia bene studiato, come fa per la causa del cliente, l’oratore lo esporrà con maggiore competenza ed eleganza dello stesso inventore e provetto intenditore. E se qualcuno sostiene che vi sono determinati argomenti e problemi propri degli oratori e una speciale scienza limitata ai tribunali, io ammetterò che il nostro genere di eloquenza si interessa con maggior frequenza di questi problemi; tuttavia in questo ristretto spazio ci sono moltissime nozioni, che non vengono insegnate e che non sono neanche conosciute dai cosiddetti retori.”
(Cicerone, De oratore, I, 48; 50-54)
Cicerone
vs. Sofisti
i Sofisti separano pensiero e
parola abolendo il concetto di una Verità universale ed elaborando il concetto
di una verità finita e arbitraria
i Sofisti rifiutano l’idea di una
politica basata sull’etica riconoscendo che i principi morali sono essi stessi
relativi e non possono pertanto fungere da criterio di giudizio
la dialettica per i Sofisti è una
“sovrascienza”, un sapere unificatore e universale
la parola è completamente
svincolata da un significato particolare: è lo strumento con cui chiunque,
conoscendone la tecnica, può operare la persuasione
Cicerone riconcilia retorica (quaestiones
finitae) e filosofia (quaestiones infinitae) nella figura
dell’oratore
Cicerone fonda l’intero suo
sistema su un concetto etico di Stato
la retorica per Cicerone è
anch’essa un sapere unificatore e universale
la parola non ha in sé la propria
ragion d’essere ma è legata al messaggio etico che deve trasmettere. La
persuasione è il fine ultimo ma può essere legittimamente operata solo
dall’uomo onesto che conosce e opera il bene
La
fine della retorica a Roma
Scrive Flocchini: “La vera
grande retorica a Roma ebbe, si può dire, la vita di una generazione e Cicerone
ne fu il punto di partenza e di arrivo insieme. Dopo di lui infatti la grande
oratoria morì soffocata dalle nuove strutture politiche in cui non c’era più
spazio per l’eloquenza, che solo dal foro e dalla vivacità della vita politica
aveva tratto alimento. L’eclissi del Senato e del foro come centri decisionali
tolse ogni credibilità alla tradizionale funzione dell’oratore e l’eloquenza
quindi, isterilita e devitalizzata, ripiegò nelle sale di recitazione secondo
la moda introdotta da Asinio Pollione. L’unità di retorica e moralità,
teorizzata e appassionatamente difesa da Cicerone, inevitabilmente si ruppe e
si ebbe il trionfo della retorica pura, delle regole, di una normativa sempre
più sofisticata e fine a se stessa.”
Le diverse letture della
decadenza
Il cambiamento fu evidente agli occhi di tutti coloro che vissero in quest’epoca, da Seneca il Vecchio a Petronio (che nei libri I e II del Satyricon inserisce un dibattito sulla decadenza dell’eloquenza), da Quintiliano a Tacito.
Del fenomeno furono date diverse
letture:
a)
stilistico - formale e mirante a evidenziare il decadimento dei costumi
(> Quintiliano)
b)
storico - politica e mirante a fornire una spiegazione più pragmatica
(> Tacito)
Quintiliano
e l’Institutio oratoria
Obiettivo: restaurazione
dell’eloquenza
Strumento: rigenerazione
del sistema didattico - educativo attraverso un programma complessivo di
formazione culturale e morale che il futuro oratore deve seguire
scrupolosamente dall’infanzia fino all’ingresso nella vita pubblica.
Presupposto: la decadenza
dell’eloquenza è dovuta alla rilassatezza dei costumi. Educando i futuri
oratori a un regime di onestà e di virtù si rinnoverà l’intera retorica.
Il
problema della retorica
Nel secondo libro,
Quintiliano si sofferma ad analizzare la natura, il fine e l’utilità della
retorica:
“Prima di tutto vediamo che cosa sia la
retorica che viene definita invero variamente, ma che presenta due questioni:
si discute infatti sulla qualità della cosa stessa o sul collegamento delle parole. La prima e
principale differenza delle opinioni è su questo punto: alcuni ritengono che
anche gli uomini disonesti si possano chiamare oratori, altri (dei quali
seguiamo il parere) vogliono che questo nome e l’arte della quale parliamo sia
da attribuirsi solo agli uomini onesti. […]
E’ frequentissima la definizione
che la retorica sia la forza della persuasione.”
Quintiliano dissente; egli non è
d’accordo neppure sull’assunto che il fine dell’oratore sia quello di “condurre
gli uomini col dire” a quello che egli vuole. Infatti ci sono altri che
persuadono con le parole o inducono gli uomini a ciò che vogliono, “come le
meretrici, gli adulatori, i seduttori. Invece l’oratore non persuade sempre,
cosicché talvolta non è il suo fine e talvolta gli è comune con quelli che sono
molto lontani dall’oratore”.
La
scienza del ben parlare
“Sembra che pensasse allo stesso modo di
coloro che ho detto anche Cornelio Celso, le cui parole sono: “L’oratore cerca
soltanto il verosimile”. Quindi, poco dopo: “Perché non la buona coscienza, ma
la vittoria della causa è il premio di colui che indice una causa”. Se queste
cose fossero vere, sarebbe da uomini assai disonesti fornire così dannosi
strumenti alla malvagità della natura degli uomini e giovare con precetti ad
essa. Ma essi vedano il motivo della loro opinione.
Quanto a noi che ci siamo
accinti a formare un perfetto oratore che soprattutto vogliamo che sia uomo
onesto, ritorniamo a coloro che su questa arte hanno una opinione migliore.
Ora alcuni hanno creduto che la retorica fosse la medesima cosa che la
politica: Cicerone la chiama una parte della scienza civile. Ora la scienza
civile equivale alla sapienza. Altri la chiamano anche una parte della
filosofia, tra costoro c’è Isocrate. Infatti, non solo abbraccia tutte le virtù
dell’oratore, ma comprende anche i costumi dell’oratore, non essendoci altro
che l’uomo onesto che possa parlare bene. […] La retorica è la scienza del
ben parlare, dal momento che, quando si è trovata la cosa migliore, chi
cerca altro vuole trovare cosa peggiore. Approvata questa definizione, è chiaro
anche quale sia il suo fine o quale sia il suo sommo ed ultimo obiettivo, che è
detto τέλος, al quale tutta l’arte tende. Infatti se essa è la scienza del
parlare bene, il suo fine e il suo supremo obiettivo è il parlar bene.”
L’uso
disonesto della retorica (I)
“Segue la questione se la
retorica sia utile. Infatti alcuni
sogliono scagliarsi con furia contro di essa e, quel che è più indegno, per
accusare l’eloquenza adoperano le forze dell’eloquenza. L’eloquenza sarebbe
quella che sottrae alle pene gli scellerati e coi suoi artifici fa condannare
talvolta gli onesti, porta al peggio ogni deliberazione e suscita non solo
torbidi e sedizioni popolari, ma anche guerre implacabili quando riesce a
sostenere le menzogne contro la verità. In questo modo, per la verità, né
saranno utili i comandanti di eserciti, né i magistrati, né la medicina, né
infine la stessa sapienza. Infatti non furono utili il capitano Flaminio e i
magistrati Gracchi, Saturnino, Glaucia; nelle medicine sono stati trovati
veleni e in quelli che usano male del nome di filosofi sono state scoperte
talvolta gravissime infamie. Non tocchiamo i cibi, spesso causarono infermità;
non entriamo mai nelle case, talvolta crollano sopra a coloro che vi abitano.
Non si fabbrichi spada per il soldato, l’assassino può valersi della medesima
arma.”
L’uso
disonesto della retorica (II)
“Per parte mia, ritengo che né i fondatori di
città sarebbero giunti diversamente a far sì che quella moltitudine di genti
vagabonde si unissero a formare dei popoli se non l’avessero convinta con una
sapiente arte oratoria; né i legislatori avrebbero ottenuto, senza una
eloquenza straordinaria, che gli uomini da soli si sottomettessero al giogo
delle leggi. Anzi, gli stessi precetti della morale, anche se per natura sono
onesti, hanno più forza a formare le menti quando un discorso splendido
illumina la bellezza degli argomenti. Perciò, anche se le armi dell’eloquenza
valgono in un senso e nell’altro opposto, tuttavia non è giusto ritenere cosa
cattiva ciò di cui si può fare buon uso.”
Dire
il falso in buona fede?
“Accusano la retorica anche di far uso di
difetti, cose che nessuna arte fa; perché essa dice il falso e muove le
passioni. Di queste due cose nessuna è turpe, quando muove da buone ragioni e
perciò non è un difetto. Infatti dire il falso talvolta è concesso anche al
sapiente e, se non si potrà indurre il giudice all’equità non diversamente
che col muovere le passioni, l’oratore dovrà necessariamente muoverle. Infatti,
ignoranti sono quelli che giudicano e spesso bisogna ingannarli proprio per
impedire loro di sbagliare. Perché se mi dessero giudici saggi, assemblee e
concili di saggi, se nessun potere avesse l’invidia, né il favore, né i
preconcetti ed i falsi testimoni, poco posto vi avrebbe l’eloquenza e
servirebbe solo a dilettare. Se invece gli animi degli ascoltatori sono
volubili e la verità è impedita da tanti ostacoli, si deve combattere con
l’artificio ed i mezzi che possono giovare. Infatti chi ha smarrito il
cammino diritto non può esservi ricondotto se non con un altro giro.”
Tacito
e il Dialogus de oratoribus
Nell’opera si confrontano
differenti punti di vista sull’oratoria ai tempi del principato:
1)
chi la ritiene superiore a quella degli antichi (> Apro)
2) chi ne lamenta la degenerazione (> Messalla e Materno).
Ma tra Messalla e Materno emerge
un contrasto sulle cause di tale degenerazione (contrasto che rispecchia
presumibilmente i dibattiti in corso al tempo di Tacito, allievo a sua volta di
Quintiliano insieme a Plinio il Giovane).
>
Messalla attribuisce le cause della decadenza dell’oratoria alla
corruzione dei costumi e all’impreparazione culturale dei nuovi oratori
>
Materno attribuisce le cause della decadenza dell’oratoria alla perdita
della libertà da parte dello stato, o meglio, alla raggiunta pacificazione di
quest’ultimo
Tacito
non vuole proporre soluzioni come fa invece Quintiliano: accetta l’esistenza
del principato come minore dei mali, e si limita ad analizzare storicamente la
situazione
L’impreparazione
dei nuovi oratori
Parla Messalla:
“Non mi si venga a dire che basta avere di
volta in volta delle semplici e generali informazioni sull’argomento. Grande è
la differenza tra l’usare ciò che è nostro e ciò che invece ci viene dato in
prestito, tra il possedere i concetti che si espongono e il prenderli invece da
altri; ed inoltre una cultura vasta è di ornamento in altre circostanze. E di
questo non solo la persona colta ed esperta, ma anche il popolo si accorge, e
con le sue lodi riconosce che colui che parla ha seriamente studiato, conosce
tutte le forme dell’eloquenza ed è insomma un vero oratore; quale anch’io
affermo che non possa esistere né mai essere esistito, se non scende nel foro
armato di tutte le scienze, come un combattente in campo, fornito di tutte le
armi. Gli avvocati dei nostri tempi tengono invece in così poco conto tutto
questo che nelle loro arringhe si scoprono i vergognosi difetti del linguaggio
volgare; ignorano le leggi, non conoscono le deliberazioni del senato, e perciò
si prendono gioco del diritto civile, hanno un profondo terrore per lo studio
della filosofia e i precetti dei filosofi.”
Oratoria
e democrazia
Parla Materno:
“In verità le continue adunanze, il diritto di
assalire i cittadini più potenti e il vanto che derivava dalle grandi
inimicizie – perché moltissimi oratori non risparmiavano neppure Scipione,
Silla o Pompeo, ed eccitati dall’astio nell’attaccare uomini tanto importanti
non rifuggivano dai modi più istrionici e volgari – quanto ardore suscitavano
negli ingegni, quale fiamma infondevano all’eloquenza! Non stiamo parlando di
un’arte oziosa e quieta, che ami l’onestà e la moderazione: la grande, sublime
eloquenza è alunna della licenza, che gli stolti chiamavano libertà, compagna
dei tumulti, incitatrice del popolo sfrenato, incapace di rispetto ed
obbedienza, fiera, tracotante e temeraria, quale non può allignare negli Stati
ben ordinati. Quali oratori ebbe mai Sparta, quali Creta? Ma quelle città
avevano disciplina e leggi quanto mai severe. Neppure tra i Macedoni, i
Persiani o altri popoli retti da governi stabili troviamo traccia di eloquenza.
Qualche oratore ebbe Rodi, moltissimi Atene, dove tutto poteva il popolo, tutto
gli ignoranti, tutto, per così dire, tutti. Anche la nostra città, finché vagò
sperduta e si lacerò nelle discordie e nelle lotte di parte, finché non ci
furono pace nel foro, concordia nel senato, moderazione nei tribunali, rispetto
verso i magistrati e limiti al loro potere, ebbe indubbiamente una eloquenza
più vigorosa, allo stesso modo che un campo non coltivato produce talvolta erbe
più rigogliose.
Tacito
e Cicerone
Tacito utilizza esattamente la
medesima espressione di Cicerone in De oratore 1, 30 ma traendone
conclusioni opposte: per Cicerone l’oratoria non può che svilupparsi
nella repubblica, perché essa è l’unico ordinamento in cui la libertà
d’espressione, il pluralismo, la possibilità di incidere concretamente sul
corso degli eventi siano oggettivamente garantiti; Tacito sostiene
invece che l’oratoria sia strettamente connessa all’ordinamento repubblicano
perché quest’ultimo si configura come una situazione di disordine e licenza, in
cui è lecito dire tutto e il contrario di tutto, perseguendo il proprio
interesse particolare, senza incorrere in alcuna sanzione.
Il pluralismo: una questione
aperta
Fino a quale punto può essere
garantita piena libertà di espressione all’individuo (soprattutto a figure di
riferimento come, ai nostri giorni, gli intellettuali e i giornalisti), senza
che questo significhi legittimare ogni sorta di giudizio su qualunque materia,
cosa che rischierebbe di generare soltanto confusione e disinformazione?
Garantire il pluralismo significa permettere anche che circolino notizie
manipolate scientemente, o si può concepire un qualche organo di controllo che
sottoponga a vaglio critico le diverse posizioni presentate, per evitare che,
soprattutto in una società massificata come la nostra in cui ogni notizia ha
immediata e vastissima risonanza, si faccia disinformazione più che
informazione? Ma entro quali limiti, in tal caso, sarebbe autorizzabile la sua
azione, considerando il rischio che un’operazione come la censura può
comportare? Chi può realmente discernere le opinioni “giuste” da quelle
“sbagliate”?
E’ insomma da garantire più
strenuamente la libertà di informare o il diritto di essere informati? E le due
cose sono davvero inconciliabili?