

![]()
La nascita di Roma
Un
giorno, su di un piccolo colle del Lazio che poi fu chiamato Palatino, un
gruppo di pastori fondò, secondo il rito etrusco, una piccola città. Già da
molti anni, fin da prima che giungessero gli Etruschi, questo popolo di
pastori, si erano stabiliti lì, in capanne disperse tra i cocuzzoli del
Palatino e, fino ad allora, erano vissuti ognuno per conto proprio, in gruppi
di poche famiglie imparentate fra loro, conducendo al pascolo le greggi e senza
preoccuparsi di darsi un ordine e una legge. Il luogo non era particolarmente
allettante: il grande fiume che scorreva ai piedi del colle, il Tevere, era
scuro di fango e le sue acque penetravano e ristagnavano nella vallata formando
paludi e acquitrini che di sera esalavano odori acuti. Tutt'intorno si
stendevano colli radi di alberi, silenziosi e austeri. Ma gli antichi amavano
abitare vicino alle acque, e quei luoghi, se non altro, erano poco ricercati e
permettevano una vita tranquilla. Infine, quei pastori avevano sentito il
bisogno di riunirsi, di non essere più dei poveri diavoli abbandonati a se
stessi e di creare un piccolo nucleo cittadino, come già avevano fatto altri
pastori del Lazio, i quali avevano creato piccole città e vivevano in buon
accordo fra loro. In questo periodo gli Etruschi erano giunti da poco in
Italia, forse da qualche decina d'anni. Siamo infatti verso la fine dell'VIII
secolo prima di Cristo. Ma i loro costumi si erano già diffusi fra le genti
della Toscana e del Lazio. Per questo i fondatori del nuovo villaggio dovettero
seguire più o meno il rito etrusco. Quel villaggio era Roma.
Roma prospera
Passa
il tempo. Gli abitanti di Roma vissero a lungo nella loro semplicità originaria
dedicandosi all'agricoltura e alla pastorizia. Poi trovarono una nuova fonte di
guadagno. Il fiume Tevere, che scorreva tortuoso lambendo il Palatino, sfociava
nel mare, non molto lontano dalla città. E là, presso la foce, le acque marine
si infiltravano nella pianura allagandola per vasti tratti. Sotto il sole,
quelle acque evaporavano lasciando sul fondo un bianco strato di sale, e il
sale era ricercato da tutte le cittadine del Lazio. I Romani pensarono di
andare a raccoglierlo e di farne commercio. Piccole carovane si diressero verso
le saline naturali della foce del Tevere e tornarono cariche di sacchi di sale
portati a spalla o messi sul dorso di asini e muli. Quel sale venne facilmente
smerciato in tutti i paesi del Lazio, anche a nord e ad oriente, presso altri
popoli non latini. Il borgo eretto sul colle Palatino cominciò così a
prosperare. Ma era una ricchezza modesta. In quei tempi, circa 650 anni prima
di Cristo , Roma era davvero un misero borgo, le sue abitazioni dovevano essere
in gran parte capanne rotonde formate da una palizzata sormontata da un alto
tetto di stoppie a cupola. Le più ricche erano probabilmente di tipo etrusco,
con fondamenta in muratura e l'edificio vero e proprio di legno.
Non
vi erano mura a difesa della città, ma solo una cinta sacra delimitata da bassi
muretti di pietra, il "pomerio", e su quella fascia di terra non era
permesso passare 1'aratro né far sorgere edifici. Questa cinta però si andava
via via allargando. Dopo breve tempo non delimitava più solo il Palatino ma si
estendeva verso nord-ovest, abbracciando anche un'altro colle, il Capitolino. E
poiché continuavano ad arrivare nuove genti, si poteva essere sicuri che si
sarebbe estesa ancora.
Esistenza Patriarcale
La
vita era quanto mai semplice. A capo della città c'era un re che non sdegnava
di andare a verificare personalmente se i suoi pastori curavano le greggi e le
mandrie e se i campi erano ben coltivati. All'occorrenza guidava lui stesso
l'aratro e, al tempo della raccolta, impugnava la falce al pari dei suoi
contadini. Gli anziani capi delle famiglie più antiche formavano il suo
consiglio, il cosiddetto consiglio dei vecchi, o senato (dal latino senex = anziano). Quando bisognava
prendere qualche decisione importante, i consiglieri si riunivano
nell'abitazione del re tornando dai campi. La figura paterna era molto
importante; tanto che anche oggi si usa la parola senatore (padre per gli antichi latini) per
indicare un'importante personaggio politico. Quando poi altre genti
sopravvennero, le antiche famiglie, per distinguersi da quei nuovi venuti, si
chiamarono "patrizie", ossia famiglie dei padri, discendenti dai
fondatori della città. E solo i patrizi potevano considerarsi veri cittadini di
Roma.
Divinità primitive e familiari
Gli
Etruschi avevano insegnato ai romani, più o meno direttamente, riti e culti
minuziosi. Questi ultimi, li accolsero ma, con la loro naturale serietà,
diedero a quei riti una maggiore importanza, un più profondo significato
religioso, e, soprattutto, un diverso carattere. Il fuoco purificatore ,che
ardeva sugli altari etruschi divenne, per i Romani, il simbolo di un focolare
familiare che era stato acceso da un antico padre fondatore della famiglia, e
che i discendenti dovevano mantenere acceso in eterno: fu insomma il simbolo di
un'autorità paterna. Vi erano poi le divinità tipicamente familiari, quelle più
amate dall'antico popolo romano: i Lari e i Penati, spiriti tutelari del
podere, della casa, della dispensa; "Vesta" la dea del focolare
domestico; piccole divinità agresti, custodi dei campi, espressione del
germoglio, della fioritura e della fruttificazione, rappresentate talora da un
semplice palo nel mezzo di un campo. Così nelle case di legno, e addirittura
nelle capanne di stoppie, si formava un profondo culto della famiglia e
diveniva la base delle leggi che governavano la città. Leggi tutte affidate
alla memoria degli anziani padri, siccome in questo periodo i Romani non
conoscevano ancora la scrittura.
I "pater familias"
Sotto
la severa direzione del padre di famiglia (in latino pater familias) la vita, nelle abitazioni, si svolge regolare e metodica.
Alla mattina ci si alza presto, le donne riordinano la casa e si dedicano al
loro tradizionale lavoro: filare e tessere; gli uomini vanno nei campi, a
sorvegliare i contadini e a lavorare loro stessi. Nei giorni di mercato è il
padre di famiglia che porta nel fangoso foro boario (la piazza del mercato dei
buoi) il bestiame destinato alla vendita, e fa gli acquisti necessari. I suoi
figli lo aiutano come fedeli servitori, perché il volere del padre è la prima
legge della casa. Anche se sono adulti e sposati, continuano a obbedirgli,
vivono nella sua casa con la loro moglie e i loro figli; solo alla sua morte
potranno considerarsi indipendenti. Fino a quel momento rimarranno al pari
della loro madre, membri secondari di una famiglia che obbedisce ciecamente ad
un unico capo. Il padre di famiglia inoltre, giudica, condanna e castiga. Un
figlio riottoso può essere mandato per mesi e anni a lavorare nei campi, con i
più umili servi, può essere venduto schiavo, può infine essere ucciso senza che
nessuna autorità intervenga a modificare quel che il padre ha deciso.
Le famiglie etrusche
Ma,
per avere un'idea più completa della vita a Roma in questo primo periodo, nel
quale la città è governata dai re, portiamoci più avanti nel tempo, circa 550
anni prima di Cristo, quando Roma diventa ormai una vera città con una
posizione preminente tra tutte le città del Lazio, le città latine. In quest'
epoca gli Etruschi si sono accorti che un popolo intraprendente e attivo sta
cercando di farsi strada e sono intervenuti per tagliargli la via. Essi
esercitano ormai una supremazia su tutto il territorio che si estende dall'Arno
(in Toscana) al Sele, (in Campania) e non sono disposti a permettere che in
questa zona si presentino dei concorrenti. A Roma, infatti, si è stabilita una
dinastia etrusca, quella della potente famiglia dei Tarquini, la quale domina
l'intera città. La tradizione parla di due re, Lucio Tarquinio Prisco (616-578
a.C.) quinto re di Roma, e Tarquinio il Superbo (534-510 a.C.) che sarebbe
stato l'ultimo dei sette re. Con ogni probabilità i re etruschi furono più di
due e ressero la città per buona parte del VI secolo, il periodo più felice
della storia etrusca. Ma a Roma la civiltà etrusca non ha potuto imporsi in
modo totale, perché i sovrani etruschi hanno avuto a che fare con un popolo
rude e ostinato, dotato di una forte personalità, legato alle proprie
tradizioni familiari, ,che non si è lasciato mai assoggettare completamente e
che, alla prima occasione saprà sottrarsi alla loro autorità. I vecchi capi
delle antiche famiglie continuano a formare il consiglio regio perché sono
troppo potenti per essere eliminati, mentre il patriziato romano tiene testa
alle nobili famiglie etrusche che cercano inutilmente di primeggiare nella
città. I Tarquini, evidentemente, sono giunti al potere solo accordandosi con
le famiglie patrizie di Roma, facendo concessioni e rinunciando ad un dominio
assoluto.
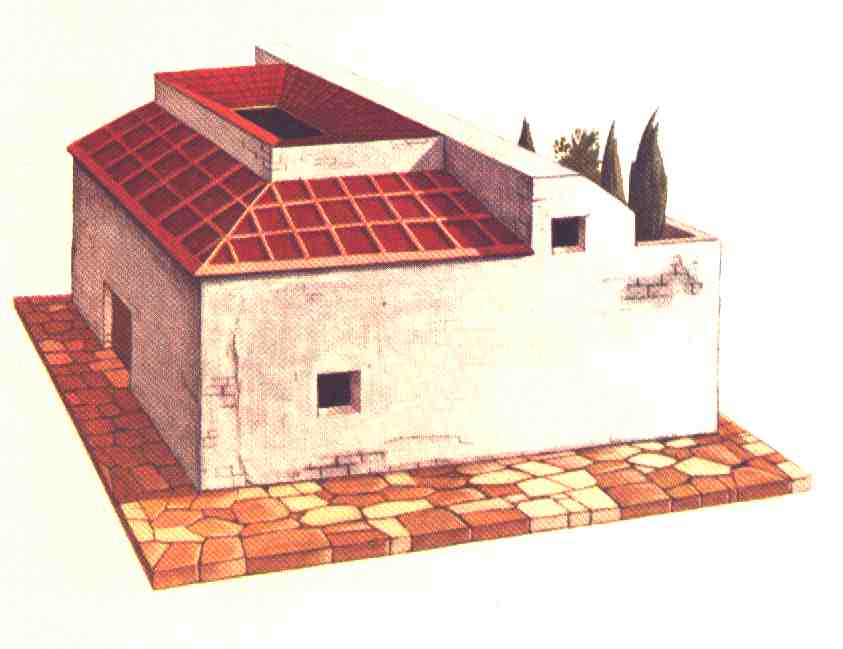
Le prime case romane
Tuttavia la solida organizzazione etrusca ha fatto fare alla città notevoli
progressi. Gli acquitrini che si stendevano ai piedi del Palatino sono stati
prosciugati e adesso al loro posto, c'è una grande piazza, quella che resterà
sempre la piazza cittadina per eccellenza, il Foro
romano. Le capanne sono scomparse e prevale ormai un tipo di abitazione
in muratura che si è diffuso un po' per tutta la Penisola. Questa casa è
costituita da un atrio coperto dal tetto solo tutt'in giro, con una apertura
nel centro che dà aria e luce. Da là, quando piove, l'acqua cade nel cortile ed
è raccolta da una vasca. Lungo le pareti dell'atrio si allineano stanze
generalmente piccole, illuminate solo dalla porta o da finestrelle quadrate.
Queste fungono da magazzini, da stanze per gli schiavi o per gli ospiti. Nella
parte posteriore della casa vi è invece l'appartamento del padrone, un'ampia
sala per i banchetti pubblici, un giardino e un piccolo sacrario dedicato alle
divinità famigliari
Una città silenziosa
La
città si è ingrandita. Una cinta di mura la circonda e comprende oltre al
Palatino, altri colli: il Capitolino, il Quirinale, il Viminale, l'Esquilino e
il Celio. Ma non è divenuta certo fastosa: le vie sono strette, irregolari e
sudicie come tutte le vie delle città antiche, difficilmente vi potrebbe
passare un carro. Le facciate delle case, di pietra grigia o di mattoni senza
intonaco con le loro rade finestrelle quadrate chiuse da telai su cui è tesa
una sottile pelle di pecora, formano uno scenario piuttosto triste. La piazza
principale è il Foro, col suo pavimento di terra battuta e ciuffi d'erba,
intorno ci sono case basse, qualche modesto tempio e, da un lato si trova il
severo e nudo salone che accoglie il senato ad ogni consiglio. La piazza non
sembra affatto lussuosa, bensì sembra piuttosto il mercato deserto di un
piccolo paese che un centro cittadino. Ma quel che soprattutto stupisce il visitatore
è il silenzio che domina quasi dappertutto. Roma è una città agricola dove la
maggior parte degli uomini lavora nelle campagne. Non vi sono praticamente
botteghe perché tutto si produce in casa. Le donne escono solo raramente. Così
che le vie sono quasi vuote. Passa a tratti qualche schiavo con la sua corta
tunica di cuoio e qualche pastore che attraversa la città con un piccolo
gregge. Solo nel Foro si vedono alcuni gruppi, ma quasi non si sentono voci:
sono patrizi ,che si raccolgono a discutere di problemi cittadini .
Patrizi e clienti
Il
costume dei Patrizi è di una semplicità estrema: si tratta di un drappo
rettangolare di lana appena imbiancata che, gettato sulla spalla sinistra,
avvolge il corpo passando sotto l'ascella destra e cade poi nuovamente sopra la
spalla sinistra. E' questa la forma più antica e semplice della toga romana. Con il solo braccio destro libero e il
sinistro coperto e occupato a trattenere i 1embi dell'abito, il Romano ha
necessariamente un atteggiamento rigido e solenne. Sotto la toga non porta
altro che un panno di lino attorno alle reni. Accanto a quei gruppi di severi
patrizi, si possono vedere persone più modeste, non tanto per il modo di
vestire, quanto per l'atteggiamento. Alcuni sono rannicchiati a terra, altri
seduti su di un sasso o su qualche gradino, e sembra che aspettino di essere
chiamati per compiere qualche incarico o qualche servigio. Sono i
"clienti", ossia schiavi liberati o gente venuta da fuori, che, pur
non essendo in condizioni di servitù non hanno diritti cittadini e vivono sotto
la protezione di un patrono patrizio. Ogni mattina si recano alla sua casa e
attendono nell'atrio che il padrone si mostri, appena lo vedono gli vanno
incontro portando la sua mano alla bocca (in latino ad orem, da cui "adorare") in segno di rispettoso saluto
e si mettono poi ai suoi ordini. Lo seguono dovunque vada, lo applaudono se
parla in pubblico, eseguono tutti i servizi che lui richiede, in compenso sono
protetti da lui e molto spesso ricevono da lui un cestino pieno di cibo.
Raggruppati presso il circolo dei loro patroni, questi poveri diavoli parlano
poco e a bassa voce per rispetto. Così anche nella grande piazza regna un
silenzio appena interrotto da qualche parola detta a voce più alta ogni tanto.
Il quartiere plebeo
Se
invece ci portiamo su di un colle che rimane ancora fuori della città,
l'Aventino, ci si presenta tutt'altro spettacolo. Si ritrovano le antiche
capanne accanto a qualche piccola casa in muratura, la gente passa numerosa per
le vie sudicie e tetre, si sente dappertutto un vocio confuso mentre ragazzi
nudi corrono e gridano giocando o litigando. Vi sono piccoli mercanti seduti
per terra con povere merci , attorno donne che contrattano, artigiani che
lavorano all'aperto unendo alle voci alte il rumore dei loro attrezzi. Siamo
nel quartiere dei "plebei" ossia di coloro, che sono arrivati a poco
a poco nella città dai paesi vicini e, pur essendo stati accolti, non sono
divenuti veri cittadini romani, non hanno diritti, non possono ricoprire cariche
né arruolarsi nell'esercito. Per partecipare più da vicino alla vita cittadina
dovrebbero cercarsi un patrono e divenire clienti; e molti di loro lo sono
infatti diventati. Ma non mancano coloro che preferiscono una sistemazione più
misera ma indipendente e vivono di ripieghi, esercitando piccoli commerci o
piccoli artigianati. Alcuni di loro sono riusciti in questo modo a raggiungere
una certa agiatezza. Possiedono greggi e se ne servono, più che per trarne lana
e carne come i patrizi, per trafficare e fare scambi vantaggiosi. Questo perché
nel periodo regio, Roma non possiede ancora la moneta (che i Greci hanno da
circa un secolo) e il bestiame minuto (in latino pecus, da cui viene l'italiano "pecunia", denaro) serve
comunemente per i pagamenti.
Due città
Questa
era la città di Roma nel periodo dei sette re. Sono quasi due città distinte:
da un lato la città patrizia, diretta
sostanzialmente dai padri di famiglia sotto la guida di un re padre che si
consiglia con i padri più anziani e onorati, il senato. Dall'altra la città plebea. Quella patrizia vive secondo antiche
tradizioni rigorosamente rispettate, è austera, taciturna, solenne nella sua
semplicità, minuziosamente organizzata. Le famiglie imparentate fra loro
costituiscono una gens; le
"genti" si raggruppano in alleanze formando delle "curie";
le curie si raggruppano infine in tre grandi "tribù". Secondo la
tradizione, i fondatori dell'antica Roma provenivano infatti da tre popoli : i
Latini, i Sabini, e gli Etruschi. La città plebea vive invece senza tradizioni
e con scarse regole, si guadagna l'esistenza giorno per giorno, è chiassosa,
avventurosa, pronta a sfruttare qualunque occasione. Gli abitanti della città
patrizia rivelano nel nome la loro origine: dopo un "prenome" loro
proprio, portano il "nome" della gente cui appartengono appena
modificato dalla terminazione nobile in ius
e vi aggiungono il "cognome" della loro famiglia. I plebei si
accontentano di un nome qualsiasi o, tutt'al più, vi pongono un prenome. I
patrizi, infine, prendono parte alla vita pubblica: il re, infatti, non ha
potere assoluto, le sue decisioni devono essere approvate dal popolo di Roma,
cioè dai patrizi, riuniti per curie nei cosiddetti comizi curiati. I plebei,
invece devono accettare le decisioni prese dai patrizi e obbedire alle loro
leggi senza avere alcun diritto. In una città così profondamente divisa era
inevitabile che, col tempo, sorgessero discordie. I plebei non potevano restare
a lungo nella loro condizione di inferiorità, le due classi dovevano
necessariamente fondersi. I patrizi avrebbero finito col fare partecipare i
plebei alle loro tradizioni, al loro orgoglio di cittadini romani, ai loro
diritti; e i plebei avrebbero comunicato ai patrizi il loro spirito di
iniziativa e di avventura, la loro vitalità. In conseguenza di questa fusione
il costume romano cambierà notevolmente, soprattutto quando il dominio etrusco
si sarà indebolito, i re etruschi saranno banditi dalla città e Roma si
trasformerà in Repubblica, fatti indubbiamente storici, ma che si presentano,
come tutto quanto accadeva in quelle epoche, avvolti in un'aura di leggenda.