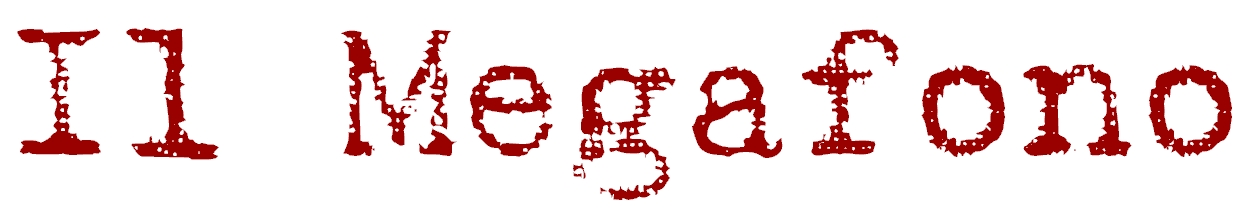 |
|
|
|
|||
|
di Sara Miglietti Ci sarà bene una ragione se mille
persone, in un gelido lunedì sera milanese, si accalcano alle porte del Teatro
Franco Parenti per assistere all' "evento del mese" – la conferenza
tenuta da Giovanni Reale, Franco Volpi, Giulio Giorello, Emanuele Severino,
Massimo Cacciari e Gianni Vattimo in occasione della riedizione degli
"Holzwege" di Martin Heidegger. E non credo che tale ragione possa
essere semplicemente cercata in un improvviso raptus accademico infuriante fra
i nostri concittadini. Tra il pubblico (qualche centinaio di fortunati si è
aggiudicato le comode seggiole del teatro; molti si sono accomodati sul
pavimento, sulle scale, sui ballatoi, dietro le quinte… appesi al sipario…;
altri ancora sono stati costretti a seguire la conferenza nell'atrio del
teatro, attraverso altoparlanti) non si trovavano soltanto metà del corpo
docenti di filosofia del Berchet, studenti universitari, esegeti e appassionati
del grande filosofo tedesco, ma soprattutto gente comune, mossa da umana
curiosità, da un interesse che prescindeva una conoscenza approfondita della
materia. Presumo che se ne possa trarre questa conclusione: evidentemente il
popolo milanese, una volta rintracciato nel tema della conferenza ("La
terra del tramonto e della globalizzazione") un interrogativo assillante
del nostro tempo, ha creduto che una degna risposta ad esso potesse giungere
proprio dalla filosofia, e in particolare da un pensatore chiave del XX secolo,
come è senza dubbio Heidegger. L'ansia di certezze e di punti di riferimento
stavolta pare essersi tradotta non in un tuffo collettivo nel new age,
bensì nella cara, vecchia filosofia, che da anni sembrava aver abdicato alla
propria missione salvifica, per richiudersi in speculazioni sempre più
specifiche, sempre più tecniche, sempre più lontane (almeno apparentemente)
dalla nostra vita quotidiana. È stato proprio questo annoso pregiudizio sulla
"distanza" della filosofia dall'average man a relegare negli
ultimi anni la filosofia stessa in una torre d'avorio del sapere,
allontanandola sempre di più dal pubblico. Sulla scorta dell'esperienza
personale, garantisco che esprimere i propri entusiasmi filosofici di fronte a
un campione di umanità ben assortita genera. Il più delle volte, un boato di
disapprovazione e perplessità. Consacrare una vita intera a studi in questo
campo si configura, agli occhi di molti, come una sterile chiusura alla vita
reale: un presuntuoso ripiegarsi a conchiglia sulla propria cultura. Pochi conoscono o si curano di conoscere
i profondi, profondissimi legami che, al contrario, la filosofia intrattiene
con la vita attiva, tanto a cuore all'uomo moderno. Pochi si lasciano
convincere da questa incontestabile verità: l'uomo moderno esiste forse solo grazie
a, e non nonostante, la ricerca e la speculazione filosofica. Da
sempre, la filosofia si è proposta come momento chiave nell'evoluzione del
pensiero: fu la prima ad abbattere le barriere del "sonno dogmatico"
– come lo definiva Kant; la prima a offrire, come contropartita, una valida pars
construens, fondata sulla valorizzazione del ruolo umano nel mondo, e sulla
assunzione a "misura di tutte le cose" (Protagora). Chi contrappone la scienza – quale vero
motore del progresso – alla filosofia – annoverata tra i saperi
"umanistici" e, in questo senso, tarpata di tutta la sua ricchezza e
complessità (ricordiamo en passant che "filosofia" significa
letteralmente "amore della sapienza", e non vi sono paletti posti ai
suoi ambiti di ricerca) – probabilmente ignora quanto numerosi e decisivi siano
stati gli apporti forniti dalla filosofia alla scienza stessa. Ecco che,
tornando ad Heidegger, i suoi rapporti fecondi e intensi con Heisenberg (premio
Nobel nel '32 e primo a formulare, nell'ambito della meccanica ondulatoria, il
principio d'indeterminazione) ci consentono di mettere in luce l'intima
connessione tra scienza e filosofia, e di comprendere come i due campi siano
spesso complanari, di come interagiscano influenzandosi reciprocamente. Nel
corso della conferenza, tale posizione è stata difesa con energia da Giulio
Giorello, studioso nel ramo della filosofia della scienza, e propugnatore di
una tesi, secondo cui la matematica sarebbe "l'unica globalizzazione
davvero riuscita". Il successo della manifestazione al
Teatro Parenti mi incoraggia a pensare che sia tornato un tempo in cui l'uomo
voglia cercare nella filosofia l'antidoto al proprio "vuoto
spirituale". Quel sapere erroneamente sentito come lontano e
auto-referenziale si sta forse "calando nuovamente tra la gente",
dimostrandosi in grado di costruire una bussola ideale in un'epoca di diffuso
disorientamento. E allora è il caso di dirlo: l'uomo ha chiamato e stavolta,
per fortuna, la filosofia si è fatta trovare sveglia e aperta ai suoi problemi.
|
||||||||||||||||||||||||
| powered
by Liceo
Berchet
|
web
editor Namo
Web Editor 5
|
web
design and engineer Nu
Midia Group
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||