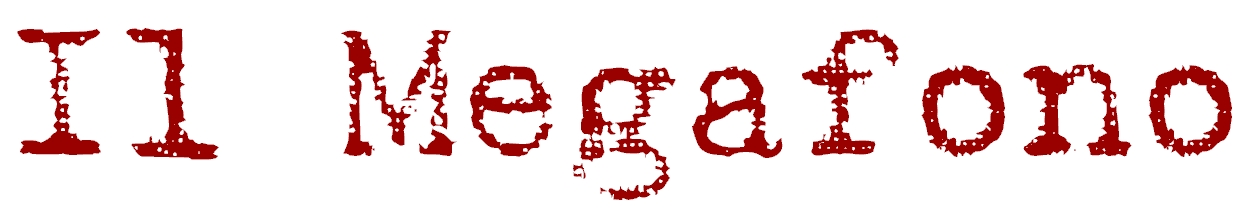 |
|
|
|
|||
|
dal nostro inviato dagli U.S.A. Rocco Polin Negli ultimi anni, qui in America, va molto di moda paragonare gli Stati Uniti all’impero romano. Superato il primo momento di fastidio per “questi americani arroganti che credono di dominare il mondo” non si può fare a meno di riconoscere che il mondo gli americani lo dominano davvero e che non esiste nella storia, se non appunto durante l’impero romano, un altro caso in cui un popolo si trovasse a esercitare una così completa egemonia economica, militare, politica e culturale. Non è forse alla pax romana che aspira il presidente Bush quando parla del suo nuovo ordine mondiale? Un mondo di pace perché dominato da una sola potenza egemone, un mondo in cui i patrizi non solo americani, ma anche quei fortunati provinciali cui è stata concessa la cittadinanza, possano vivere nel lusso, mentre barbari e plebei sono tenuti ai margini... c’è persino una vecchia Europa, divisa e debole politicamente, ma che mantiene una certa autorità culturale, pronta a fare la parte della Grecia. Piu’ ci penso, piu’ mi convinco che la metafora è azzeccata. Ultimamente però alcuni giornalisti ed intellettuali americani hanno avanzato l’ipotesi che questo apice così simile a quello dell’impero romano non sia altro che l’inizio della decadenza. Effettivamente, negli ultimi anni ci sono stati molti segnali che potrebbero far pensare ad una crisi imminente del sistema americano-occidentale: la recessione economica, il movimento no-global, l’11 Settembre, gli scandali finanziari....il solo fatto che da ormai due mesi l’amministrazione Bush stia cercando di rovesciare Saddam e, nonostante i molti compromessi, non sia ancora riuscita a venire a capo della comunità internazionale e del Consiglio di Sicurezza è, a mio parere, sorprendente. Per spiegare le ragioni della crisi bisogna per un attimo provare a capire su cosa si basa il sistema americano: esso si basa sul consumo. Da quando sono qui, sono veramente impressionato dalla quantità di cose completamente inutili acquistate quotidianamente dall’americano medio. L’italiano, bene o male, deve avere qualche retaggio di un passato in cui eravamo terra di contadini e di emigranti o delle privazioni subite durante la guerra, un retaggio che ci impedisce di comprare cose di cui non solo prima di entrare in negozio non sentivamo la necessità, ma di cui non sospettavamo nemmeno l’esistenza. La mia mamma-ospitante ha ammesso di non conoscere l’utilizzo di almeno il 40% dei suoi utensili da cucina, mi ha detto ridendo di averli comprati solo per la gioia dell’acquisto. Secondo la mentalità americana se uno ha i soldi e il desiderio, non c’è nulla di eticamente sbagliato nel comprare qualcosa, pur riconoscendone l’assoluta inutilità. L’idea che l’acquisto inutile sia moralmente sbagliato nei confronti di chi non ha neanche lo stretto indispensabile per vivere è assolutamente estranea a questa “cultura”. Come il bambino sgridato dalla mamma perché non mangia la minestra mentre nel mondo c’è chi muore di fame, l’americano rileva che in Africa moriranno di fame anche se lui mangia tutta la sua minestra. Il fatto che la povertà del sud del mondo sia legata al consumismo degli occidentali è assolutamente incomprensibile per i cittadini di questo paese. La propensione all’acquisto si basa su quella che gli economisti definiscono “fiducia del consumatore”. É ovvio che, se una persona ha paura che i terroristi gli piombino in casa, è meno propensa ad acquistare 200 dollari di decorazioni natalizie (media nazionale che ogni cittadino americano, neonati compresi, spende ogni anno per gli addobbi) e questo vuol dire che la fabbrica che le produce dovrà licenziare gli operai, che il camionista che le trasporta non avrà lavoro, che il negozio che le vende farà meno soldi e che in breve tutta l’economia americana ne risentirà pesantemente. Una volta stabilito che l’intero sistema americano si basa sulla fiducia del consumatore, possiamo capire perché gli ultimi avvenimenti potrebbero avere ripercussioni pesanti sugli Stati Uniti. Cominciamo dagli scandali che hanno colpito numerosi manager delle piu’ gradi industrie americane (prima fra tutte la Enron): Adam Smith, nella sua celeberrima opera La ricchezza delle nazioni, sosteneva che il pane non ce lo dobbiamo aspettare dalla benevolenza del fornaio, ma dal mutuo vantaggio del fornaio e dei suoi clienti, l’uno a vendere gli altri ad acquistare il prodotto. Così veniva valorizzato il proficuo incontro di due sani egoismi. Questi egoismi però riposavano su alcuni valori condivisi: era implicito, ad esempio che il fornaio non avrebbe avvelenato il pane. Alla Enron il pane lo hanno avvelenato e ora sembra pure che non ne pagheranno le conseguenze. Il consumatore americano comincia a pensare che forse, se si lascia che l’economia e la società vengano regolate solo dalla lotta tra egoismi senza un'autorità superiore, non egoista, che stabilisca delle regole, l’egoista più ricco e potente frega sempre l’egoista più povero e disarmato. Oltre al sospetto che lo Stato non sia poi una malvagia invenzione dei comunisti, gli americani cominciano a rendersi conto che questo sistema mondiale, basato sullo sfruttamento dei paesi poveri, potrebbe alla lunga causare qualche problema. Ovviamente non c’è una coscienza precisa di perché il sistema è sbagliato; c’è solo una confusa idea che qualcosa non va. Perché ci odiano? Questa è la domanda che più spesso si sente fare da sgomenti americani. A volte la risposta è: “Perché sono cattivi”, altre volte si insinua il sospetto che qualcosa di sbagliato l’America deve pur aver fatto. Ho rilevato, io, ma anche i ben più autorevoli commentatori del NY Times, che, forse per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale (se sorvoliamo la parentesi seguita alla guerra del Vietnam), gli americani mostrano una certa freddezza nei confronti della possibilità di una nuova guerra. L’americano medio pensa: “Sia che gli arabi abbiano ragione a criticare i nostri interventi sia che lo facciano solo perché sono cattivi, per quale ragione dobbiamo aumentare il loro risentimento, andando a rompere le scatole ad un tipo (Saddam) che, magari avrà pure massacrato un sacco di Curdi, ma a noi non ha fatto nulla?” Bisogna ammettere che il ragionamento non fa una piega. Bush è prigioniero delle sue stesse menzogne: se dicesse che vuole attaccare l’Iraq per il petrolio magari avrebbe un seguito, ma siccome si ostina a dire di farlo per ideali di pace e giustizia, l’americano gli risponde che se ne frega della pace e della giustizia, gli basta che non buttino giù altre torri. La mia impressione, di sedicenne italiano relegato nei sobborghi di St. Louis, Missouri, è che effettivamente il sistema sia in crisi. Sul fronte economico il calo di fiducia del consumatore sta recando gravi danni all’economia, su quello “politico” si sta facendo strada l’impressione che lo Stato debba fissare regole più severe in campo soprattutto economico (il che non ha nulla a che vedere con il voto democratico piuttosto che repubblicano), sul fronte della politica estera sta nascendo l’impressione che qualcosa non va. Le manifestazioni dei no global, il numero di palestinesi che si fanno kamikaze, l’odio che in molta parte del mondo è riservato ai soldati statunitensi… tutti questi fattori contribuiscono a creare quell’impressione, vaga quanto possibilmente gravida di conseguenze, che la politica estera americana degli ultimi decenni sia stata, nonostante le buone intenzioni del popolo americano, completamente sbagliata. Quando dico buone intenzioni, ovviamente non mi riferisco alle lobby delle armi o del petrolio che non hanno fatto altro che fare i propri interessi sulla pelle dei popoli del terzo mondo, ma ai genuini sentimenti di questo popolo che per anni ha pagato la benzina il doppio del dovuto per sostenere guerre e politiche che credeva finalizzate alla costruzione di un mondo di pace, libertà e democrazia.
|
||||||||||||||||||||||||
| powered
by Liceo
Berchet
|
web
editor Namo
Web Editor 5
|
web
design and engineer Nu
Midia Group
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||