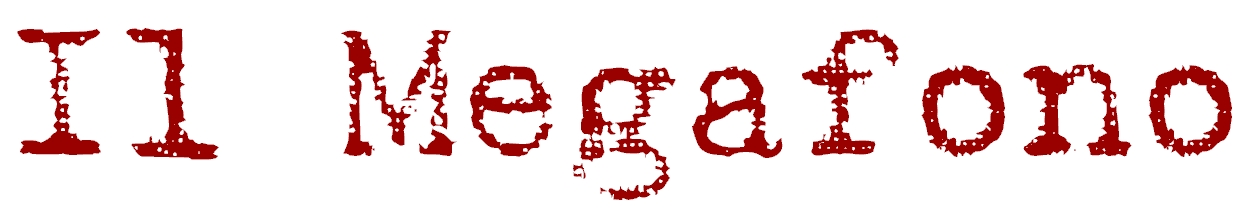 |
|
|
|
|||
|
a cura di Sara Miglietti La sfida, lanciata nel Siglo de oro da Calderón de la Barca, non è di poco conto. Dove passa il confine tra apparenza e realtà? Si può essere infallibilmente convinti che la realtà stessa sia quella da noi vissuta nella veglia e non quella in cui ci immergiamo calandoci in un sogno? Basta insomma quell’autocoscienza che ci pervade al risveglio – la consapevolezza di essere “tornati” a una vita più vera del sogno, reame dell’apparenza – a dare una svolta al problema? Nei due trattati “Sul sogno” e “Sulla divinazione nel sonno” Aristotele si pronuncia sulla natura del sogno: esso è “una sorta di immagine che compare nel sonno”. Tale immagine, naturalmente, può non avere alcun riscontro nella vita reale, essere cioè letteralmente insensata, non derivata dall’intuizione sensibile: come Epicuro ha ben presente il concetto di “centauro” – che pure non esiste - a partire dalla sintesi artificiale dell’uomo e del cavallo, così alla mente sognante appaiono immagini composte sì da elementi reali, ma frutto nel complesso di connessioni illecite. E’ qualcosa di ben noto a chiunque si sia accorto, analizzando i propri sogni, di come essi nascano spesso dal rimescolamento irrazionale delle esperienze compiute nella veglia. Ma resta aperta la questione da cui siamo partiti. Qual è la vita vera: il sogno o la veglia? Aristotele non ha dubbi: l’unico criterio inconfutabile per stabilirlo è rendersi conto, nel corso del sogno, di stare appunto sognando. Immancabilmente “qualcosa” ci avvertirà che le immagini che si presentano ai nostri occhi sono figlie di collegamenti infondati della mente, e non frutto del lavoro dei sensi. Ma scoprirsi sognanti nel bel mezzo del sogno non è affatto impresa facile! E al di là delle difficoltà “tecniche” – dirà Cartesio un paio di millenni più tardi – tale procedimento è oltre tutto un mero circolo vizioso che non fornisce garanzie della propria validità. L’inventor del dubbio come metodo si concentra ancora una volta sul fondamento delle nostre certezze: la consapevolezza di cui si fa scudo Aristotele non è sufficiente in se stessa a garantirmi che le cose stiano proprio come mi appaiono in tutta la loro evidenza (cioè che la veglia corrisponda alla vita reale). Perfino questa consapevolezza deve essere convalidata da qualcosa: in caso contrario nulla vieta che essa stessa sia un sogno! Questa è chiaramente una conclusione paradossale, cui Cartesio approda applicando rigorosamente il dubbio iperbolico nel corso dello smantellamento sistematico dei metodi conoscitivi del suo tempo. Ma è ugualmente significativo della complessità del dilemma il fatto che il francese riesca a porvi rimedio solo appellandosi all’esistenza di Dio, unico garante della verità delle conoscenze umane. Due secoli dopo, nel 1819 (la data non è irrilevante; ci troviamo nel cuore del Romanticismo europeo, con tutta la sua straordinaria rivalutazione dell’irrazionale e del nascosto. Un artista come Füssli, ad esempio, incentra spesso i suoi soggetti sul sogno; “The rhyme of the ancient mariner”, “Frankenstein” e “Kubla Khan” sono nati essi stessi da sogni dei loro autori), il filosofo tedesco Schopenhauer definisce l’esperienza onirica come un momento di vita psichica discontinua; la veglia è invece una fase cosciente caratterizzata fondamentalmente dalla continuità. Ciò significa in sostanza che al risveglio ci rendiamo conto di riprendere la stessa vita interrotta dal sonno: ciò non accade, viceversa, rituffandoci nei nostri sogni, il che dimostrerebbe chiaramente la loro natura fittizia e inconsapevole. Sono di estremo interesse alcune scoperte scientifiche dell’inizio del secolo scorso. Un individuo nato cieco, ad esempio, ha una vita onirica legata unicamente alla sfera auditiva; al contrario un uomo vedente sogna appunto in maniera prevalentemente visiva. E’ l’ennesima riprova di come nel sogno non solo emergano le pulsioni più remote e inaccessibili dell’io (ciò che, affermato nel 1900 da Freud ne “L’interpretazione dei sogni”, pone l’accento sulla dimensione interiore della produzione onirica); ma di come la sfera del sogno sia condizionata in maniera decisiva dagli stimoli sensoriali. Ricordiamoci di un Dante che, nel IX canto del Purgatorio, si ritrova alle porte del regno dell’espiazione, pur senza aver mosso un passo: è santa Lucia a trasportarvelo, immerso in un sogno: e cosa sogna Dante addormentato, nella sua inconsapevole ascesa? D’essere appunto condotto in volo da un’aquila fino alla sfera del fuoco: è la percezione del suo movimento reale a condizionare il sogno! Simile è l’esempio del grottesco sogno di don Rodrigo nel XXIII capitolo dei Promessi Sposi, dove il nobilotto interpreta come un fastidio prodotto dall’elsa della propria spada quel dolore invece reale, che è sintomo della sua malattia. Quella del drammaturgo spagnolo non è l’unica grande sfida tesa all’immaginazione umana. Vi lascio con un enigma di Coleridge, citato da Borges in “Altre inquisizioni”: “Se un uomo attraversasse il Paradiso in sogno, e gli dessero un fiore come prova d’esser stato lì, e se destandosi si trovasse in mano quel fiore… allora?”
|
||||||||||||||||||||||||
| powered
by Liceo
Berchet
|
web
editor Namo
Web Editor 5
|
web
design and engineer Nu
Midia Group
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||